| Segnala il documento | Stampa | ||||
| Dove stanno i ricordi nel cervello? Gli esperimenti di Penfield |
| di Andrea Velardi |
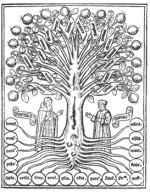
“Uneasy philosophers seem to be calling downward through the clouds:... "Can you prove yet ... that consciousness and nerve activity are the same thing?”
Wilder Penfield
1.1 La permanenza dei ricordi nella mente umana.
Qualcuno resterà stupito se, all’inizio di un saggio sul mantenimento dei ricordi, si afferma che la memoria non esisterebbe se non esistesse la capacità di dimenticare. Argomenterò tra breve l’importanza di questa tesi e il suo legame profondo con il subject principale. Per adesso vorrei far notare come la sorpresa nasce dal fatto che percepiamo l’intelligenza e la memoria come dei grandi contenitori. Ad esempio tutti pensiamo che il nostro cervello sia un enorme magazzino la cui funzione è di essere riempito il più possibile di informazioni. Questa idea si basa sul principio che se c’è un contenitore, questo va riempito nella sua totalità. L’idea di mente e di memoria come contenitore da riempire si è rafforzata con l’avvento delle tecnologie informatiche. Non a caso il computer è divenuto il contenitore di informazioni per antonomasia. Uno degli scopi fondamentali di questa macchina è proprio quello di raccogliere, archiviare e conservare dati. La maggior parte degli utenti non riflette sul fatto che questa memoria è limitata. Apre nuovi file, salva testi, musiche e immagini senza pensare più di tanto al limite di memoria dell’hard disk. Solo quando qualcosa si inceppa e il computer è lento, allora siamo spinti ad estenderne la memoria aggiungendo la RAM. In questo caso sono i problemi di usability che ci spingono a prendere coscienza del fatto che la memoria del computer non è illimitata.
E’ interessante notare che, nel caso della memoria umana, la metafora del contenitore diventa più complessa. Infatti con la parola memoria noi non intendiamo soltanto il contenitore, il deposito o il magazzino delle informazioni, ma anche e soprattutto la straordinaria messe di dati che sono raccolti dentro quel contenitore. La memoria è sia il magazzino, sia quello che è immagazzinato; è sia il contenitore, che il database. Gli informatici cercano di trovare modi per espandere la memoria (nel senso del contenitore). Invece in noi soggetti umani la ricerca dell’espansione e dell’arricchimento della memoria coincide con la maggiore complessità e organizzazione della codifica delle informazioni. Nel nostro cervello i due processi sono interdipendenti e a volte coincidono.
Lo stereotipo per cui la memoria è una continua somma di informazioni resta forte a causa dell’imperversare dei computer e di quel grande database ipertestuale che è Internet. L’idea informatica di memoria ha mantenuto vivi molti malintesi sulla natura della memoria umana e una visione semplicistica del suo funzionamento. Per uscire fuori da certi stereotipi del senso comune potrei elencare una serie di differenze tra la memoria del computer e la memoria del cervello. Se la prima è precisa, la seconda è imprecisa; se la prima non è selettiva ed è espandibile, la seconda è altamente selettiva ma strutturalmente vincolata. L’opposizione che ci interessa discutere in questo contributo è quella tra la memoria del computer che non sa cosa è l’oblio (se non quello totale e irreversibile cui assistiamo quando un virus ci distrugga fatalmente l’hard disk) e la memoria umana, che non solo conosce l’oblio ma che non può sussistere senza l’oblio.
A dare un fondamento scientifico alla idea del potenziamento e dell’arricchimento della memoria è stata la teoria di Donald Hebb (1946) e le ricerche di Kandel sul meccanismo del potenziamento a lungo termine.
Di recente un gruppo di studiosi di Berlino tra cui Gina Turrigiano (2004) hanno riesaminato l’idea di potenziamento e di facilitazione pervenendo ad un modello più vicino alla dimensione umana del ricordo in cui un ruolo chiave è rivestito dalla omeostasi o equilibrio cognitivi. Questo equilibrio è fortemente legato all’assunto enunciato all’inizio. Se la memoria fosse regolata solo dalla legge di Hebb il nostro cervello non farebbe che incamerare dati in modo esponenziale fino ad esplodere in una sorta di cortocircuito bulimico. Una idea più matura del potenziamento è che al principio di facilitazione ed eccitazione secondo cui i neuroni sono spinti a creare sinapsi (legami tra le terminazioni dei neuroni) con maggiore velocità e intensità, occorre contrapporre un principio di inibizione e di freno di questa facilitazione. Gli esperimenti e il modello di Turrigiano, in piena sintonia con le moderne ipotesi del connessionismo, conferma il nostro assunto secondo cui non potrebbe esistere la memoria se non esistesse l’oblio, la dimenticanza.
Un’altra conferma proviene dalle descrizioni di casi di pazienti dotati di una memoria straordinaria, i cosiddetti mnemonisti. Il più famoso è il dott. Seresevskij, giornalista affetto da mnemonismo patologico, descritto da Lurija (1968) nello splendido libro Viaggio nella mente di un uomo che non dimenticava nulla.
Se non dimenticassimo finiremmo tutti come il mnemonista di Lurija in preda ad una memoria talmente affollata di ricordi, da creare un duplicato caleidoscopico e labirintico della realtà, impossibile da governare. Un doppione così intricato, folto, ridondante e linkato, da non permettere più di ricordare, con ordine e pertinenza, i fatti, le persone e gli oggetti della vita reale. Come dimostra una attenta analisi del caso di Seresevskij quello che i linguisti chiamano pertinenza semantica dipende in larga misura dalla pertinenza cognitiva che i nostri ricordi posseggono con le associazioni emerse dal senso intersoggettivo e personale delle parole e dall’equilibrio (omeostasi) costante che la nostra mente mantiene fra gli aspetti soggettivi, interiori e autobiografici della nostra memoria episodica e gli aspetti pubblici, esterni, intersoggettivi della memoria semantica. Dentro questo equilibrio i ricordi associati alle parole mantengono una relazione stringente con il significato condiviso delle parole stesse e tengono salda quella funzione di realtà di cui parla Janet (1889, 1907), ovvero la relazione adeguata e pertinente fra l’ ontologia delle relazioni che intercorrono fra gli oggetti e gli eventi presenti nel mondo e il loro rispecchiamento adeguato all’interno del linguaggio e della memoria.
Avremo modo di approfondire in altre sedi il problema della interdipendenza fra oblio e memoria. In questa sede vogliamo domandarci perchè dimentichiamo e se davvero il nostro cervello dimentica completamente i ricordi cancellandoli completamente. E’ proprio vero che ci sono delle esperienze del nostro passato che sono andate irrimediabilmente perdute? Che si sono volatilizzati come i testi dei filosofi antichi distrutti nel misterioso incendio della biblioteca di Alessandria? Oppure qualcosa si salva come la scatola nera degli aerei dopo le tremende disintegrazioni che seguono alle esplosioni o ai crolli?
Dobbiamo capire se l’oblio della mente è un vuoto che non è più colmabile nonostante i nostri sforzi di recuperare il tempo perduto; se è assolutamente inaccessibile, o se questi vuoti della memoria sono essenziali all’equilibrio psico-fisiologico della nostra vita cognitiva perchè impediscono quella pienezza troppo patologica, strabordante e straripante, di Seresevskij e di altri mnemonisti, che aumenterebbe talmente il potere della nostra memoria da renderlo nemico della memoria stessa, fino a impedirci di parlare della nostra vita con ordine e precisione e addirittura di agire nel mondo da persone normali. E’ forse possibile che questi vuoti così importanti e fisiologici siano al contempo inaccessibili, ma colmabili attraverso strategie mirate del ricordo, attraverso itinerari particolari segnati dentro il fitto bosco della memoria.
Del resto se, come abbiamo detto, l’oblio è, insieme alla memoria, una funzione fondamentale della nostra conoscenza è anche vero che il nostro cervello immagazzina ed elabora un messe straordinaria di ricordi e di informazioni e che tutti noi crediamo di essere persone umane, dotate di un Sé unitario, grazie al fatto che sentiamo di contenere nella mente i fatti della nostra vita e di poterli raccontare a noi stessi e agli altri in qualsiasi momento. Inoltre è stato dimostrato che gran parte del nostro sapere e della nostra vita sta nascosto nella nostra mente in modo inconscio e implicito e che può essere richiamato alla nostra attenzione cosciente quando se ne presenti l’occasione o la necessità.
I ricordi possono emergere in modo involontario. Non si può non ricordare il grande romanzo in sette volumi di Marcel Proust, tutto fondato sulla ricerca di quel ricordo involontario che nasce dall’azione imprevista di certi stimoli sensoriali che ci ricollegano improvvisamente ad alcune esperienze della vita passata. Chiuso nella sua stanza avvolta da pareti di sughero Proust si era immerso in un contesto per lui adeguato al recupero del tempo perduto, delle tracce remote della vita passata che si perdono dentro una nebbia fitta e impenetrabile. Proust si affannò molto a perlustrare la sua memoria attraverso il ricordo involontario e le intermittenze del cuore, riuscendo a risvegliare dal sonno molti eventi remoti come quelli della sua relazione affettuosa con la nonna. Di certo siamo sicuri che questo viaggio all’indietro ha una soglia invalicabile che nemmeno il ricordo involontario può superare. Si sa infatti che il periodo della nostra vita che va dal primo al terzo anno di vita è irrimediabilmente precluso alla nostra facoltà di recupero. Questo fenomeno è quello che si suole chiamare amnesia infantile.
Tutto questo non ci impedisce di supporre che, se anche non ricordano, i bambini registrano tutto nella loro mente in tracce di cui poi perdono la memoria cosciente. Per motivazioni che non possiamo discutere ampiamente in questa sede, a loro resta impossibile accedere ai ricordi. L’introduzione del tema dell’amnesia infantile ci permette di operare due distinzioni chiave: una è quella fra registrazione e ricordo, l’altra è quella fra accessibilità e disponibilità del ricordo.
La prima distinzione è una distinzione che ho sviluppato per dirimere l’ambiguità del termine italiano ricordoe che ho creato sul calco della distinzione presente invece nella lingua inglese fra record e recall. Non è un caso che in psicologia della memoria sia recall il termine usato per ricordo inteso nel senso di recupero cosciente dell’informazione. Il termine ricordoo registrazione si riferisce alla attività di memorizzazione o codifica che può avvenire anche in modo non cosciente e che non ha come conseguenza il fatto che quello che viene registrato possa essere ricordato per il semplice fatto di essere stato registrato.
Quello che avviene al momento della codifica è fondamentale per quello che avverrà al momento del recupero. Questo legame fra codifica e recupero è alla base di una teoria fondamentale formulata da Tulving (1983) che si chiama teoria dell’ecforia sinergica o GAPS, alla cui base sta il noto principio di specificità di codifica: “l’efficacia di un certo suggerimento dipende dalla quantità di informazioni che, in fase di recupero, combacia con le informazioni disponibili al momento dell’aquisizione. In sostanza uno stimolo richiama una esperienza se era effettivamente presente quando facevamo questa esperienza” (Roncato e Zucco 1993, p.82). A questa teoria dobbiamo l’altra importante distinzione fra accessibilitàe disponibilità dei ricordi (Tulving e Pearlstone 1966; Tulving e Thomson 1973). I ricordi possono essere presenti nella mente, disponibili al recupero da parte dei soggetti, ma possono essere al contempo inaccessibili per motivi che dipendono dal modo in cui è avvenuta la codifica, dalla relazione che si viene a creare nel contesto del recupero fra il suggerimento presente in quel momento e l’evento che dobbiamo andare a risvegliare nella nostra mente, dalla presenza o dalla assenza di adeguate strategie di recupero possedute dal soggetto medesimo. Per adesso non possiamo approfondire la complessità dei legami fra codifica e recupero e fra suggerimento e materiale del ricordo, ma dobbiamo concentrarci sul problema generale della permanenza dei ricordi. Dobbiamo chiederci cioè se è vero che tutti gli eventi della nostra vita restano comunque registrati nel nostro cervello o se invece alcune tracce vengono irrimediabilmente cancellate (ipotesi del decadimento della traccia). Nel primo caso tutti i ricordi della nostra vita sarebbero disponibili al recupero in linea di principio, anche se non è detto che essi siano di fatto accessibili. In questo secondo caso il problema è solo come potere accedere dentro l’impenetrabile cassaforte dei ricordi.
Ma è proprio vero che i ricordi sono tutti registrati nella nostra mente? Lo psicofisiologo Karl Lashley “praticava lesioni nelle diverse aree cerebrali per localizzare esattamente gli engrammi, cioè le modificazioni cerebrali responsabili della ritenzione mnemonica. Lashley trascorse 35 anni ad addestrare ratti, gatti e scimmie all’esecuzione di complessi compiti di apprendimento per poi lesionare o asportare specifiche porzioni dei loro cervelli, nell’inutile tentativo di cancellare la memoria delle informazioni apprese” (Gasbarri e Tomaz 2005, p.49. Cfr. anche Lashley 1929, 1950). Dunque il famigerato engramma non esiste e non esiste un correlato neurofisiologico delimitato e circoscritto della traccia della memoria. Se Lashley avesse avuto ragione allora ci sarebbe dovuto essere qualche angolo del nostro cervello una sorta di filmino delle nostre singole esperienze tipo: quella volta che mio padre si litigò con mia madre, quella volta che mi misero un brutto voto a scuola, la gita di istruzione in Grecia fatta con la scuola etc. Se il tentativo di Lashley è fallito, alcune clamorose scoperte hanno mostrato quantomeno che c’è una parte del cervello molto sensibile al ricordo delle esperienze passate e che se, da una parte non esistono engrammi circoscritti e localizzabili, dall’altra esiste un luogo misterioso (il lobo temporale) che adeguatamente stimolato produce dei flashback sorprendenti su porzioni lontane, remote e perdute della nostra vita. Il neurochirurgo canadese Wilder Graves Penfield è il punto di riferimento di questa ricerca.
1.2 L’esplorazione elettrica del cervello vivo.
Penfield doveva curare dei pazienti affetti da epilessia temporale cioè con “crisi epilettiche causate da una scarica avente origine in quel lobo” (Penfield 1975, p. 42). Il trattamento chirurgico dell'epilessia, soprattutto quella di tipo focale, era già stato introdotto da Sir Victor Horsley in Gran Bretagna e da William W. Keen negli Stati Uniti verso la fine dell’Ottocento. Un grande impulso venne dato anche dalle innovazioni nella tecnica neurochirurgica introdotte da Harvey Cushing, che abbatterono i valori di mortalità operatoria a causa degli interventi intracranici. Come ricorda lo stesso Penfield (ibid.) oltre alla tecnica operatoria “l’esplorazione elettrica era una guida particolarmente preziosa nei nostri interventi chirurgici, prima dei progressi dell’elettroencefalografia e dell’elettrocorticografia. Herbert Jasper venne all’Istituto Neurologico di Montreal nel 1935, introducendo la nuova tecnica elettrografica, e la sua inestimabile collaborazione neurofisiologica. Questa cooperazione costruttiva ebbe come frutto anche un libro, Epilepsy and the Functional Anatomy of the Human Brain pubblicato (....) nel 1954”.
Penfield operò in tal modo, dal 1943 al 1960, presso il Montreal Neurological Institute, 1132 pazienti, ottenendo una percentuale di successo del 75%, senza causare gravi deficit funzionali e/o psicologici ai pazienti.
Il risvolto più importante della pratica sistematica dell'elettrostimolazione fu la creazione di una mappa dell'organizzazione topografica del cervello umano per quanto riguarda le aree corticali con funzione motoria (homunculus motorio) e con funzione sensitiva (homunculus somatosensoriale), dimostrando ad esempio che la rappresentazione corticale della nostra sensazione del volto e della lingua e straordinariamente più ampia e più intensa di quella del nostro addome o che la rappresentazione corticale della mano e inferiore a quella del braccio etc.
Non solo dato che la stimolazione di determinate aree del lobo temporale in 53 pazienti era in grado di risvegliare dei ricordi, gli fu possibile formulare un'ipotesi sul meccanismo funzionale della memoria e sulla sua localizzazione cerebrale. Tutte queste scoperte hanno una particolare importanza in quanto eseguite sull'uomo e non su animali, come era avvenuto in precedenza. Come è noto infatti l'organizzazione funzionale del cervello varia da specie a specie in funzione del differente sviluppo della corticalità. Quindi, una ricerca basata sulla pato-fisiologia animale, trasferita in clinica, poteva generare conclusioni spesso inesatte, se non completamente erronee.
Penfield e la sua équipe utilizzavano, come Horsley, la stimolazione elettrica per localizzare esattamente i foci epileptogeni in pazienti portatori di epilessia focale corticale. Ai pazienti veniva applicata una semplice anestesia locale. Il paziente era sveglio sul tavolo operatorio durante la stimolazione delle presunte aree epileptogene. Dunque essi restavano coscienti, perfettamente vigili, capaci di intendere quello che stava accadendo e di sentire il dottor Penfield mentre discuteva con loro, ponendo loro domande e ascoltava risposte e racconti dall’origine misteriosa. Infatti ad ogni stimolazione il paziente rivelava al chirurgo le sue sensazioni. Tutto questo accadeva mentre lui, in una situazione surreale evocatrice di atmosfere alla dottor Caligari, operava con precisione indagatrice e meticolosa curiosità dentro un cervello aperto e vivo. Penfield realizzò immediatamente quanto potesse essere importante questa scoperta per la psichiatria, ma esitava a rendere disponibile le informazioni straordinarie di cui era venuto in possesso. Da scienziato preciso e onesto, egli voleva ottenere molti più dati circa la neurofisiologia di questo stranissimo e sorprendente effetto di reliving. Aspettò ben vent’anni prima di comunicare la sua scoperta, nel 1954, ai colleghi presenti alle Mandsley Lecture tenutesi a Montreal (1).
Una domanda sorgerà certamente nel lettore: ma come facevano i pazienti di Penfield a sopportare le elettro-stimolazioni sul loro cervello se erano anestetizzati solo nella parte del cranio che veniva incisa dal neurochirurgo? E la materia grigia, le terminazioni nervose? Come facevano i pazienti a non sentire dolore, se noi dal dentista saltiamo per aria al minimo tocco del trapano sul nervo della radice? Forse nessuno di voi lo saprà ma “il cervello non contiene ricettori del dolore” (Squire 1987, p. 75-76). La materia grigia è insensibile al dolore al contrario dei nervi di tutto il sistema periferico, soprattutto quelli che raccolgono i neuroni sensoriali. Per questo motivo bastava che i pazienti ricevessero solo un anestetico locale, un pain blocker, e non c’era alcun problema se “rimanevano completamente coscienti durante l’operazione chirurgica” (ivi, p.76).
Nel suo laboratorio Penfield utilizzava lo strumento stereotassico, una sorta di casco fissato alla testa che permette di visualizzare con esattezza le parti del cervello che devono essere stimolate, e gli elettrodi stimolatori per le esplorazioni intracerebrali, seguendo delle coordinate x, y, z. Dal punto di vista chirurgico il procedimento è il seguente: Penfield disegna delle linee tratteggiate sul cranio depilato di un paziente, lo incide, rimuove la calotta ossea del cranio. Poi inserisce gli elettrodi nella corteccia, opera una scarica singola per 60 cicli di 2 volt e monitora in un video l’apparato delle frequenze radio dello pneumoencefalogramma (2). In questo modo Penfield si muove con l’elettrodo sulla superficie del cervello per mapparne le zone.
A volte la stimolazione dell'area o delle aree responsabili dell'irritazione cerebrale ha come risposta l'inizio di un accesso epilettico. In tal modo l'area scatenante era esattamente delimitata e poteva essere asportata con successo. Altre volte “la stimolazione elettrica delle aree interpretative della corteccia produce occasionalmente quel che Hughlings Jackson aveva chiamato ‘stato sognante’ o ‘attacchi psichici’” (Penfield 1975, p.42; cfr. Jackson 1931, 1973; Hogan e Kaiboriboon 2003). Talvolta il paziente ci faceva capire che avevamo prodotto in lui uno stato sognante e noi valutammo ciò come una prova che eravamo vicini alla sede della causa della crisi” (ibid). Le conferme di questa supposizione arrivano anche dalle descrizioni dei pazienti: “Oh, è stato come un attacco (nda epilettico), c’era qualcuno che fumava del tabacco, ma non so chi potesse essere” (Penfield e Perot 1963, caso 23, 637).
Per Penfield questi risultati riguardavano quegli strani fenomeni che il neurologo inglese Hughlings Jackson aveva individuato nella sua lunga pratica clinica con gli epilettici. Jackson aveva chiamato dreamy states (stati sognanti) gli stati di leggera perdita di memoria episodica recente e del normale flusso di coscienza che seguivano alla disritmia cerebrale elettrica. In realtà questo termine generico indicava una serie di fenomeni disparati molto simili fra loro: allucinazioni, stati di coscienza spesso accompagnati da sentimenti e rappresentazioni mentali dotate di grande pregnanza e vividezza o da quella particolare qualità chiamata oneness, che corrisponde ad una sorta di cenestesi del sé ovvero di armonia scaturita dal sentirsi identici a se stessi avvolti in una pace stabile e solida.
Nessuno poteva immaginare che il dato scientifico più importante delle operazioni di Penfield non sarebbe stato il risultato chirurgico e le sue conseguenze terapeutiche sui pazienti epilettici, ma una scoperta, imprevista e stravolgente, scaturita proprio da quel dialogo surreale e dagli stranissimi resoconti dei pazienti. Egli si accorse che il lobo temporale è l’unica zona della corteccia (la sostanza grigia) che reagisce alle stimolazioni elettriche facendo emergere dall’oscurità della memoria dei flashback della vita passata, dei veri e propri relivings in cui i pazienti erano pienamente coinvolti e di cui erano coscienti testimoni. Come dice Squire (1987, pp.76-77): “La stimolazione elettrica della superficie corticale a volte fa sorgere delle immagini che i pazienti hanno descritto come percezioni ed esperienze coerenti. Penfield ha interpretato queste risposte allucinazioni esperienziali come delle veridiche riproduzioni dell’esperienza passata. Inoltre ha supposto che sia la traccia di registrazione di queste esperienze, sia le connessioni neurali che permettono di accedervi, devono essere vicini al luogo stimolato dall’elettrodo. Nella visione di Penfield, le esperienze riprodotte attraverso la stimolazione hanno ripresentato il flusso della coscienza a partire da un episodio antecedente della vita passata. L'elettrodo stimolatore ha delineato la ripresentazione a partire dal suo stesso luogo (nda cerebrale) di immagazzinamento, situazione molto simile a quella in cui un nastro registratore fosse stato inserito arbitrariamente in certi punti” del cervello dei soggetti. Una delle caratteristiche salienti del reliving è il pieno coinvolgimento dell’io dei pazienti. Essi sembrano dei sogni, delle full immersion in una realtà virtuale vissuta secondo coordinate spazio-temporali precise. Per esempio, un paziente riferiva di sentire una canzone, ma di non stare immaginando l’aria producendola da sé, ma di stare ascoltando realmente qualcosa. Nel manuale di Zimbardo e Ruch (1975, pp. 48-49) vengono riferiti in dettaglio alcuni particolari interessanti delle indagini di Penfield: “Siamo nella sala operatoria dell'istituto neurologico de Montreal osservando l’operazione al cervello di Buddy, un giovane uomo con delle scariche epilettiche incontrollabili. Il chirurgo si propone di operare per rimuovere un tumore, ma in primo luogo deve scoprire quali saranno le conseguenze della rimozione di svariate parti del tessuto del cervello che circonda il tumore .... Tutto ad un tratto viene fuori una risposta inaspettata. Il paziente ghigna, sorride, apre gli occhi quando quella zona è stimolata. "Buddy, che cosa è accaduto, che cosa li ha fatti esperienza giusta?" "Dot., ho sentito una canzone, o piuttosto una parte di una canzone, una melodia." "Buddy, lo ha mai sentito prima?" "sì, mi ricordo di averlo sentito molto tempo fa, ma non posso ricordarmi del nome dell'aria." Quando un altro luogo del cervello è stimolato, il paziente ricorda un'esperienza drammatica (trhilling experience) di infanzia con vividi dettagli.
In una operazione similare, una donna “ha rivissuto” l’esperienza avuta nel dare alla luce il suo bambino, come se, spingendo un pulsante elettronico della memoria, il Dr. Wilder Penfield avesse toccato le memorie immagazzinate silenziosamente per anni negli spazi reconditi dei cervelli dei suoi pazienti”.
Le varie componenti sensoriali dell’evento, visive, uditive, olfattive, emergono alla coscienza. Perfino le sensazioni somatiche dell’evento vengono esperite di nuovo. I soggetti riferiscono che la sequenza della stimolazione neurologica si sovrappone ad un flusso che scorre parallelo alla sequenza del tempo reale, come se l’azione andasse avanti e si srotolasse come una pellicola cinematografica. Questo processo memoriale è una “one-way street”, “una strada a senso unico che procede da un punto qualsiasi a partire dal quale la stimolazione apre un ingresso dentro di essa” (Penfield 1955, p. 453). Penfield stesso paragona questo movimento in avanti ad un film: “Fu subito evidente che non si trattava di sogni. Era un’attivazione elettrica della registrazione sequenziale della coscienza, registrazione che era stata impressa durante un’antecedente esperienza del malato. Il paziente ‘riviveva’ tutto quello in cui era stato consapevole in quel periodo passato, come in un flashback cinematografico.
La prima esperienza di questo tipo accadde nel 1933. Una madre disse che non appena l’elettrodo aveva toccato la corteccia “era all’improvviso conscia di essere in cucina, mentre ascoltava la voce del suo bambino che giocava fuori nel cortile. Avvertiva inoltre dei rumori circostanti, come ad esempio di automobili che potevano rappresentare un pericolo per il figlio”” (Penfield 1975, p. 42).
L’esperienza continua fino a che lo stimolatore non viene estratto e si può ripetere più d una volta se l’elettrodo viene ripiazzato dopo un breve intervallo. Penfield credeva che questa corsia compatta della memoria fosse stata “in qualche modo condizionata da anni di scariche elettriche provenienti da un vicino focus epileptogenico” (Penfield 1955, p. 453) e perciò collega il fenomeno alla teoria della plasticità di Hebb (1946): “«Si è tentati di credere (...) che da ogni nuova esperienza venga stabilita una facilitazione sinaptica». Se così fosse, quella facilitazione permanente potrebbe guidare un flusso di impulsi neuronali susseguente, attivato dalla corrente elettrica dell’elettrodo, anche anni dopo” (Penfield 1975, pp. 52-54).
Il meccanismo della facilitazione è collegato direttamente all’ idea che i ricordi restino integri nella mente anche dopo lunghissimo tempo: “è chiaro che l'azione di un neurone che accompagna ogni successivo stato di coscienza lascia la sua impronta permanente nel cervello. L’impronta, o ricordo, designa un percorso di facilitazione dei collegamenti neuronali che può essere ripercorso molti anni più tardi attraverso una corrente elettrica, senza perdita di dettagli, come se tutto questo fosse stato conservato nel nastro di un registratore.
Consideriamo adesso quello che succede nella vita normale. Per un tempo breve, un uomo può ricordare tutti i dettagli presenti del suo stato di coscienza appena passato. Dopo alcuni minuti parte di esso sarà svanito aldilà del raggio di azione della sua volontà. Dopo settimane sembrerà che, fino limitatamente al suo ricordo volontario, tutto si è dileguato, tranne quello che gli sembrava importante o che ha scosso la sua emotività. In verità il dettaglio non è andato perduto. Durante l’interpretazione subconscia di una più tardiva esperienza contemporanea, questo dettaglio è ancora disponibile. Questo è una parte di quello che noi possiamo chiamare percezione” (Penfield 1969, p. 165).
1.2. Risposte esperienziali e risposte senso-motorie.
Grazie a Penfield possediamo un vasto repertorio dei resoconti dei soggetti, repertorio documentato e scientificamente valido, non affidato a tradizioni orali o a riferimenti di seconda mano: “Un giovane dichiarò che stava seduto ad assistere un partita di baseball in un piccola città e osservava un bambino che si infilava sotto lo steccato per andare fra il pubblico. Un altro che si trovava in una sala da concerti ascoltando musica. “Un orchestra”, spiegò. Poteva distinguere i diversi strumenti.” (Penfield 1975, pp. 42-43).
Invece “la paziente D.F. sentiva degli strumenti che suonavano una melodia. Tornai a stimolare lo stesso punto trenta volte (!) cercando di fuorviarla e dettando ogni volta la sua risposta ad una stenografa. E ogni volta che tornavo a stimolare quel punto, lei sentiva di nuovo la melodia. Cominciava dallo stesso punto e andava avanti, musica e parole. Quando lei cantava a bocca chiusa il ritmo era quello giusto” (Penfield 1975, p. 43).
Un caso esemplare presente anche in Penfield (1958) è quello di M.M., una giovane donna di ventisei anni affetta da crisi che iniziavano con una sensazione di familiarità, seguita da una paura e da un breve sogno di qualche esperienza passata. Dopo aver operato l’incisione e aver liberato l’emisfero destro dal cranio, Penfield esplora con l’elettrodo le zone ricettive del cervello di M.M. e segna con dei numeri quelle in cui ottiene una risposta di qualche tipo. Il punto n.2 provoca un formicolio nel pollice sinistro, il n.3 un formicolio nel lato sinistro della lingua, al 7 un movimento della lingua. Mentre queste risposte sono di tipo senso-motorio e rivelano che Penfield aveva toccato aree della circonvoluzione somato-sensoriale o motoria,il lobo temporale forniva delle risposte definite “psichiche” cioè che avevano a che fare con le funzioni cognitive superiori della memoria e della coscienza. Gli esempi, forniti per ogni punto dell’emisfero destro sono i seguenti:
“ 11- «Ho udito qualcosa , non so cosa fosse».
11-(stimolazione ripetuta, senza preavviso) «Sì, credo d’aver udito una madre che in qualche posto chiamava il suo bambino. Sembrava qualcosa accaduto anni fa». Richiesta di una spiegazione, la paziente rispose: « Era qualcuno del vicinato, dove io abito». Poi aggiunse: « Io stesso ero là, abbastanza vicina da sentire».
12 - «Sì, ho sentito delle voci laggiù, in qualche posto lungo il fiume; la voce di un uomo e la voce di una donna che chiamavano ...... credo d’aver visto il fiume».
15- « Appena un lampo d’una sensazione di dimistichezza e la sensazione che sapevo tutto quanto sarebbe successo nel prossimo futuro».
17c- (Un ago elettricamente isolato tranne che sulla punta, venne inserito profondamente nella fissura di Silvio, nella superficie superiore del lobo temporale, poi venne data la corrente) « Oh! Ho riavuto lo stesso ricordo tanto tanto familiare, in un ufficio, da qualche parte. Vedevo le scrivanie. Ero lì e qualcuno mi chiamava, un uomo appoggiato a una scrivania con una matita in mano ». Avvisai la paziente che stavo per stimolare, ma non lo feci: «Niente ».
18a- (stimolazione senza preavviso) « Ho avuto un breve ricordo; la scena di una commedia; parlavano e io la vedevo, ma la vedevo proprio, nel ricordo».” (Penfield 1975, p.43).
Penfield chiama questo tipo di risposte esperienziali (experiential answers) per distinguerle dalle risposte di tipo sensoriale o motorio. Quest’ultimo tipo di risposte segue una stimolazione delle aree dell’omuncolo somatosensoriale e dell’omuncolo motorio per cui se viene toccata la zona deputata alla sensibilità della lingua nel primo omuncolo, il paziente avverte un formicolio nella lingua medesima; mentre se viene toccata la zona del movimento della mano sinistra presente nel secondo omuncolo il paziente muove la mano sinistra (3).
La risposta esperienziale è molto più complessa. Essa riguarda il ricordo di esperienze avute dal soggetto o la percezione di esperienze che il soggetto sente come parte della propria stessa vita. A differenza dalle risposte senso-motorie, alla risposta esperienziale manca quella corrispondenza sperimentale, biunivoca, infallibile e reiterabile tra la zona del cervello stimolata e l’output che ne scaturisce. Infatti dalla lettura di molti casi ci si rende conto come siamo di fronte ad una grande variabilità di tipi di risposte esperienziali, differenziabili sia per modalità sensoriale che per maggiore o minore vividezza percettiva. Penfield ha fornito una divisione per modalità stabilendo quattro categorie di risposte: “uditive (voci, musica o un suono senza senso), visive (la gente, una scena o un oggetto riconoscibile), uditive e visive combinate (scene insieme a suoni pertinenti) o risposte esperienziali non classificate (un pensiero, una memoria, o un flash-back)” (Squire 1987, p.77). In Penfield e Perot (1963) questa classificazione è applicata ai dialoghi svolti con 40 soggetti di cui 24 con risposte esperienziali di tipi uditivo che asserivano di sentire voci, suoni, o suoni senza un preciso significato e 12 soggetti con risposte esperienziali di tipo combinato, uditivo e visivo insieme. I restanti 5 pazienti riferiscono cose vaghe, non relate ad alcuna immagine concreta, ma alla supposizione di “un pensiero”, di “una memoria”, di “un flash-back” dicendo che lo stimolo “ha riportato alla mente qualcosa”.
Il caso 1 è quello, già citato sopra, della donna che rivive l’esperienza del parto e che “percepiva il fatto di star rivivendo quell’esperienza” in prima persona (Loftus e Loftus 1980, p.414). Il caso 19 riferisce un’altra risposta esperienziale di tipo visivo-uditivo in cui gli elementi percepiti sono svariati: una persona, un gruppo di persone, una scena, un oggetto dalla forma familiare e riconoscibile. Il paziente dice ad esempio di aver visto un uomo da lui conosciuto mentre afferrava un bastone. Il caso 36 è una donna che si esprime così: “Io penso di aver sentito una madre chiamare il suo piccolo ragazzo da qualche parte. Sembrava che fosse qualcosa accaduto anni fa” (ibid.) e riferisce pure che c’era “qualcuno vicino a dove vivo” (ibid.).
Il caso n.9 è uno dei 12 con sola risposta di tipo uditivo riferita da una donna che esclama: “Oh, una sorta di suono lontano come di persone che cantano”. Quando le viene chiesto cosa senta precisamente risponde: “Non so. E’ come una raccolta di vecchie canzoni popolari in sottofondo, probabilmente sono degli inni” (ibid).
Dopo aver analizzato le risposte, Penfield e Perot (1963, p.672) avanzano l’ipotesi che molte di questi resoconti “consistono in una esperienza che il paziente può riconoscere facilmente e identificare come se fosse stata parte di una esperienza precedente”. Questo fatto emerge dalle frasi dei pazienti che posseggono un tono equivalente di partecipazione cosciente da parte dei pazienti: “Oh! Io avevo la stessa memoria molto, ma molto familiare! In un ufficio, da qualche parte in qualche posto. Io potrei vedere le scrivanie. Ero lì e qualcuno mi stava chiamando, un uomo che studiava su un tavolo, con una matita nella mano”.
1.3 La parentela tra i relivings e sogni.
Squire (1987, p. 78) ricorda che molte rievocazioni hanno caratteristiche in comune con quanto avviene nei sogni. Nel suo trattato di neuropsicologia Benedetti (1969=1972, p. 60) descrive molto bene le parentele fra i relivings di Penfield e i sogni:
“ La rievocazione quasi-allucinatoria del passato è nei suoi termini generali un fenomeno fisiologico: infatti avviene innumerevoli volte nel corso dei sogni. Talora il soggetto è cosciente del carattere quasi-allucinatorio delle sue esperienze; egli rivede la madre morta da anni, risente voci e rivive scene significative del passato e “crede di sognare”; altre volte non si rende conto di trovarsi in una realtà diversa dal suo presente attuale e la rievocazione è allora del tutto allucinatoria. Il significato di questi ritorni del passato nei sogni è ben noto a chi ha esperienza di psicoterapia. E’ una delle qualità fondamentali dell’uomo,quella di poter continuare, nei sogni, l’elaborazione del passato. Le sue esperienze significative ritornano e trovano adesso nuove risposte e nuove integrazioni”.
Un ragazzo di 12 anni aveva degli attacchi epilettici preceduti dalla vista di un ladro che si muoveva verso di lui. Questa esperienza si ripete quando Penfield tocca con l’elettrodo la porzione posteriore del lobo temporale sinistro: “ Oh non posso crederci, mio Dio, dei ladri con le pistole stanno venendo verso di me” (ivi, Caso 3, p.616). Una stimolazione in un altra zona del lobo temporale provoca il ricordo di una conversazione fra sua madre e sua zia, ascoltata così per caso come in un sogno. Il ragazzo dice che la zia sta invitando la mamma ad andare a farle visita e riferisce che egli comprende che si tratta di una telefonata solo grazie al modo in cui la zia parla e modula il suono della sua voce. L’esperienza avvertita ha le caratteristiche di una esperienza onirica in cui eventi che normalmente si dovrebbero percepire in successione temporale attraverso una combinazione di immagini e di suoni riferibili anche se legati in modo imprevedibile e discontinuo, vengono invece percepiti in modo simultaneo, olistico, intuitivo.
Sono gli stessi pazienti che rivelano direttamente di percepire il reliving come un sogno. Il caso 2 stimolato per la quinta volta sulla superficie posteriore del giro temporale superiore sinistro ha riferito di “Voci di persone che parlano”. Alla sesta stimolazione ha riferito che “ora li sento....E’ un po’ come se stessi sognando” (Penfield e Perot 1963, caso 2, p.614). Il caso 22 riferisce “Io sto avendo dei sogni...sto sentendo delle cose...sto sognando delle cose” (ivi, p.635). Il caso 25 è una donna che esordisce dicendo: “Sta cominciando un sogno. Ci sono molte persone”. Dopo aver riferito che non sa cosa si stanno dicendo queste persone le viene chiesto se sa almeno dove stanno e lei: “Nel soggiorno. Io suppongo che uno di loro sia mia madre” (ivi, p.638). Squire (1987, p.78) nota che, come nei sogni, alcuni pazienti non ricordano i dettagli e sentono che il racconto del loro reliving non può essere colmato in alcun modo, ma deve essere riferito così per come lo hanno vissuto: un miscuglio di percezioni chiare e confuse che danno alla persona una sensazione forte di familiarità, tanto forte quanto poco ricca di riscontri autobiografici chiari. Il caso 8 conferma questa prospettiva. La donna, stimolata nella superficie superiore del lobo temporale sinistro, parla di un uomo che prede forma nel suo stato sognante: “Aveva il suono di una voce che pronunciava delle parole, ma questa voce era talmente fievole che non potevo afferrarne niente”. Penfield ripete la stimolazione per 15 secondi. La paziente allora afferra qualche parola. Capisce un nome e lo ripete più volte: Jimmy, Jimmy, Jimmy”. E’ suo padre, lei ne è sicura. La sta chiamando. Jimmy è lei. Lei in persona!
Un ragazzo di 19 anni dice. “Sento parlare qualcuno...Penso che questo debba essere come un ristorante o qualcosa....” (Penfield e Perot 1963, caso 13, 627). Un altro: “Sì....Qualcosa veniva detto e io sapevo che cosa veniva detto, ma non riesco a tradurlo in parole” (Penfield e Perot 1963, caso 14, p.629).
In uno dei suoi esperimenti Penfield pensò di nascondere l’elettrodo. La paziente non sentiva nulla. Penfield credeva che la paziente non sarebbe riuscita a indovinare che cosa stava succedendo quando avrebbe tolto l’elettrodo dalla corteccia cerebrale. In altri casi invece verificava se una nuova stimolazione riproponeva la stessa risposta esperienziale. Per esempio “L.G. vedeva un uomo che faceva a pugni. Quando il punto veniva ristimolato egli vedeva un uomo e un cane che passeggiavano lungo la strada" (Penfield 1955, p.455). Questo vuol dire che non c’è una continuità fra stimolazione e risposta e il nastro della memoria non innesca un flusso continuo dell’evento, ma delle tracce che hanno il sapore della familiarità.
Penfield (1975, p.67) rivela che la sua curiosità per il cervello e per la mente iniziò, durante la sua specializzazione in filosofia, grazie alla lettura dei “Principi di Psicologia” di William James (1910). James aveva paragonato il flusso di coscienza ad un fiume che scorre ininterrottamente durante le ore di veglia. Penfield corregge la metafora perchè un fiume non può subire modificazioni da parte dell’uomo, mentre “pensiero, ragione, curiosità invece possono far sì che la corrente di coscienza alteri il suo corso e muti completamente il suo contenuto” (ibid.). Il fiume della coscienza imperversa dalla sorgente della vita passata e cambia continuamente direzione, capienza, intensità. La mente può in qualsiasi momento aprire la diga di questo fiume e far scorrere flussi di coscienza intimamente legati alle esperienze del ricordo del passato.
Le stimolazioni elettriche e le scariche epilettiche erano per Penfield la strada per entrare dentro a questo fiume dilagante, navigando nel suo letto tumultuoso. Il ricordo emerge da questa continua fluttuazione in modi che non sono regolati da leggi di causalità standardizzabili. Talvolta il paziente può rievocare un evento senza sapere però a quale contesto o periodo della vita esso appartiene. Per esempio, la musica sentita è familiare, viene avvertita come parte della propria esperienza passata, ma il paziente può restare incapace di collegare con precisione questa musica ad un evento preciso della sua vita, all’occasione reale di cui egli assapora soltanto una sensazione di estrema familiarità. Di norma gli eventi che erano imbevuti di sensazioni, erano emozioni e normalmente esperienze che erano avvenute routine (nessuna emozione forte veniva licitata) non potevano essere richiamate con facilità. Il ricordo suscitato elettricamente differisce da quello naturale per il fatto che spesso produce delle sequenze esperienziali casuali. Per esempio uno dei pazienti sentiva una selezione di musica molto strana e particolare, che gli sembrava eseguita da un’ orchestra perchè il suono era nettamente fruibile dal suo udito ed era talmente vivido e chiaro che il paziente credeva che ci fosse un fonografo dentro la sala operatoria. Quando lo stesso punto veniva nuovamente stimolato la musica cominciava dallo stesso lasso di tempo da dove era cominciata la prima volta. E’ molto interessante sapere che, in generale, la percezione della musica da parte dei pazienti, non avveniva solo ad un puro livello uditivo superficiale, ma metteva in gioco anche il feeling emotivo e le sensazioni profonde dei soggetti legate all’ascolto del motivo musicale Anche se la sorgente da cui proviene la musica è ignota, il senso di godimento e di benessere accompagna il fluire della sequenza musicale nel passato rivissuto ed è avvertito nel qui ed ora dell’esperienza cosciente, e dunque anche di quella emotiva e affettiva.
La mente cosciente della persona che subisce l’intervento realizza che è nella stanza operatoria. La comprensione della memoria precedente è chiara, l’interpretazione di quello che succedeva nel punto del tempo passato è compreso e sentito con l’accompagnamento di sensazioni e di emozioni. Perciò la risposta è veramente esperienziale, in prima persona e allo stesso tempo interpretativa, in terza persona. Il soggetto non parla solo del che cosa sta rivivendo, ma parla anche del modo in cui lo sta rivivendo. Anzi egli ne parla mentre lo rivive, dal di dentro e non dal di fuori dell’evento. Da molti resoconti dei pazienti si percepisce che la loro esperienza non è quella di un uomo che rivede le scene della propria infanzia proiettate su uno schermo da un filmino. Sono i pazienti che agiscono nel ricordo, come se fossero penetrati dentro una realtà virtuale. Per questo navigano contemporaneamente sul livello mnemonico del ricordo e finanche sul livello meta-cognitivo della coscienza che gli permette di farsi delle domande e di riflettere sul fenomeno del reliving che stanno sperimentando.
A mio modo di vedere l’ analisi completa deve andare oltre un esame puramente neurofisiologico o neuropsicologico. Essa richiede anche un approccio di tipo linguistico-testuale e di tipo cognitivo-teorico. Occorre capire bene cosa dicono esattamente i pazienti e quale sia la correlazione fra i loro testi, i loro racconti e l’attivazione di funzioni cognitive molto alte come la memoria e la coscienza. Vediamo allora in cosa consistono queste risposte esperienziali che coinvolgono l’io dei pazienti nel rivivere eventi del passato in prima persona.
1.4 Ricordo di esperienze realmente vissute o allucinazioni?
Come abbiamo visto dal brano sopra citato Benedetti (1969=1972, p.60) aggiunge i tratti dell’allucinazione alle parentele fra reliving e sogno. Vedremo come questa terza dimensione percettiva sia fondamentale per una corretta interpretazione dei fenomeni scoperti da Penfield. Per adesso è importante comprendere che le somiglianze con i sogni aprono la strada una analisi delle memorie risvegliate in termini ricostruttivi. Benedetti fa l’interessante osservazione che i pazienti che reagiscono alla stimolazione elettrica della corteccia con allucinazioni mnestiche, sono contemporaneamente consapevoli sia della scena vividamente rievocata sia della situazione in cui essi si trovavano, ovvero l’allucinazione sperimentale si inserisce nell’esperienza presente. Per Benedetti altri esperimenti “ammettono un’interpretazione diversa della stimolazione temporale: quest’ultima provocherebbe fenomeni allucinatori, di deja vue , etc., non solo mediante l’attivazione di tracce mnemoniche, ma anche trasformando associazioni presenti in fatti pseudomnenomici” (ibid.). Anche se Mahl ha dimostrato “la manipolazione della situazione presente influenza l’esperienza mnemonica” (ibid.), questo fatto non incrina la teoria di Penfield, la quale “piuttosto si arricchisce dell’osservazione che non solo la stimolazione elettrica della corteccia “interpretativa” (vedi lobo temporale), ma la concomitante stimolazione sensoriale ed esperienziale sfocia nel fenomeno globale” (ivi, p. 61).
Penfield parla di due correnti di coscienza che sono simultaneamente afferrate dal soggetto nel loro reciproco rapporto: “Il flashback è una risposta alla stimolazione elettrica, non intrattiene nessuna relazione con l’esperienza presente all’interno della camera operatoria. In quel momento la coscienza è doppia, e il paziente può discutere intorno al fenomeno. Se egli sta sentendo della musica, egli può canticchiare a tempo con questa. L’aspetto sorprendente del fenomeno è che infine egli è cosciente di tutto quello che stava nella sua mente durante un precedente intervallo di tempo. Quest’ultimo è il flusso di coscienza precedente che ha ricominciato a scorrere. Se viene sentita della musica, essa può consistere in un orchestra, in una voce, in un piano. Qualche volta egli è cosciente di quello che stava vedendo in quel momento, altre volte solo della musica. Questo flusso si arresta quando l’elettrodo viene tolto e può ripetersi anche parecchie volte quando viene ripiazzato senza un intervallo troppo lungo. Il ricordo elettrico è completamente casuale. La gran parte delle volte l’evento non era né significativo, né importante” (Penfield 1969, p. 152). Non c’è una interferenza di altri flussi di coscienza, ma anzi si dà solo contemporaneità di più flussi di coscienza. Così una donna vede sua figlia ancora piccola mentre gioca nel cortile. Mentre assiste a quella scena il suo flusso di coscienza è attirato contemporaneamente del suono delle auto che passano in una strada vicina (Penfield 1955, p. 455). In un altro caso un uomo si sorprende mentre ascolta la conversazione di alcuni suoi parenti mentre ridono e si divertono. Nello stesso tempo si ritrova in un ospedale convalescente dopo un intervento chirurgico. Anche se egli si sforza in tutti i modi di capire perché i suoi parenti sono di buon umore egli non ci riesce (ibid.).
Questo fenomeno della “doppia coscienza" potrebbe costituire una conferma sperimentale alle ipotesi neo-dissociazioniste attualmente in voga nello studio degli Stati di Coscienza. A noi interessa come questo costanza e questo intreccio tra flussi di coscienza diversi confermi ancora di più la caratteristica della piena familiarità dei relivings per i pazienti elettrostimolati.
Come abbiamo visto quasi tutti i pazienti avvertono una sensazione di familiarità rispetto alle scene dei relivinsg anche se non riescono a capire bene cosa dicono le persone che vedono o quali siano queste persone. Questo fatto aumenta la stranezza del fenomeno della doppia coscienza. Infatti i pazienti “non perdono mai la coscienza di essere in una sala operatoria e della realtà immediata” (Squire 1987, p.78) che li circonda fisicamente. Un paziente si esprime così: “Io sento che è come se stessi andando incontro ad un attacco”. Poi gli viene chiesto perchè e lui risponde: “Quella musica, dalla scena colpiscono i Guys and Dolls, e dice che è come quando la stava ascoltando in un episodio della sua vita passato. Quando gli viene chiesto se gli sembra di trovarsi lì o se sta solo ricordando tutto ciò il paziente non ha dubbi: “E’ come se fossì lì” (Penfield e Perot 1973, Caso 37, p.653). Un altro paziente esclama: “Sì dottore, sì dottore! Ora sto sentendo delle persone che ridono-miei amici che stanno in Sud Africa”. Il dottore gli chiede se li riconosce: “Sì sono due cugini, Bessie e Ann Wheliaw”. Secondo il paziente i cugini stavano ridendo proprio perchè lui non sapeva perchè ridevano (ivi, Caso 38, p.654).
Come fa notare Squire (1987, p.79) queste scene familiari sono “spesso inframmezzate da situazioni estranee o addirittura irreali e fantastiche”. E’ il caso del paziente che dice: “Sì. Io sento la stessa donna familiare che chiama. La stessa signora (la stessa che il paziente aveva sentito un momento prima quando era stato stimolato lo stesso punto) quella non era nelle vicinanze. Sembrava stare in un deposito legnami.....io non sono mai stato vicino ad un deposito di legna” (Penfield e Perot 1973, Caso 36, p. 651).
(continua in Scenari-Esperimenti))
Wilder Penfield
1.1 La permanenza dei ricordi nella mente umana.
Qualcuno resterà stupito se, all’inizio di un saggio sul mantenimento dei ricordi, si afferma che la memoria non esisterebbe se non esistesse la capacità di dimenticare. Argomenterò tra breve l’importanza di questa tesi e il suo legame profondo con il subject principale. Per adesso vorrei far notare come la sorpresa nasce dal fatto che percepiamo l’intelligenza e la memoria come dei grandi contenitori. Ad esempio tutti pensiamo che il nostro cervello sia un enorme magazzino la cui funzione è di essere riempito il più possibile di informazioni. Questa idea si basa sul principio che se c’è un contenitore, questo va riempito nella sua totalità. L’idea di mente e di memoria come contenitore da riempire si è rafforzata con l’avvento delle tecnologie informatiche. Non a caso il computer è divenuto il contenitore di informazioni per antonomasia. Uno degli scopi fondamentali di questa macchina è proprio quello di raccogliere, archiviare e conservare dati. La maggior parte degli utenti non riflette sul fatto che questa memoria è limitata. Apre nuovi file, salva testi, musiche e immagini senza pensare più di tanto al limite di memoria dell’hard disk. Solo quando qualcosa si inceppa e il computer è lento, allora siamo spinti ad estenderne la memoria aggiungendo la RAM. In questo caso sono i problemi di usability che ci spingono a prendere coscienza del fatto che la memoria del computer non è illimitata.
E’ interessante notare che, nel caso della memoria umana, la metafora del contenitore diventa più complessa. Infatti con la parola memoria noi non intendiamo soltanto il contenitore, il deposito o il magazzino delle informazioni, ma anche e soprattutto la straordinaria messe di dati che sono raccolti dentro quel contenitore. La memoria è sia il magazzino, sia quello che è immagazzinato; è sia il contenitore, che il database. Gli informatici cercano di trovare modi per espandere la memoria (nel senso del contenitore). Invece in noi soggetti umani la ricerca dell’espansione e dell’arricchimento della memoria coincide con la maggiore complessità e organizzazione della codifica delle informazioni. Nel nostro cervello i due processi sono interdipendenti e a volte coincidono.
Lo stereotipo per cui la memoria è una continua somma di informazioni resta forte a causa dell’imperversare dei computer e di quel grande database ipertestuale che è Internet. L’idea informatica di memoria ha mantenuto vivi molti malintesi sulla natura della memoria umana e una visione semplicistica del suo funzionamento. Per uscire fuori da certi stereotipi del senso comune potrei elencare una serie di differenze tra la memoria del computer e la memoria del cervello. Se la prima è precisa, la seconda è imprecisa; se la prima non è selettiva ed è espandibile, la seconda è altamente selettiva ma strutturalmente vincolata. L’opposizione che ci interessa discutere in questo contributo è quella tra la memoria del computer che non sa cosa è l’oblio (se non quello totale e irreversibile cui assistiamo quando un virus ci distrugga fatalmente l’hard disk) e la memoria umana, che non solo conosce l’oblio ma che non può sussistere senza l’oblio.
A dare un fondamento scientifico alla idea del potenziamento e dell’arricchimento della memoria è stata la teoria di Donald Hebb (1946) e le ricerche di Kandel sul meccanismo del potenziamento a lungo termine.
Di recente un gruppo di studiosi di Berlino tra cui Gina Turrigiano (2004) hanno riesaminato l’idea di potenziamento e di facilitazione pervenendo ad un modello più vicino alla dimensione umana del ricordo in cui un ruolo chiave è rivestito dalla omeostasi o equilibrio cognitivi. Questo equilibrio è fortemente legato all’assunto enunciato all’inizio. Se la memoria fosse regolata solo dalla legge di Hebb il nostro cervello non farebbe che incamerare dati in modo esponenziale fino ad esplodere in una sorta di cortocircuito bulimico. Una idea più matura del potenziamento è che al principio di facilitazione ed eccitazione secondo cui i neuroni sono spinti a creare sinapsi (legami tra le terminazioni dei neuroni) con maggiore velocità e intensità, occorre contrapporre un principio di inibizione e di freno di questa facilitazione. Gli esperimenti e il modello di Turrigiano, in piena sintonia con le moderne ipotesi del connessionismo, conferma il nostro assunto secondo cui non potrebbe esistere la memoria se non esistesse l’oblio, la dimenticanza.
Un’altra conferma proviene dalle descrizioni di casi di pazienti dotati di una memoria straordinaria, i cosiddetti mnemonisti. Il più famoso è il dott. Seresevskij, giornalista affetto da mnemonismo patologico, descritto da Lurija (1968) nello splendido libro Viaggio nella mente di un uomo che non dimenticava nulla.
Se non dimenticassimo finiremmo tutti come il mnemonista di Lurija in preda ad una memoria talmente affollata di ricordi, da creare un duplicato caleidoscopico e labirintico della realtà, impossibile da governare. Un doppione così intricato, folto, ridondante e linkato, da non permettere più di ricordare, con ordine e pertinenza, i fatti, le persone e gli oggetti della vita reale. Come dimostra una attenta analisi del caso di Seresevskij quello che i linguisti chiamano pertinenza semantica dipende in larga misura dalla pertinenza cognitiva che i nostri ricordi posseggono con le associazioni emerse dal senso intersoggettivo e personale delle parole e dall’equilibrio (omeostasi) costante che la nostra mente mantiene fra gli aspetti soggettivi, interiori e autobiografici della nostra memoria episodica e gli aspetti pubblici, esterni, intersoggettivi della memoria semantica. Dentro questo equilibrio i ricordi associati alle parole mantengono una relazione stringente con il significato condiviso delle parole stesse e tengono salda quella funzione di realtà di cui parla Janet (1889, 1907), ovvero la relazione adeguata e pertinente fra l’ ontologia delle relazioni che intercorrono fra gli oggetti e gli eventi presenti nel mondo e il loro rispecchiamento adeguato all’interno del linguaggio e della memoria.
Avremo modo di approfondire in altre sedi il problema della interdipendenza fra oblio e memoria. In questa sede vogliamo domandarci perchè dimentichiamo e se davvero il nostro cervello dimentica completamente i ricordi cancellandoli completamente. E’ proprio vero che ci sono delle esperienze del nostro passato che sono andate irrimediabilmente perdute? Che si sono volatilizzati come i testi dei filosofi antichi distrutti nel misterioso incendio della biblioteca di Alessandria? Oppure qualcosa si salva come la scatola nera degli aerei dopo le tremende disintegrazioni che seguono alle esplosioni o ai crolli?
Dobbiamo capire se l’oblio della mente è un vuoto che non è più colmabile nonostante i nostri sforzi di recuperare il tempo perduto; se è assolutamente inaccessibile, o se questi vuoti della memoria sono essenziali all’equilibrio psico-fisiologico della nostra vita cognitiva perchè impediscono quella pienezza troppo patologica, strabordante e straripante, di Seresevskij e di altri mnemonisti, che aumenterebbe talmente il potere della nostra memoria da renderlo nemico della memoria stessa, fino a impedirci di parlare della nostra vita con ordine e precisione e addirittura di agire nel mondo da persone normali. E’ forse possibile che questi vuoti così importanti e fisiologici siano al contempo inaccessibili, ma colmabili attraverso strategie mirate del ricordo, attraverso itinerari particolari segnati dentro il fitto bosco della memoria.
Del resto se, come abbiamo detto, l’oblio è, insieme alla memoria, una funzione fondamentale della nostra conoscenza è anche vero che il nostro cervello immagazzina ed elabora un messe straordinaria di ricordi e di informazioni e che tutti noi crediamo di essere persone umane, dotate di un Sé unitario, grazie al fatto che sentiamo di contenere nella mente i fatti della nostra vita e di poterli raccontare a noi stessi e agli altri in qualsiasi momento. Inoltre è stato dimostrato che gran parte del nostro sapere e della nostra vita sta nascosto nella nostra mente in modo inconscio e implicito e che può essere richiamato alla nostra attenzione cosciente quando se ne presenti l’occasione o la necessità.
I ricordi possono emergere in modo involontario. Non si può non ricordare il grande romanzo in sette volumi di Marcel Proust, tutto fondato sulla ricerca di quel ricordo involontario che nasce dall’azione imprevista di certi stimoli sensoriali che ci ricollegano improvvisamente ad alcune esperienze della vita passata. Chiuso nella sua stanza avvolta da pareti di sughero Proust si era immerso in un contesto per lui adeguato al recupero del tempo perduto, delle tracce remote della vita passata che si perdono dentro una nebbia fitta e impenetrabile. Proust si affannò molto a perlustrare la sua memoria attraverso il ricordo involontario e le intermittenze del cuore, riuscendo a risvegliare dal sonno molti eventi remoti come quelli della sua relazione affettuosa con la nonna. Di certo siamo sicuri che questo viaggio all’indietro ha una soglia invalicabile che nemmeno il ricordo involontario può superare. Si sa infatti che il periodo della nostra vita che va dal primo al terzo anno di vita è irrimediabilmente precluso alla nostra facoltà di recupero. Questo fenomeno è quello che si suole chiamare amnesia infantile.
Tutto questo non ci impedisce di supporre che, se anche non ricordano, i bambini registrano tutto nella loro mente in tracce di cui poi perdono la memoria cosciente. Per motivazioni che non possiamo discutere ampiamente in questa sede, a loro resta impossibile accedere ai ricordi. L’introduzione del tema dell’amnesia infantile ci permette di operare due distinzioni chiave: una è quella fra registrazione e ricordo, l’altra è quella fra accessibilità e disponibilità del ricordo.
La prima distinzione è una distinzione che ho sviluppato per dirimere l’ambiguità del termine italiano ricordoe che ho creato sul calco della distinzione presente invece nella lingua inglese fra record e recall. Non è un caso che in psicologia della memoria sia recall il termine usato per ricordo inteso nel senso di recupero cosciente dell’informazione. Il termine ricordoo registrazione si riferisce alla attività di memorizzazione o codifica che può avvenire anche in modo non cosciente e che non ha come conseguenza il fatto che quello che viene registrato possa essere ricordato per il semplice fatto di essere stato registrato.
Quello che avviene al momento della codifica è fondamentale per quello che avverrà al momento del recupero. Questo legame fra codifica e recupero è alla base di una teoria fondamentale formulata da Tulving (1983) che si chiama teoria dell’ecforia sinergica o GAPS, alla cui base sta il noto principio di specificità di codifica: “l’efficacia di un certo suggerimento dipende dalla quantità di informazioni che, in fase di recupero, combacia con le informazioni disponibili al momento dell’aquisizione. In sostanza uno stimolo richiama una esperienza se era effettivamente presente quando facevamo questa esperienza” (Roncato e Zucco 1993, p.82). A questa teoria dobbiamo l’altra importante distinzione fra accessibilitàe disponibilità dei ricordi (Tulving e Pearlstone 1966; Tulving e Thomson 1973). I ricordi possono essere presenti nella mente, disponibili al recupero da parte dei soggetti, ma possono essere al contempo inaccessibili per motivi che dipendono dal modo in cui è avvenuta la codifica, dalla relazione che si viene a creare nel contesto del recupero fra il suggerimento presente in quel momento e l’evento che dobbiamo andare a risvegliare nella nostra mente, dalla presenza o dalla assenza di adeguate strategie di recupero possedute dal soggetto medesimo. Per adesso non possiamo approfondire la complessità dei legami fra codifica e recupero e fra suggerimento e materiale del ricordo, ma dobbiamo concentrarci sul problema generale della permanenza dei ricordi. Dobbiamo chiederci cioè se è vero che tutti gli eventi della nostra vita restano comunque registrati nel nostro cervello o se invece alcune tracce vengono irrimediabilmente cancellate (ipotesi del decadimento della traccia). Nel primo caso tutti i ricordi della nostra vita sarebbero disponibili al recupero in linea di principio, anche se non è detto che essi siano di fatto accessibili. In questo secondo caso il problema è solo come potere accedere dentro l’impenetrabile cassaforte dei ricordi.
Ma è proprio vero che i ricordi sono tutti registrati nella nostra mente? Lo psicofisiologo Karl Lashley “praticava lesioni nelle diverse aree cerebrali per localizzare esattamente gli engrammi, cioè le modificazioni cerebrali responsabili della ritenzione mnemonica. Lashley trascorse 35 anni ad addestrare ratti, gatti e scimmie all’esecuzione di complessi compiti di apprendimento per poi lesionare o asportare specifiche porzioni dei loro cervelli, nell’inutile tentativo di cancellare la memoria delle informazioni apprese” (Gasbarri e Tomaz 2005, p.49. Cfr. anche Lashley 1929, 1950). Dunque il famigerato engramma non esiste e non esiste un correlato neurofisiologico delimitato e circoscritto della traccia della memoria. Se Lashley avesse avuto ragione allora ci sarebbe dovuto essere qualche angolo del nostro cervello una sorta di filmino delle nostre singole esperienze tipo: quella volta che mio padre si litigò con mia madre, quella volta che mi misero un brutto voto a scuola, la gita di istruzione in Grecia fatta con la scuola etc. Se il tentativo di Lashley è fallito, alcune clamorose scoperte hanno mostrato quantomeno che c’è una parte del cervello molto sensibile al ricordo delle esperienze passate e che se, da una parte non esistono engrammi circoscritti e localizzabili, dall’altra esiste un luogo misterioso (il lobo temporale) che adeguatamente stimolato produce dei flashback sorprendenti su porzioni lontane, remote e perdute della nostra vita. Il neurochirurgo canadese Wilder Graves Penfield è il punto di riferimento di questa ricerca.
1.2 L’esplorazione elettrica del cervello vivo.
Penfield doveva curare dei pazienti affetti da epilessia temporale cioè con “crisi epilettiche causate da una scarica avente origine in quel lobo” (Penfield 1975, p. 42). Il trattamento chirurgico dell'epilessia, soprattutto quella di tipo focale, era già stato introdotto da Sir Victor Horsley in Gran Bretagna e da William W. Keen negli Stati Uniti verso la fine dell’Ottocento. Un grande impulso venne dato anche dalle innovazioni nella tecnica neurochirurgica introdotte da Harvey Cushing, che abbatterono i valori di mortalità operatoria a causa degli interventi intracranici. Come ricorda lo stesso Penfield (ibid.) oltre alla tecnica operatoria “l’esplorazione elettrica era una guida particolarmente preziosa nei nostri interventi chirurgici, prima dei progressi dell’elettroencefalografia e dell’elettrocorticografia. Herbert Jasper venne all’Istituto Neurologico di Montreal nel 1935, introducendo la nuova tecnica elettrografica, e la sua inestimabile collaborazione neurofisiologica. Questa cooperazione costruttiva ebbe come frutto anche un libro, Epilepsy and the Functional Anatomy of the Human Brain pubblicato (....) nel 1954”.
Penfield operò in tal modo, dal 1943 al 1960, presso il Montreal Neurological Institute, 1132 pazienti, ottenendo una percentuale di successo del 75%, senza causare gravi deficit funzionali e/o psicologici ai pazienti.
Il risvolto più importante della pratica sistematica dell'elettrostimolazione fu la creazione di una mappa dell'organizzazione topografica del cervello umano per quanto riguarda le aree corticali con funzione motoria (homunculus motorio) e con funzione sensitiva (homunculus somatosensoriale), dimostrando ad esempio che la rappresentazione corticale della nostra sensazione del volto e della lingua e straordinariamente più ampia e più intensa di quella del nostro addome o che la rappresentazione corticale della mano e inferiore a quella del braccio etc.
Non solo dato che la stimolazione di determinate aree del lobo temporale in 53 pazienti era in grado di risvegliare dei ricordi, gli fu possibile formulare un'ipotesi sul meccanismo funzionale della memoria e sulla sua localizzazione cerebrale. Tutte queste scoperte hanno una particolare importanza in quanto eseguite sull'uomo e non su animali, come era avvenuto in precedenza. Come è noto infatti l'organizzazione funzionale del cervello varia da specie a specie in funzione del differente sviluppo della corticalità. Quindi, una ricerca basata sulla pato-fisiologia animale, trasferita in clinica, poteva generare conclusioni spesso inesatte, se non completamente erronee.
Penfield e la sua équipe utilizzavano, come Horsley, la stimolazione elettrica per localizzare esattamente i foci epileptogeni in pazienti portatori di epilessia focale corticale. Ai pazienti veniva applicata una semplice anestesia locale. Il paziente era sveglio sul tavolo operatorio durante la stimolazione delle presunte aree epileptogene. Dunque essi restavano coscienti, perfettamente vigili, capaci di intendere quello che stava accadendo e di sentire il dottor Penfield mentre discuteva con loro, ponendo loro domande e ascoltava risposte e racconti dall’origine misteriosa. Infatti ad ogni stimolazione il paziente rivelava al chirurgo le sue sensazioni. Tutto questo accadeva mentre lui, in una situazione surreale evocatrice di atmosfere alla dottor Caligari, operava con precisione indagatrice e meticolosa curiosità dentro un cervello aperto e vivo. Penfield realizzò immediatamente quanto potesse essere importante questa scoperta per la psichiatria, ma esitava a rendere disponibile le informazioni straordinarie di cui era venuto in possesso. Da scienziato preciso e onesto, egli voleva ottenere molti più dati circa la neurofisiologia di questo stranissimo e sorprendente effetto di reliving. Aspettò ben vent’anni prima di comunicare la sua scoperta, nel 1954, ai colleghi presenti alle Mandsley Lecture tenutesi a Montreal (1).
Una domanda sorgerà certamente nel lettore: ma come facevano i pazienti di Penfield a sopportare le elettro-stimolazioni sul loro cervello se erano anestetizzati solo nella parte del cranio che veniva incisa dal neurochirurgo? E la materia grigia, le terminazioni nervose? Come facevano i pazienti a non sentire dolore, se noi dal dentista saltiamo per aria al minimo tocco del trapano sul nervo della radice? Forse nessuno di voi lo saprà ma “il cervello non contiene ricettori del dolore” (Squire 1987, p. 75-76). La materia grigia è insensibile al dolore al contrario dei nervi di tutto il sistema periferico, soprattutto quelli che raccolgono i neuroni sensoriali. Per questo motivo bastava che i pazienti ricevessero solo un anestetico locale, un pain blocker, e non c’era alcun problema se “rimanevano completamente coscienti durante l’operazione chirurgica” (ivi, p.76).
Nel suo laboratorio Penfield utilizzava lo strumento stereotassico, una sorta di casco fissato alla testa che permette di visualizzare con esattezza le parti del cervello che devono essere stimolate, e gli elettrodi stimolatori per le esplorazioni intracerebrali, seguendo delle coordinate x, y, z. Dal punto di vista chirurgico il procedimento è il seguente: Penfield disegna delle linee tratteggiate sul cranio depilato di un paziente, lo incide, rimuove la calotta ossea del cranio. Poi inserisce gli elettrodi nella corteccia, opera una scarica singola per 60 cicli di 2 volt e monitora in un video l’apparato delle frequenze radio dello pneumoencefalogramma (2). In questo modo Penfield si muove con l’elettrodo sulla superficie del cervello per mapparne le zone.
A volte la stimolazione dell'area o delle aree responsabili dell'irritazione cerebrale ha come risposta l'inizio di un accesso epilettico. In tal modo l'area scatenante era esattamente delimitata e poteva essere asportata con successo. Altre volte “la stimolazione elettrica delle aree interpretative della corteccia produce occasionalmente quel che Hughlings Jackson aveva chiamato ‘stato sognante’ o ‘attacchi psichici’” (Penfield 1975, p.42; cfr. Jackson 1931, 1973; Hogan e Kaiboriboon 2003). Talvolta il paziente ci faceva capire che avevamo prodotto in lui uno stato sognante e noi valutammo ciò come una prova che eravamo vicini alla sede della causa della crisi” (ibid). Le conferme di questa supposizione arrivano anche dalle descrizioni dei pazienti: “Oh, è stato come un attacco (nda epilettico), c’era qualcuno che fumava del tabacco, ma non so chi potesse essere” (Penfield e Perot 1963, caso 23, 637).
Per Penfield questi risultati riguardavano quegli strani fenomeni che il neurologo inglese Hughlings Jackson aveva individuato nella sua lunga pratica clinica con gli epilettici. Jackson aveva chiamato dreamy states (stati sognanti) gli stati di leggera perdita di memoria episodica recente e del normale flusso di coscienza che seguivano alla disritmia cerebrale elettrica. In realtà questo termine generico indicava una serie di fenomeni disparati molto simili fra loro: allucinazioni, stati di coscienza spesso accompagnati da sentimenti e rappresentazioni mentali dotate di grande pregnanza e vividezza o da quella particolare qualità chiamata oneness, che corrisponde ad una sorta di cenestesi del sé ovvero di armonia scaturita dal sentirsi identici a se stessi avvolti in una pace stabile e solida.
Nessuno poteva immaginare che il dato scientifico più importante delle operazioni di Penfield non sarebbe stato il risultato chirurgico e le sue conseguenze terapeutiche sui pazienti epilettici, ma una scoperta, imprevista e stravolgente, scaturita proprio da quel dialogo surreale e dagli stranissimi resoconti dei pazienti. Egli si accorse che il lobo temporale è l’unica zona della corteccia (la sostanza grigia) che reagisce alle stimolazioni elettriche facendo emergere dall’oscurità della memoria dei flashback della vita passata, dei veri e propri relivings in cui i pazienti erano pienamente coinvolti e di cui erano coscienti testimoni. Come dice Squire (1987, pp.76-77): “La stimolazione elettrica della superficie corticale a volte fa sorgere delle immagini che i pazienti hanno descritto come percezioni ed esperienze coerenti. Penfield ha interpretato queste risposte allucinazioni esperienziali come delle veridiche riproduzioni dell’esperienza passata. Inoltre ha supposto che sia la traccia di registrazione di queste esperienze, sia le connessioni neurali che permettono di accedervi, devono essere vicini al luogo stimolato dall’elettrodo. Nella visione di Penfield, le esperienze riprodotte attraverso la stimolazione hanno ripresentato il flusso della coscienza a partire da un episodio antecedente della vita passata. L'elettrodo stimolatore ha delineato la ripresentazione a partire dal suo stesso luogo (nda cerebrale) di immagazzinamento, situazione molto simile a quella in cui un nastro registratore fosse stato inserito arbitrariamente in certi punti” del cervello dei soggetti. Una delle caratteristiche salienti del reliving è il pieno coinvolgimento dell’io dei pazienti. Essi sembrano dei sogni, delle full immersion in una realtà virtuale vissuta secondo coordinate spazio-temporali precise. Per esempio, un paziente riferiva di sentire una canzone, ma di non stare immaginando l’aria producendola da sé, ma di stare ascoltando realmente qualcosa. Nel manuale di Zimbardo e Ruch (1975, pp. 48-49) vengono riferiti in dettaglio alcuni particolari interessanti delle indagini di Penfield: “Siamo nella sala operatoria dell'istituto neurologico de Montreal osservando l’operazione al cervello di Buddy, un giovane uomo con delle scariche epilettiche incontrollabili. Il chirurgo si propone di operare per rimuovere un tumore, ma in primo luogo deve scoprire quali saranno le conseguenze della rimozione di svariate parti del tessuto del cervello che circonda il tumore .... Tutto ad un tratto viene fuori una risposta inaspettata. Il paziente ghigna, sorride, apre gli occhi quando quella zona è stimolata. "Buddy, che cosa è accaduto, che cosa li ha fatti esperienza giusta?" "Dot., ho sentito una canzone, o piuttosto una parte di una canzone, una melodia." "Buddy, lo ha mai sentito prima?" "sì, mi ricordo di averlo sentito molto tempo fa, ma non posso ricordarmi del nome dell'aria." Quando un altro luogo del cervello è stimolato, il paziente ricorda un'esperienza drammatica (trhilling experience) di infanzia con vividi dettagli.
In una operazione similare, una donna “ha rivissuto” l’esperienza avuta nel dare alla luce il suo bambino, come se, spingendo un pulsante elettronico della memoria, il Dr. Wilder Penfield avesse toccato le memorie immagazzinate silenziosamente per anni negli spazi reconditi dei cervelli dei suoi pazienti”.
Le varie componenti sensoriali dell’evento, visive, uditive, olfattive, emergono alla coscienza. Perfino le sensazioni somatiche dell’evento vengono esperite di nuovo. I soggetti riferiscono che la sequenza della stimolazione neurologica si sovrappone ad un flusso che scorre parallelo alla sequenza del tempo reale, come se l’azione andasse avanti e si srotolasse come una pellicola cinematografica. Questo processo memoriale è una “one-way street”, “una strada a senso unico che procede da un punto qualsiasi a partire dal quale la stimolazione apre un ingresso dentro di essa” (Penfield 1955, p. 453). Penfield stesso paragona questo movimento in avanti ad un film: “Fu subito evidente che non si trattava di sogni. Era un’attivazione elettrica della registrazione sequenziale della coscienza, registrazione che era stata impressa durante un’antecedente esperienza del malato. Il paziente ‘riviveva’ tutto quello in cui era stato consapevole in quel periodo passato, come in un flashback cinematografico.
La prima esperienza di questo tipo accadde nel 1933. Una madre disse che non appena l’elettrodo aveva toccato la corteccia “era all’improvviso conscia di essere in cucina, mentre ascoltava la voce del suo bambino che giocava fuori nel cortile. Avvertiva inoltre dei rumori circostanti, come ad esempio di automobili che potevano rappresentare un pericolo per il figlio”” (Penfield 1975, p. 42).
L’esperienza continua fino a che lo stimolatore non viene estratto e si può ripetere più d una volta se l’elettrodo viene ripiazzato dopo un breve intervallo. Penfield credeva che questa corsia compatta della memoria fosse stata “in qualche modo condizionata da anni di scariche elettriche provenienti da un vicino focus epileptogenico” (Penfield 1955, p. 453) e perciò collega il fenomeno alla teoria della plasticità di Hebb (1946): “«Si è tentati di credere (...) che da ogni nuova esperienza venga stabilita una facilitazione sinaptica». Se così fosse, quella facilitazione permanente potrebbe guidare un flusso di impulsi neuronali susseguente, attivato dalla corrente elettrica dell’elettrodo, anche anni dopo” (Penfield 1975, pp. 52-54).
Il meccanismo della facilitazione è collegato direttamente all’ idea che i ricordi restino integri nella mente anche dopo lunghissimo tempo: “è chiaro che l'azione di un neurone che accompagna ogni successivo stato di coscienza lascia la sua impronta permanente nel cervello. L’impronta, o ricordo, designa un percorso di facilitazione dei collegamenti neuronali che può essere ripercorso molti anni più tardi attraverso una corrente elettrica, senza perdita di dettagli, come se tutto questo fosse stato conservato nel nastro di un registratore.
Consideriamo adesso quello che succede nella vita normale. Per un tempo breve, un uomo può ricordare tutti i dettagli presenti del suo stato di coscienza appena passato. Dopo alcuni minuti parte di esso sarà svanito aldilà del raggio di azione della sua volontà. Dopo settimane sembrerà che, fino limitatamente al suo ricordo volontario, tutto si è dileguato, tranne quello che gli sembrava importante o che ha scosso la sua emotività. In verità il dettaglio non è andato perduto. Durante l’interpretazione subconscia di una più tardiva esperienza contemporanea, questo dettaglio è ancora disponibile. Questo è una parte di quello che noi possiamo chiamare percezione” (Penfield 1969, p. 165).
1.2. Risposte esperienziali e risposte senso-motorie.
Grazie a Penfield possediamo un vasto repertorio dei resoconti dei soggetti, repertorio documentato e scientificamente valido, non affidato a tradizioni orali o a riferimenti di seconda mano: “Un giovane dichiarò che stava seduto ad assistere un partita di baseball in un piccola città e osservava un bambino che si infilava sotto lo steccato per andare fra il pubblico. Un altro che si trovava in una sala da concerti ascoltando musica. “Un orchestra”, spiegò. Poteva distinguere i diversi strumenti.” (Penfield 1975, pp. 42-43).
Invece “la paziente D.F. sentiva degli strumenti che suonavano una melodia. Tornai a stimolare lo stesso punto trenta volte (!) cercando di fuorviarla e dettando ogni volta la sua risposta ad una stenografa. E ogni volta che tornavo a stimolare quel punto, lei sentiva di nuovo la melodia. Cominciava dallo stesso punto e andava avanti, musica e parole. Quando lei cantava a bocca chiusa il ritmo era quello giusto” (Penfield 1975, p. 43).
Un caso esemplare presente anche in Penfield (1958) è quello di M.M., una giovane donna di ventisei anni affetta da crisi che iniziavano con una sensazione di familiarità, seguita da una paura e da un breve sogno di qualche esperienza passata. Dopo aver operato l’incisione e aver liberato l’emisfero destro dal cranio, Penfield esplora con l’elettrodo le zone ricettive del cervello di M.M. e segna con dei numeri quelle in cui ottiene una risposta di qualche tipo. Il punto n.2 provoca un formicolio nel pollice sinistro, il n.3 un formicolio nel lato sinistro della lingua, al 7 un movimento della lingua. Mentre queste risposte sono di tipo senso-motorio e rivelano che Penfield aveva toccato aree della circonvoluzione somato-sensoriale o motoria,il lobo temporale forniva delle risposte definite “psichiche” cioè che avevano a che fare con le funzioni cognitive superiori della memoria e della coscienza. Gli esempi, forniti per ogni punto dell’emisfero destro sono i seguenti:
“ 11- «Ho udito qualcosa , non so cosa fosse».
11-(stimolazione ripetuta, senza preavviso) «Sì, credo d’aver udito una madre che in qualche posto chiamava il suo bambino. Sembrava qualcosa accaduto anni fa». Richiesta di una spiegazione, la paziente rispose: « Era qualcuno del vicinato, dove io abito». Poi aggiunse: « Io stesso ero là, abbastanza vicina da sentire».
12 - «Sì, ho sentito delle voci laggiù, in qualche posto lungo il fiume; la voce di un uomo e la voce di una donna che chiamavano ...... credo d’aver visto il fiume».
15- « Appena un lampo d’una sensazione di dimistichezza e la sensazione che sapevo tutto quanto sarebbe successo nel prossimo futuro».
17c- (Un ago elettricamente isolato tranne che sulla punta, venne inserito profondamente nella fissura di Silvio, nella superficie superiore del lobo temporale, poi venne data la corrente) « Oh! Ho riavuto lo stesso ricordo tanto tanto familiare, in un ufficio, da qualche parte. Vedevo le scrivanie. Ero lì e qualcuno mi chiamava, un uomo appoggiato a una scrivania con una matita in mano ». Avvisai la paziente che stavo per stimolare, ma non lo feci: «Niente ».
18a- (stimolazione senza preavviso) « Ho avuto un breve ricordo; la scena di una commedia; parlavano e io la vedevo, ma la vedevo proprio, nel ricordo».” (Penfield 1975, p.43).
Penfield chiama questo tipo di risposte esperienziali (experiential answers) per distinguerle dalle risposte di tipo sensoriale o motorio. Quest’ultimo tipo di risposte segue una stimolazione delle aree dell’omuncolo somatosensoriale e dell’omuncolo motorio per cui se viene toccata la zona deputata alla sensibilità della lingua nel primo omuncolo, il paziente avverte un formicolio nella lingua medesima; mentre se viene toccata la zona del movimento della mano sinistra presente nel secondo omuncolo il paziente muove la mano sinistra (3).
La risposta esperienziale è molto più complessa. Essa riguarda il ricordo di esperienze avute dal soggetto o la percezione di esperienze che il soggetto sente come parte della propria stessa vita. A differenza dalle risposte senso-motorie, alla risposta esperienziale manca quella corrispondenza sperimentale, biunivoca, infallibile e reiterabile tra la zona del cervello stimolata e l’output che ne scaturisce. Infatti dalla lettura di molti casi ci si rende conto come siamo di fronte ad una grande variabilità di tipi di risposte esperienziali, differenziabili sia per modalità sensoriale che per maggiore o minore vividezza percettiva. Penfield ha fornito una divisione per modalità stabilendo quattro categorie di risposte: “uditive (voci, musica o un suono senza senso), visive (la gente, una scena o un oggetto riconoscibile), uditive e visive combinate (scene insieme a suoni pertinenti) o risposte esperienziali non classificate (un pensiero, una memoria, o un flash-back)” (Squire 1987, p.77). In Penfield e Perot (1963) questa classificazione è applicata ai dialoghi svolti con 40 soggetti di cui 24 con risposte esperienziali di tipi uditivo che asserivano di sentire voci, suoni, o suoni senza un preciso significato e 12 soggetti con risposte esperienziali di tipo combinato, uditivo e visivo insieme. I restanti 5 pazienti riferiscono cose vaghe, non relate ad alcuna immagine concreta, ma alla supposizione di “un pensiero”, di “una memoria”, di “un flash-back” dicendo che lo stimolo “ha riportato alla mente qualcosa”.
Il caso 1 è quello, già citato sopra, della donna che rivive l’esperienza del parto e che “percepiva il fatto di star rivivendo quell’esperienza” in prima persona (Loftus e Loftus 1980, p.414). Il caso 19 riferisce un’altra risposta esperienziale di tipo visivo-uditivo in cui gli elementi percepiti sono svariati: una persona, un gruppo di persone, una scena, un oggetto dalla forma familiare e riconoscibile. Il paziente dice ad esempio di aver visto un uomo da lui conosciuto mentre afferrava un bastone. Il caso 36 è una donna che si esprime così: “Io penso di aver sentito una madre chiamare il suo piccolo ragazzo da qualche parte. Sembrava che fosse qualcosa accaduto anni fa” (ibid.) e riferisce pure che c’era “qualcuno vicino a dove vivo” (ibid.).
Il caso n.9 è uno dei 12 con sola risposta di tipo uditivo riferita da una donna che esclama: “Oh, una sorta di suono lontano come di persone che cantano”. Quando le viene chiesto cosa senta precisamente risponde: “Non so. E’ come una raccolta di vecchie canzoni popolari in sottofondo, probabilmente sono degli inni” (ibid).
Dopo aver analizzato le risposte, Penfield e Perot (1963, p.672) avanzano l’ipotesi che molte di questi resoconti “consistono in una esperienza che il paziente può riconoscere facilmente e identificare come se fosse stata parte di una esperienza precedente”. Questo fatto emerge dalle frasi dei pazienti che posseggono un tono equivalente di partecipazione cosciente da parte dei pazienti: “Oh! Io avevo la stessa memoria molto, ma molto familiare! In un ufficio, da qualche parte in qualche posto. Io potrei vedere le scrivanie. Ero lì e qualcuno mi stava chiamando, un uomo che studiava su un tavolo, con una matita nella mano”.
1.3 La parentela tra i relivings e sogni.
Squire (1987, p. 78) ricorda che molte rievocazioni hanno caratteristiche in comune con quanto avviene nei sogni. Nel suo trattato di neuropsicologia Benedetti (1969=1972, p. 60) descrive molto bene le parentele fra i relivings di Penfield e i sogni:
“ La rievocazione quasi-allucinatoria del passato è nei suoi termini generali un fenomeno fisiologico: infatti avviene innumerevoli volte nel corso dei sogni. Talora il soggetto è cosciente del carattere quasi-allucinatorio delle sue esperienze; egli rivede la madre morta da anni, risente voci e rivive scene significative del passato e “crede di sognare”; altre volte non si rende conto di trovarsi in una realtà diversa dal suo presente attuale e la rievocazione è allora del tutto allucinatoria. Il significato di questi ritorni del passato nei sogni è ben noto a chi ha esperienza di psicoterapia. E’ una delle qualità fondamentali dell’uomo,quella di poter continuare, nei sogni, l’elaborazione del passato. Le sue esperienze significative ritornano e trovano adesso nuove risposte e nuove integrazioni”.
Un ragazzo di 12 anni aveva degli attacchi epilettici preceduti dalla vista di un ladro che si muoveva verso di lui. Questa esperienza si ripete quando Penfield tocca con l’elettrodo la porzione posteriore del lobo temporale sinistro: “ Oh non posso crederci, mio Dio, dei ladri con le pistole stanno venendo verso di me” (ivi, Caso 3, p.616). Una stimolazione in un altra zona del lobo temporale provoca il ricordo di una conversazione fra sua madre e sua zia, ascoltata così per caso come in un sogno. Il ragazzo dice che la zia sta invitando la mamma ad andare a farle visita e riferisce che egli comprende che si tratta di una telefonata solo grazie al modo in cui la zia parla e modula il suono della sua voce. L’esperienza avvertita ha le caratteristiche di una esperienza onirica in cui eventi che normalmente si dovrebbero percepire in successione temporale attraverso una combinazione di immagini e di suoni riferibili anche se legati in modo imprevedibile e discontinuo, vengono invece percepiti in modo simultaneo, olistico, intuitivo.
Sono gli stessi pazienti che rivelano direttamente di percepire il reliving come un sogno. Il caso 2 stimolato per la quinta volta sulla superficie posteriore del giro temporale superiore sinistro ha riferito di “Voci di persone che parlano”. Alla sesta stimolazione ha riferito che “ora li sento....E’ un po’ come se stessi sognando” (Penfield e Perot 1963, caso 2, p.614). Il caso 22 riferisce “Io sto avendo dei sogni...sto sentendo delle cose...sto sognando delle cose” (ivi, p.635). Il caso 25 è una donna che esordisce dicendo: “Sta cominciando un sogno. Ci sono molte persone”. Dopo aver riferito che non sa cosa si stanno dicendo queste persone le viene chiesto se sa almeno dove stanno e lei: “Nel soggiorno. Io suppongo che uno di loro sia mia madre” (ivi, p.638). Squire (1987, p.78) nota che, come nei sogni, alcuni pazienti non ricordano i dettagli e sentono che il racconto del loro reliving non può essere colmato in alcun modo, ma deve essere riferito così per come lo hanno vissuto: un miscuglio di percezioni chiare e confuse che danno alla persona una sensazione forte di familiarità, tanto forte quanto poco ricca di riscontri autobiografici chiari. Il caso 8 conferma questa prospettiva. La donna, stimolata nella superficie superiore del lobo temporale sinistro, parla di un uomo che prede forma nel suo stato sognante: “Aveva il suono di una voce che pronunciava delle parole, ma questa voce era talmente fievole che non potevo afferrarne niente”. Penfield ripete la stimolazione per 15 secondi. La paziente allora afferra qualche parola. Capisce un nome e lo ripete più volte: Jimmy, Jimmy, Jimmy”. E’ suo padre, lei ne è sicura. La sta chiamando. Jimmy è lei. Lei in persona!
Un ragazzo di 19 anni dice. “Sento parlare qualcuno...Penso che questo debba essere come un ristorante o qualcosa....” (Penfield e Perot 1963, caso 13, 627). Un altro: “Sì....Qualcosa veniva detto e io sapevo che cosa veniva detto, ma non riesco a tradurlo in parole” (Penfield e Perot 1963, caso 14, p.629).
In uno dei suoi esperimenti Penfield pensò di nascondere l’elettrodo. La paziente non sentiva nulla. Penfield credeva che la paziente non sarebbe riuscita a indovinare che cosa stava succedendo quando avrebbe tolto l’elettrodo dalla corteccia cerebrale. In altri casi invece verificava se una nuova stimolazione riproponeva la stessa risposta esperienziale. Per esempio “L.G. vedeva un uomo che faceva a pugni. Quando il punto veniva ristimolato egli vedeva un uomo e un cane che passeggiavano lungo la strada" (Penfield 1955, p.455). Questo vuol dire che non c’è una continuità fra stimolazione e risposta e il nastro della memoria non innesca un flusso continuo dell’evento, ma delle tracce che hanno il sapore della familiarità.
Penfield (1975, p.67) rivela che la sua curiosità per il cervello e per la mente iniziò, durante la sua specializzazione in filosofia, grazie alla lettura dei “Principi di Psicologia” di William James (1910). James aveva paragonato il flusso di coscienza ad un fiume che scorre ininterrottamente durante le ore di veglia. Penfield corregge la metafora perchè un fiume non può subire modificazioni da parte dell’uomo, mentre “pensiero, ragione, curiosità invece possono far sì che la corrente di coscienza alteri il suo corso e muti completamente il suo contenuto” (ibid.). Il fiume della coscienza imperversa dalla sorgente della vita passata e cambia continuamente direzione, capienza, intensità. La mente può in qualsiasi momento aprire la diga di questo fiume e far scorrere flussi di coscienza intimamente legati alle esperienze del ricordo del passato.
Le stimolazioni elettriche e le scariche epilettiche erano per Penfield la strada per entrare dentro a questo fiume dilagante, navigando nel suo letto tumultuoso. Il ricordo emerge da questa continua fluttuazione in modi che non sono regolati da leggi di causalità standardizzabili. Talvolta il paziente può rievocare un evento senza sapere però a quale contesto o periodo della vita esso appartiene. Per esempio, la musica sentita è familiare, viene avvertita come parte della propria esperienza passata, ma il paziente può restare incapace di collegare con precisione questa musica ad un evento preciso della sua vita, all’occasione reale di cui egli assapora soltanto una sensazione di estrema familiarità. Di norma gli eventi che erano imbevuti di sensazioni, erano emozioni e normalmente esperienze che erano avvenute routine (nessuna emozione forte veniva licitata) non potevano essere richiamate con facilità. Il ricordo suscitato elettricamente differisce da quello naturale per il fatto che spesso produce delle sequenze esperienziali casuali. Per esempio uno dei pazienti sentiva una selezione di musica molto strana e particolare, che gli sembrava eseguita da un’ orchestra perchè il suono era nettamente fruibile dal suo udito ed era talmente vivido e chiaro che il paziente credeva che ci fosse un fonografo dentro la sala operatoria. Quando lo stesso punto veniva nuovamente stimolato la musica cominciava dallo stesso lasso di tempo da dove era cominciata la prima volta. E’ molto interessante sapere che, in generale, la percezione della musica da parte dei pazienti, non avveniva solo ad un puro livello uditivo superficiale, ma metteva in gioco anche il feeling emotivo e le sensazioni profonde dei soggetti legate all’ascolto del motivo musicale Anche se la sorgente da cui proviene la musica è ignota, il senso di godimento e di benessere accompagna il fluire della sequenza musicale nel passato rivissuto ed è avvertito nel qui ed ora dell’esperienza cosciente, e dunque anche di quella emotiva e affettiva.
La mente cosciente della persona che subisce l’intervento realizza che è nella stanza operatoria. La comprensione della memoria precedente è chiara, l’interpretazione di quello che succedeva nel punto del tempo passato è compreso e sentito con l’accompagnamento di sensazioni e di emozioni. Perciò la risposta è veramente esperienziale, in prima persona e allo stesso tempo interpretativa, in terza persona. Il soggetto non parla solo del che cosa sta rivivendo, ma parla anche del modo in cui lo sta rivivendo. Anzi egli ne parla mentre lo rivive, dal di dentro e non dal di fuori dell’evento. Da molti resoconti dei pazienti si percepisce che la loro esperienza non è quella di un uomo che rivede le scene della propria infanzia proiettate su uno schermo da un filmino. Sono i pazienti che agiscono nel ricordo, come se fossero penetrati dentro una realtà virtuale. Per questo navigano contemporaneamente sul livello mnemonico del ricordo e finanche sul livello meta-cognitivo della coscienza che gli permette di farsi delle domande e di riflettere sul fenomeno del reliving che stanno sperimentando.
A mio modo di vedere l’ analisi completa deve andare oltre un esame puramente neurofisiologico o neuropsicologico. Essa richiede anche un approccio di tipo linguistico-testuale e di tipo cognitivo-teorico. Occorre capire bene cosa dicono esattamente i pazienti e quale sia la correlazione fra i loro testi, i loro racconti e l’attivazione di funzioni cognitive molto alte come la memoria e la coscienza. Vediamo allora in cosa consistono queste risposte esperienziali che coinvolgono l’io dei pazienti nel rivivere eventi del passato in prima persona.
1.4 Ricordo di esperienze realmente vissute o allucinazioni?
Come abbiamo visto dal brano sopra citato Benedetti (1969=1972, p.60) aggiunge i tratti dell’allucinazione alle parentele fra reliving e sogno. Vedremo come questa terza dimensione percettiva sia fondamentale per una corretta interpretazione dei fenomeni scoperti da Penfield. Per adesso è importante comprendere che le somiglianze con i sogni aprono la strada una analisi delle memorie risvegliate in termini ricostruttivi. Benedetti fa l’interessante osservazione che i pazienti che reagiscono alla stimolazione elettrica della corteccia con allucinazioni mnestiche, sono contemporaneamente consapevoli sia della scena vividamente rievocata sia della situazione in cui essi si trovavano, ovvero l’allucinazione sperimentale si inserisce nell’esperienza presente. Per Benedetti altri esperimenti “ammettono un’interpretazione diversa della stimolazione temporale: quest’ultima provocherebbe fenomeni allucinatori, di deja vue , etc., non solo mediante l’attivazione di tracce mnemoniche, ma anche trasformando associazioni presenti in fatti pseudomnenomici” (ibid.). Anche se Mahl ha dimostrato “la manipolazione della situazione presente influenza l’esperienza mnemonica” (ibid.), questo fatto non incrina la teoria di Penfield, la quale “piuttosto si arricchisce dell’osservazione che non solo la stimolazione elettrica della corteccia “interpretativa” (vedi lobo temporale), ma la concomitante stimolazione sensoriale ed esperienziale sfocia nel fenomeno globale” (ivi, p. 61).
Penfield parla di due correnti di coscienza che sono simultaneamente afferrate dal soggetto nel loro reciproco rapporto: “Il flashback è una risposta alla stimolazione elettrica, non intrattiene nessuna relazione con l’esperienza presente all’interno della camera operatoria. In quel momento la coscienza è doppia, e il paziente può discutere intorno al fenomeno. Se egli sta sentendo della musica, egli può canticchiare a tempo con questa. L’aspetto sorprendente del fenomeno è che infine egli è cosciente di tutto quello che stava nella sua mente durante un precedente intervallo di tempo. Quest’ultimo è il flusso di coscienza precedente che ha ricominciato a scorrere. Se viene sentita della musica, essa può consistere in un orchestra, in una voce, in un piano. Qualche volta egli è cosciente di quello che stava vedendo in quel momento, altre volte solo della musica. Questo flusso si arresta quando l’elettrodo viene tolto e può ripetersi anche parecchie volte quando viene ripiazzato senza un intervallo troppo lungo. Il ricordo elettrico è completamente casuale. La gran parte delle volte l’evento non era né significativo, né importante” (Penfield 1969, p. 152). Non c’è una interferenza di altri flussi di coscienza, ma anzi si dà solo contemporaneità di più flussi di coscienza. Così una donna vede sua figlia ancora piccola mentre gioca nel cortile. Mentre assiste a quella scena il suo flusso di coscienza è attirato contemporaneamente del suono delle auto che passano in una strada vicina (Penfield 1955, p. 455). In un altro caso un uomo si sorprende mentre ascolta la conversazione di alcuni suoi parenti mentre ridono e si divertono. Nello stesso tempo si ritrova in un ospedale convalescente dopo un intervento chirurgico. Anche se egli si sforza in tutti i modi di capire perché i suoi parenti sono di buon umore egli non ci riesce (ibid.).
Questo fenomeno della “doppia coscienza" potrebbe costituire una conferma sperimentale alle ipotesi neo-dissociazioniste attualmente in voga nello studio degli Stati di Coscienza. A noi interessa come questo costanza e questo intreccio tra flussi di coscienza diversi confermi ancora di più la caratteristica della piena familiarità dei relivings per i pazienti elettrostimolati.
Come abbiamo visto quasi tutti i pazienti avvertono una sensazione di familiarità rispetto alle scene dei relivinsg anche se non riescono a capire bene cosa dicono le persone che vedono o quali siano queste persone. Questo fatto aumenta la stranezza del fenomeno della doppia coscienza. Infatti i pazienti “non perdono mai la coscienza di essere in una sala operatoria e della realtà immediata” (Squire 1987, p.78) che li circonda fisicamente. Un paziente si esprime così: “Io sento che è come se stessi andando incontro ad un attacco”. Poi gli viene chiesto perchè e lui risponde: “Quella musica, dalla scena colpiscono i Guys and Dolls, e dice che è come quando la stava ascoltando in un episodio della sua vita passato. Quando gli viene chiesto se gli sembra di trovarsi lì o se sta solo ricordando tutto ciò il paziente non ha dubbi: “E’ come se fossì lì” (Penfield e Perot 1973, Caso 37, p.653). Un altro paziente esclama: “Sì dottore, sì dottore! Ora sto sentendo delle persone che ridono-miei amici che stanno in Sud Africa”. Il dottore gli chiede se li riconosce: “Sì sono due cugini, Bessie e Ann Wheliaw”. Secondo il paziente i cugini stavano ridendo proprio perchè lui non sapeva perchè ridevano (ivi, Caso 38, p.654).
Come fa notare Squire (1987, p.79) queste scene familiari sono “spesso inframmezzate da situazioni estranee o addirittura irreali e fantastiche”. E’ il caso del paziente che dice: “Sì. Io sento la stessa donna familiare che chiama. La stessa signora (la stessa che il paziente aveva sentito un momento prima quando era stato stimolato lo stesso punto) quella non era nelle vicinanze. Sembrava stare in un deposito legnami.....io non sono mai stato vicino ad un deposito di legna” (Penfield e Perot 1973, Caso 36, p. 651).
(continua in Scenari-Esperimenti))