| Segnala il documento | Stampa | ||||
| Sette piccoli ostacoli per chi vuole pensare il futuro |
| di Sara Fortuna |
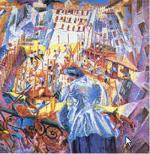
Forse ricorderete che, alcuni anni fa, nel tentativo di far fronte alle sfide del passaggio di secolo e di millennio, la stampa italiana e quella di altri Paesi europei hanno per un breve periodo eletto il futuro a proprio tema di analisi e discussione. In quel periodo (che possiamo, in modo approssimativo, delimitare tra l’ultimo trimestre del 1999 e la fine del 2000) mi trovavo a Berlino e gestivo insieme a un collega una rivista online, “Futuri”, per la quale ho seguito con una certa attenzione il fenomeno sui giornali tedeschi e italiani.
Alla base dell’attività di prevedere gli sviluppi futuri degli eventi in settori cardine dell’economia, della società e della tecnologia fu, in quell’occasione, identificata una capacità cruciale e ancora poco sviluppata degli esseri umani; per farvi riferimento il “Financial Times Deutschland” coniò il neologismo “futurità” (“Futurität”) per indicare un determinato tipo di mentalità orientata al futuro e sostenne che acquisirla sarebbe stato un passo necessario per far fronte al nuovo millennio.
Strettamente associata alla flessibilità e alla capacità di innovare, di ampliare e ristrutturare continuamente le proprie conoscenze, la futurità è stata, a ragione, considerata un’attitudine che manca ancora alla maggioranza degli abitanti del pianeta e certamente a buona parte degli europei per una serie di ragioni che cercherò qui di analizzare.
Vorrei far notare che nel trattare la questione futuro i giornali assumevano spesso toni allarmistici. L’impressione è che si identificasse il compito da eseguire con il dare ai lettori un avvertimento di questo genere: se non si fossero adeguati, imparando a fare fronte alle nuove esigenze di una società e di un mercato del lavoro in continuo mutamento sarebbero incorsi in sicura rovina.
Il titolo con cui il quotidiano “Repubblica” aveva battezzato i suoi supplementi di inglese e di computer giudicati evidentemente gli strumenti più indispensabili per far fronte all’imminente futuro suonava sì volutamente tranquillizzante: “Futuro no problem”. Ma la stessa formula letta alla rovescia suggeriva piuttosto che, se non si fossero fatti una serie di passi indispensabili (l’apprendimento di un inglese e di conoscenze informatiche di buon livello in quel caso), il futuro avrebbe piuttosto portato problemi gravi, di difficilissima soluzione.
Non è infrequente che un addestramento di tipo pavloviano venga utilizzato anche per far acquisire una nuova abitudine di ordine culturale, un nuovo modo di pensare o, potremmo anche dire, un meme (unità culturale, secondo i teorici evoluzionisti come Richard Dawkins, creatore di questa nozione, almeno in parte paragonabile, per modalità di propagazione, al gene, v. Ianneo 1999).
Questa è stata ed è ancora, mi pare, la strada seguita per lo più anche dai mezzi di informazione che, per convincere i lettori che devono adattarsi a guardare al futuro e procedere con il suo stesso ritmo serrato, creano in essi un condizionamento negativo, producendo un certo di tipo di credenze che evocano scenari apocalittici per chi non fosse capace di adeguarsi e suscitano, di conseguenza, sentimenti di paura e di disagio.
C’è da chiedersi se questa sia davvero la strategia migliore, in particolare per un tema come il futuro. In questo modo per almeno buona parte delle persone si delineerebbe un’alternativa inaggirabile assai poco attraente e che, cosa che qui più conta, non è invece tale: forzarsi a pensare al futuro come a un gioco estremamente ed esclusivamente competitivo la cui posta è tentare di adeguarsi a trasformazioni sempre più rapide (prospettiva che suscita una grossa ansia, ma anche, in molti, un rifiuto per lo stesso modello e per l’atteggiamento a esso associato, reputato, allo stesso modo, indispensabile) o non pensarci affatto, assicurandosi – o almeno così gli si dice - un inevitabile fallimento sociale o anche asserragliandosi per difesa dietro categorie e griglie interpretative, categorie che, prescindendo qui dal loro valore pratico ed epistemologico, vengono applicate a tutto tranne che alla realtà, al mondo in cui chi le usa si trova e si troverà a vivere e ad agire, anche grazie al modo in cui quella realtà e quel mondo sono stati pensati e progettati.
Per questa ragione è forse opportuno fare un passo indietro. E chiedersi anzitutto perché è così difficile acquistare una mentalità futurologica e se si tratti di un’unica mentalità o di più atteggiamenti e modalità di interazione. Sembra infatti che la stessa nozione di futuro sia scindibile in più concetti e che dunque tutti i “futuri” che ci vengono proposti (e mediatamente imposti) in un unico blocco siano effettivamente dimensioni tra loro distinte.
Invece di assumere toni allarmistici è bene avere chiaro il fatto che non solo nessuno ci ha mai insegnato il gioco, anzi i giochi, numerosi, attraverso cui ci rivolgiamo al futuro e ci apriamo alla ‘futurità’, ma che ci è stata anzi trasmessa in molti casi l’idea che si tratti di un territorio tabù, una zona limite che è arduo varcare: per farlo è necessario superare diversi sbarramenti, prove multiple di difficoltà crescente, un po’ come quelle che devono superare gli eroi dei miti o delle favole per arrivare alla meta.
La morte e il controllo impossibile (1)
Il primo ostacolo per chi vuole guardare al futuro è banale, ma non per questo poco significativo. Chi guarda avanti, lungo il percorso lineare con cui si è soliti rappresentare il futuro, incontra e oltrepassa ben presto un evento di fronte a cui distoglie istintivamente lo sguardo, la propria morte. Questo tipo di resistenza rispetto al futuro è ben sintetizzato in diverse versioni di un mito greco, in cui forse sarà capitato di imbattervi già negli anni del liceo classico. Una delle tante varianti racconta che gli esseri umani chiesero un giorno alla divinità il dono di poter vedere in anticipo il futuro e che la divinità benignamente glielo concesse: gli umani si chinarono allora su un grande specchio e lì dentro scorsero il loro futuro. Subito la terra risuonò di pianti e lamenti: nello specchio gli esseri umani avevano visto sciagure per sé, per i loro amici e i loro familiari e naturalmente la morte, fine a cui tutti gli umani sono destinati. La morale della favola, riassunta nella formula finale: “o mythos legei”, “la favola insegna”, suona dunque che è meglio non conoscere il futuro.
E’ opportuno ricordare che il contesto culturale che fa da sfondo a questa narrazione è quello di una società in cui le forme di controllo e di influenza sugli eventi futuri sono infinitamente più limitate rispetto a oggi. Esiste una relazione precisa tra l’atto di prevedere gli eventi futuri e la possibilità di agire in modo tale da esercitare su di essi un’influenza e modificare così il loro corso. Quanto più gli individui avvertono di non aver alcuno o uno scarso controllo sul futuro degli eventi in settori fondamentali come la salute o le fonti di sussistenza (per lungo tempo costituite da pastorizia e agricoltura), tanto più si avrà una difficoltà psicologica a immaginare eventi futuri e si svilupperà un insieme di pratiche magiche nel tentativo di esercitare un’influenza benefica per gli esseri umani su fenomeni naturali come il clima e il raccolto o su eventi sociali come fondazioni di città, guerre, etc.
Ma se questo è vero, e va preso nella dovuta considerazione nel riflettere sui modi più efficaci di superare le resistenze rispetto all’acquisizione di un generale orientamente alla previsione, è altrettanto innegabile che il senso di non avere un controllo pieno e assoluto sugli eventi, sul futuro proprio e altrui, è prodotto antropologicamente comune dell’identità e strutturazione psicologica degli esseri umani. E in ogni società, anche nell’illuminato Occidente di oggi, vi sono figure che impersonano ed esaudiscono il bisogno di avere responsi sugli eventi futuri che non sono il frutto di valutazioni razionali: maghe, cartomanti, sibille, oracoli e aruspici esercitano da millenni questa funzione, formulando risposte che hanno spesso la forma ambigua dei resoconti onirici proprio perché probabilmente rendono conto dell’inclinazione a entrare in contatto con il sapere dell’inconscio e con le sue specifiche forme di simbolizzazione che, come ha rivelato la psicanalisi, costituiscono una dimensione costitutiva di ogni soggetto umano.
Poiché dunque le barriere psicologiche a immaginare il futuro a medio e lungo termine sono un retaggio antico, hanno cioè costituito un atteggiamento primario degli esseri umani per migliaia di anni e, soprattutto, derivano da caratteristiche antropologiche che appaiono culturalmente invariabili, non stupisce che, anche in tempi in cui le possibilità di controllo e prevenzione sono enormemente superiori, esse rimangano parte integrante della struttura psicologica degli esseri umani.
In effetti guardare al futuro è ancora oggi per molte persone un tabù. Si evita di prevedere anche dove ciò è possibile a causa di una paura superstiziosa che si appoggia sull’idea irrazionale che un fatto probabile di cui non si sa nulla rimarrà un fatto inesistente, non si verificherà. Perciò, in campi particolarmente minacciosi come le malattie, le persone rifiutano deliberatamente di sapere in anticipo se sono soggetti a rischio, anche quando sono invitate a farlo ed è ovviamente per loro vantaggioso farlo. Lo scarso successo delle campagne di prevenzioni dei tumori e di altre malattie dipende soprattutto da questo.
E’ assai probabile che neppure nei decenni a venire, in cui i progressi della ricerca in campo genetico permetteranno di allungare enormemente la vita, di prevenire gravi malattie e perciò di controllare e determinare buona parte del futuro delle persone, questa atavica resistenza psicologica degli umani sarà abbattuta.
Si tratta allora di interrogarsi sui modi più efficaci per eliminarla, articolando con contenuti adeguati la ricetta generale dell’Illuminismo: quella dell’istruzione nella doppia direzione del suo miglioramento qualitativo e della diffusione capillare nell’intera società globale.
Il punto di vista senza futuro: lo sguardo del dio dei filosofi (2)
Nelle società del passato e nelle comunità religiose tuttora esistenti si contrappongono due punti di vista riguardo al futuro: quello degli esseri umani, che sono incapaci di prevedere il futuro se non grazie alla rivelazione della divinità e quello di una divinità onnisciente per cui la capacità di conoscere il futuro fa parte della sua stessa natura.
La divinità, ovviamente non è in grado di prevedere il futuro, se la cosa viene espressa così è a causa di una proiezione antropomorfa: è l’essere umano, essere temporale, che chiede a Dio di svelargli il proprio futuro. Il punto di vista di Dio è viceversa uno sguardo da nessun tempo e da nessun luogo. La divinità non assume una prospettiva spaziale o temporale, ma è piuttosto la totalità eterna di tutte le prospettive.
Proprio questa concezione della divinità e la riflessione metafisica a cui ha dato vita sono incompatibili con una visione orientata al futuro. In questa concezione della divinità il futuro infatti scompare, il tempo scompare: la divinità coincide con la totalità del mondo, dello spazio e del tempo e la filosofia è il tentativo di pensare questa totalità. La filosofia di Spinoza ha portato alle sue conseguenze più radicali questa concezione metafisica della divinità. Nell’atto di comprensione della totalità la visione del filosofo coincide con la visione della divinità che è a sua volta tutt’uno con la totalità del mondo.
La mistica di Eckart esprime questa intuizione attraverso la formula secondo cui l’occhio con cui guardo Dio è lo stesso da cui lui mi guarda. Riprendendo l’immagine eckartiana, Hegel descritto la sua filosofia come realizzazione dell’identità con lo sguardo assoluto della divinità (ab-solutus, sciolto da ogni legame, da ogni prospettiva determinata). Per fare questo la filosofia si deve porre, secondo Hegel, nel punto in cui tutto è già avvenuto, nel punto in cui il tempo diventa eternità. E’ in questa coincidenza con l’eternità che diventa possibile ripensare gli eventi, portarne alla luce il senso e reinserirlo nel posto che occupa in un quadro complessivo, nella totalità resa sensata che è il sapere assoluto.
Il modello di riflessione filosofica presentato da Hegel sembra dunque incompatibile con un orientamento al futuro: filosofia si può fare solo a orologi fermi, quando il tempo diventa eternità, quando tutto è già avvenuto. Essa non può cambiare nulla degli eventi passati, né dire come questi influenzeranno gli eventi futuri.
Ma proprio la fine della storia come esito del suo ripercorrimento logico-razionale nella filosofia di Hegel ha aperto alla riflessione di questo secolo un vuoto epocale. Ed esso ha, tra le altre cose, prodotto un’inversione di punto di vista, una proiezione dei modelli interpretativi hegeliani, le figure fenomenologiche anzitutto, sul presente e sugli eventi futuri di cui saranno protagoniste e spettatrici le generazioni a venire.
Il ruolo che la Fenomenologia dello spirito (1807) di Hegel ha avuto nella cultura del Novecento, ad esempio nelle filosofie dell’esistenza e nella fenomenologia, è sintomatico di questa inversione. Non si tratta solo del fatto che le strutture di senso messe in luce da Hegel nella Fenomenologia per specifici eventi come la rivoluzione francese, la polis greca o il liberalismo economico si sono poi rivelate adeguate anche a interpretare eventi contemporanei o a costruire modelli teorici per interpretare eventi futuri. E’ stata soprattutto la passione di pensare un evento come una totalità e di coglierne il senso all’interno di un processo globale di cui sono parte, di inserirli in totalità sempre più complesse e onnicomprensive ciò che la Fenomenologia ha trasmesso alla cultura di questo secolo. Nonostante Hegel descriva il cammino della coscienza dalla prospettiva in cui esso è già interamente compiuto, l’analisi delle diverse figure fenomenologiche e delle loro relazioni può costituire un modello anche per rappresentare scenari futuri e le loro possibili interazioni.
In un periodo come questo, in cui si usa constatare l’ancora carente “futurità” nei comportamenti delle società europee, varrebbe anche la pena di rileggere in questa prospettiva un breve saggio di Nietzsche Sull’utilità e il danno della storia per la vita (1874). La malattia storica indotta dall’obbligo di assimilare conoscenze in grandi quantità che spesso rimangono sullo stomaco come “pietre mal digerite” produce, secondo Nietzsche, un atteggiamento che inibisce l’azione, porta alla reiterazione delle vecchie regole, alla tutela e al culto dei costumi ereditati dai propri padri al fine di tramandarli ai propri figli ed è ostile perciò a ogni innovazione. Soltanto la storia monumentale stimola ad un’azione eroica individuale che emula le imprese dei grandi del passato. Chi agisce ispirato da questi ultimi preferisce però confrontarsi con Alessandro Magno o con Napoleone, piuttosto che con gli uomini della società in cui si trova a vivere.
Una difficile integrazione: futuro degli individui e futuro della totalità (3)
La passione per la storia, in forma sia positiva che critica (come rifiuto e condanna del passato), è stata un tratto fondamentale della cultura europea che dovrebbe avere uno spazio maggiore nella discussione attuale sull’importanza di acquisire una mentalità orientata al futuro. Attraverso di essa è possibile distinguere due dimensioni fondamentali nell’atteggiamento verso il futuro, dimensioni che chiamo qui “microfuturo” e “macrofuturo”.
Il microfuturo riguarda l’individuo e i singoli benefici che esso può trarre dal prevedere gli sviluppi futuri di un determinato evento. La previsione riguarda qui l’obiettivo che ci si è prefissato e si può dire di avere avuto un beneficio dalla previsione soltanto se si è raggiunto tale obiettivo. Per spiegare meglio la cosa prendiamo l’esempio della borsa: qui la previsione riguarda l’andamento di un’azione ed è essenziale a far decidere l’azionista se e quando vendere o comprare. Se la previsione è azzeccata essa avrà dunque come effetto un guadagno. Naturalmente è possibile immaginare un osservatore dei mercati azionari che azzecca tutte le previsioni, ma non investe nulla, né consiglia nessun altro nei suoi investimenti. Tuttavia si tratterebbe di un gioco anomalo che è del resto dipendente dal gioco normale, esso è infatti possibile solo se esistano azionisti che prevedono e poi agiscono effettivamente di conseguenza. Sul microfuturo come atteggiamento tipico della cultura anglosassone e americana e sul quello che sembra essere oggi il suo campo di applicazione prediletto, il mercato azionario, tornerò all’ostacolo n.4.
Il macrofuturo è invece il prodotto di previsioni di eventi collettivi, previsioni che non hanno come scopo quello di determinare singoli benefici per singoli individui, ma quello di seguire delle tendenze globali, di interrogarsi su questioni che riguardano intere collettività o gruppi (ad esempio l’ecologia, l’urbanistica, l’alfabetizzazione, la condizione sociale delle donne). La ricerca futurologica costruisce degli scenari in cui si individuano delle tendenze nello sviluppo (per questa ragione la futurologia si definisce anche “ricerca delle tendenze”,“Trendsforschung”, etc.) a partire da situazioni presenti e passate. Uno dei primi modelli di previsione futurologica viene creato da Dennis L. Meadows, in uno studio commissionato dal Club of Rome nel 1972.
Meadows partiva dall’analisi quantitativa di fattori determinanti come lo sviluppo demografico o la diminuzione delle materie prime nel passato per prevedere i futuri sviluppi di quegli stessi fattori. La sua indagine macrofuturologica di Meadows si ancorava immediatamente alla prevenzione di disastri di cui l’analisi metteva in luce la probabilità. Si trattava ad esempio di agire tempestivamente per impedire di lasciare alle generazioni future un pianeta desertificato e ormai completamente privo di risorse. Non è un caso che il movimento ambientalista europeo, che ha una vocazione futurologica di questo tipo, consideri l’opera di Meadows una delle sue fonti ispiratrici.
La dimensione del macrofuturo è possibile soltanto a partire da un’assunzione di natura etica, ossia dall’adozione del punto di vista di una collettività presente e futura di un certo tipo, come un valore in sé che deve essere tutelato. Carlo Bastasin nel suo libro Alexanderplatz. Da Berlino all’Europa tedesca (1996) osserva che la Germania dal dopo guerra a oggi ha puntato, più di ogni altro paese europeo, sulla “valorizzazione del presente nella preservazione del futuro” (p.225), ossia sulla realizzabilità di condizioni sociali e politiche che riguardano il benessere della società nel suo insieme e in particolare delle generazioni future. Nella Germania attuale la globalizzazione economica, che esprimerebbe solo forme di microfuturo, che riguardano cioè il profitto di determinati individui o di gruppi di individui, è considerata un fenomeno che può mettere a rischio il proprio modello di macrofuturo. Esso va però distinto anche dalle visioni del futuro elaborate agli inizi del secolo precedente, in cui il socialismo e la Chiesa fornivano alle masse un sistema di valori.
In questa opposizione di macrofuturo e microfuturo si scontrano, secondo Bastasin modello tedesco da un lato e modello anglossassone ed americano. E’ prevedibile che nel compimento dell’integrazione europea questo contrasto si acuirà ulteriormente opponendo sia gli stati della Comunità Europea tra di loro sia Europa e Stati Uniti. E’ sempre Carlo Bastasin che scrive: “l’intolleranza con cui gli anglosassoni osservano e criticano il modello tedesco nell’economia sociale di mercato è legato al fatto che questo modello mette in questione qualche cosa di più del modello anglosassone dove tutto ciò che conta è la libera concorrenza, l’economicità delle azioni e la razionalità (l’ottimizzazione) di breve termine. Un sistema come quello tedesco dove gli obiettivi non sono mai di breve termine, dove il profitto di un anno può essere sacrificato in previsione del futuro, viene percepito come un atto di accusa agli anglosassoni che legittimano comportamenti più simili alla massimizzazione soggettiva, finendo per far la figura degli egoisti” (p.170). Ma le controaccuse degli anglosassoni al modello tedesco non sono solo difensive e infondate. La pianificazione di un futuro di benessere per l’intera comunità nell’economia sociale di mercato tedesca si è servita di un sistema di consenso e di controllo a base prevalentemente emotiva delle credenze e dei valori dei cittadini, un sistema dunque che presuppone una struttura gerarchica e una forte asimmetria tra governanti e governati che devono essere indotti a comportarsi in modo da realizzare le previsioni compiute dai governanti.
Da questo punto di vista è certamente un limite di alcune posizioni del dibattito attuale sul ‘futuro del macrofuturo’ che la caduta del sistema di credenze e di relazioni collettive del cattolicesimo e del socialismo sia considerata come un elemento negativo e che si ritenga necessario trovare dei sostituti sostanzialmente uguali in grado di appagare il presunto bisogno di sicurezza e tutela delle masse. Di fronte a questo atteggiamento, con cui parte dell’élite intellettuale europea sembra considerare insuperabile l’opposizione tra i governanti capaci di ragionare e la massa bisognosa della retorica della tranquillizzazione, la cultura anglosassone ha buon gioco di rivendicare per sé i valori della libertà e della democraticità e anche una diversa concezione di uguaglianza.
La paura dell’errore (4)
La passione del mondo anglosassone è indubbiamente, come osserva Bastasin, il microfuturo, ossia la pianificazione adeguata da parte degli individui del proprio futuro allo scopo di garantirsi il successo economico, sociale e culturale.
Questo gioco con il futuro si esprime al meglio nelle previsioni fatte dagli agenti del mercato azionario. Qui la previsione è tipicamente a breve o medio termine ed è immediatamente legata a una conseguenza pratica, la perdita o la vincita dell’azionista. Il fatto che si tratti di previsioni a breve o medio termine e relative a un oggetto ben preciso (le azioni) dovrebbe rendere il rapporto degli individui con il microfuturo in questo piuttosto semplice e accessibile. In realtà è vero esattamente il contrario: in un mondo di agenti economici privi di regole e di controllo statale, le variabili e le possibilità da considerare nella previsione sono talmente tante che è praticamente impossibile non sbagliare. Ed è proprio il rapporto con l’errore a costituire uno dei punti di opposizione più importanti tra mentalità microfuturologica e macrofuturologica. Il tema dell’atteggiamento individuale e collettivo rispetto all’errore e dei suoi risvolti politici e sociali è infatti centrale rispetto alla mentalità futurologica.
Il sistema pedagogico tuttora dominante in Europa si fonda sulla capacità di istillare la paura dell’errore. In un modello come quello anglosassone e statunitense (che promuove l’affermazione individuale, lo spirito di iniziativa e di innovazione) esitare ad agire (e soprattutto agire in modo nuovo) per paura di sbagliare è evidentemente un intralcio, viceversa in un modello sociale tradizionale che tutela lo status quo del sistema socio-economico esistente istillare la paura dell’errore è piuttosto funzione dell’autoconservazione della totalità.
Dal punto di vista della tradizione si sbaglia anche quando si percorrono strade nuove su cui non c’è ancora consenso sociale. Studi sociologici hanno mostrato che proprio nelle società più tradizionali l’errore è associato a sentimenti come forte imbarazzo e vergogna, mentre nelle società occidentali si sente spesso manifestare l’attonita, snobistica constatazione secondo cui la gente non si vergogna più di nulla, cosa che si dovrebbe da un certo punto di vista accogliere con sollievo (auspicando semmai che sia la consizione di manifestazioni culturali più complesse, personali e meditate), visto il carattere paralizzante, conservatore e assolutamente non produttivo di un’emozione viscerale come la vergogna.
Tuttavia le istituzioni scolastiche e accademiche rimangono comunque, in questo senso, roccaforte della tradizione: i docenti hanno la facoltà di decidere cosa è o cosa non è un errore, senza che su questo vi siano per lo più possibilità istituzionalizzate di discussione, contrattazione e critica da parte dei discenti. Qui la paura dell’errore, l’ansia da esame sono ancora sentimenti diffusissimi a cui si aggiungono quelli di vergogna e di umiliazione (sollecitati da atteggiamenti vari, ben noti a tutti) nelle situazioni a cui viene data una valutazione negativa.
L’abito di accettare la tradizione come portatrice di verità indiscussa, la cultura dell’auctoritas sono stati oggetto di una critica radicale almeno dall’Illuminismo. Tuttavia quello dell’esame critico della tradizione e della sovranità intellettuale ed emotiva di fronte alle controreazioni da parte dell’autorità sono rimasti fenomeni minoritari.
Dal punto di vista della programmazione politica del macrofuturo ciò offre indubitabili vantaggi. Il fatto che i cittadini accettino credenze ricevute e proseguano in modelli di comportamento tradizionali è una grossa agevolazione per la previsione e la pianificazione politico-economica, così come, in modo particolarmemente accentuato in Italia, per la perpetuazione indiscussa di una classe politica e dirigente del tutto refrattaria a qualsiasi trasformazione e cambio generazionale.
Per questo in modo più o meno consapevole, il modello politico e l’economia sociale di mercato tedesca, hanno guardato con irritazione le innovazioni che introducono variabili che richiedono di pensare una serie di effetti a catena, mutando ad esempio profondamente modi di comunicare, di consumare, di trascorrere il tempo libero.
Non è un caso, come ha ricordato in diverse occasioni il settimanale tedesco “Der Spiegel”, che proprio la ricerca futurologica tedesca, all’inizio degli anni novanta, considerò l’esplosione della professione di programmatori e creatori di software un fenomeno passeggero destinato ad estinguersi in pochi anni.
La Germania non riuscì ovviamente neppure a prevedere in anticipo le enormi potenzialità di Internet in fatto di trasformazioni sociali, crescita economica e creazione di posti di lavoro. Una conseguenza di questo errore è che il paese si è trovato, tra le altre cose, privo di migliaia di informatici che l’ex governo socialdemocratico di Schröder, attraverso un progetto finalizzato a questo scopo, ha cercato, con esiti variabili, di importare dall’India. Una delle cause di questo insuccesso previsionale è stata probabilmente l’inclinazione della programmazione socio-economica a considerare le innovazioni anzitutto come scomodo intralcio al proprio lavoro.
Chi pianifica lo stato sociale, facendosi carico del benessere della collettività presente e futura ha la vita più facile se in essa un numero estremamente basso di individui, più capaci dei pianificatori di cogliere le potenzialità di ogni nuova innovazione, ne traggono velocemente il massimo profitto. Sul piano politico molte nazioni europee orientate allo stato sociale si sono servite di vincoli legislativi per tenere a freno questi individui, sul piano psicologico essi sono stati frenati, come si diceva, anche con lo spauracchio dell’errore, con la paura di rischiare, mentre sul piano etico li si è combattuti attraverso la convinzione che grosse disparità di condizioni economiche sociali tra esseri umani debbano essere evitate con ogni mezzo, soprattutto se producono situazioni di miseria nella maggioranza. Il modello individualistico neoliberalista solitamente contesta allo stato la legittimità e i vantaggi dei vincoli che pone al libero mercato, denuncia come illusoria ed ipocrita l’etica altruistica dell’egualitarismo e rivendica il diritto di pensare e agire con la più assoluta libertà individuale.
Per vincere l’atteggiamento psicologico che è alla base della politica dei vincoli e della burocratizzazione di cui tanto si parla l’Europa non potrà che fare perno sull’eliminazione della nevrosi da errore e sulla struttura retorico-ideologica su cui si innesta.
Il segnale della possibilità di un’integrazione proficua tra microfuturo e macrofuturo viene dal mondo anglosassone ed esemplare in questo tempo è l’esperienza dell’investitore finanziario Geoge Soros, uno degli uomini più ricchi e influenti del mondo. Nella Crisi del capitalismo globale (1999), interrogandosi sulle ragioni del suo successo professionale, Soros racconta che esso è stato prodotto anzitutto dalla capacità di non aver paura di scoprire errori nelle proprie scelte di azionista e di dedicarsi anzi accanitamente a scoprirne sempre di nuovi. Soros ha finito per accorgersi che la sua propensione a scoprire in modo veloce e sistematico i propri errori è un dono raro e che la maggior parte delle persone è viceversa incline a ignorare i propri errori e a concentrare l’attenzione su ciò che ha fatto bene, piuttosto che su quello che si può migliorare. A questa doppia ragione (non solo la passione per la perfettibilità di Soros, cioè, ma anche la carenza della medesima nella maggioranza degli individui) si deve, a suo avviso, la straordinaria fortuna che egli si è costruito sul mercato borsistico. Individuando rapidamente gli errori che aveva fatto nel valutare un’azione, Soros era infatti in grado di comprare o vendere molto prima degli altri azionisti. La rapida scoperta dei propri errori e il conseguente costante perfezionamento delle sue azioni di speculatore sul mercato globale sono espressioni di capacità che Soros ha al principio usato solo per il proprio vantaggio economico, compiendo esclusivamente previsioni nell’ambito del microfuturo.
La previsione conservatrice: l’inferenza percettiva (5)
Promuovere il superamento della paura dell’errore è un passo essenziale per sviluppare una mentalità orientata al futuro in grado di integrare dimensione micro- e macrofuturologica. Ma si può vincere davvero la paura di fare errori quando si cerca di prevedere il futuro? O la paura dell’errore, oltre che un prodotto culturale, è anche un indispensabile dispositivo cognitivo forgiato dall’evoluzione senza il quale la specie umana, e non solo essa, non sarebbe mai sopravvissuta?
Quando si affronta il tema delle previsioni futurologiche si usa sempre premettere che è impossibile avere la certezza che una determinata previsione si avvererà. Ma per quanto riguarda la probabilità che si verifichi un evento ipotizzato c’è una differenza nettissima tra previsioni a medio/lungo termine e previsioni a breve termine basate su inferenze percettive intorno all’ambiente circostante. Questa capacità inferenziale, che è stata descritta, fin dall’antichità, dalle teorie del segno naturale, fa sì che da un cielo annuvolato, dal ringhio o dall’atto di scoprire i denti di un cane, dalle orme su un terreno si possano fare ipotesi su quello che accadrà (o anche, come nel caso delle orme, su quello che è già accaduto) ed eventualmente scegliere anticipatamente il tipo di azione più adeguato all’inferenza compiuta. Ancora più sofisticato è l’insieme delle valutazioni che possiamo trarre, a livello conscio e inconscio dal comportamento, dai gesti, dall’espressione e dall’atteggiamento complessivo di altri individui. Naturalmente anche in questi casi possiamo commettere errori. Si tratta però di errori nel complesso talmente poco frequenti che sviluppiamo presto un sentimento di fiducia, di certezza riguardo a questi sistemi di inferenze.
Per agevolare ulteriormente questa capacità previsionale della mente, le culture umane hanno sviluppato un insieme di abiti, riti e tradizioni che rendono l’ambiente circostante il più possibile prevedibile. Si può dire cioè che nel costruire i propri ambienti culturali gli esseri umani tendono ad aumentarne la prevedibilità in modo tale da riuscire a conoscere in anticipo la maggior parte delle risposte. L’ambiente culturale viene perciò incontro al bisogno umano di prevedere gli eventi, per questo il passaggio ad un ambiente culturale sconosciuto, e quindi solo in minima parte prevedibile, è assai meno tranquillizzante e implica un impiego molto superiore di attenzione, visto che non si può più fare conto sulla fiducia in inferenze ormai automatiche.
Questa previsione naturale, istintiva degli eventi corrisponde a una psicologia molto conservatrice: chi difende il modello flessibile di un ambiente in perenne trasformazione o dà per certo che la popolazione del futuro sarà in perenne movimento non può non soffermarsi sugli ostacoli psicologici e quindi sulle forti resistenze che hanno gli individui al cambiamento continuo, visto che esso mette in scacco il sistema istintivo di previsioni che si sono costruiti abitando sempre lo stesso ambiente. Nessun appello alla flessibilità è sensato se non si interroga su quali meccanismi psicologici si oppongono alla possibilità di un riadeguamento continuo a una realtà in perpetuo mutamento.
Il sentimento di paura e di incertezza che suscita un luogo o una situazione nuova, nonostante le variazioni individuali, anche notevoli, tra pavidi e audaci, pigri e curiosi, abitudinari ed esploratori, è dunque comune alla maggior parte degli esseri umani a causa del suo valore adattativo, ossia per i vantaggi rispetto alla sopravvivenza che dà agli individui che lo possiedono. In tale atteggiamento risiede forse anche una delle ragione della progressiva omogeneizzazione del territorio urbano in tutto il pianeta che va di pari passo con il progredire della globalizzazione e, in particolare, del turismo come movimento planetario. Questo indubitabile impoverimento della molteplicità delle culture umane è spesso ascritto a malvagità o noncuranza da neocolonizzatori degli occidentali. Ricordare che il comportamento che lo produce è viceversa il più istintivo non significa affatto, ovviamente, legittimarlo, ma piuttosto invitare a rendersi davvero conto dell’impegno che richiede superarlo.
Perciò non si può mai sottolineare abbastanza il fatto che l’inclinazione a sfuggire situazioni sconosciute, a cui si può non essere in grado di far fronte in modo adeguato, ha avuto nell’evoluzione una ragione adattativa essenziale. In un ambiente con scarse risorse alimentari, molti animali pericolosi e altri gruppi umani aggressivi, compiere un errore significava mettere a repentaglio la propria vita. Poiché è probabile che in un tale ambiente evolutivo siano vissuti gli esseri umani e le specie da cui deriva la specie umana per milioni di anni non stupisce che la paura dell’errore sia una disposizione psicologia così diffusa.
Certo si può obiettare che nelle società contemporanee buona parte degli errori che gli esseri umani fanno non sono errori fatali, almeno considerati singolarmente - ma è del resto difficile valutare il ruolo che essi, interagendo con molti altri fattori, hanno nel determinare eventi futuri.
Tuttavia la paura dell’errore è un sentimento che viene suscitato in modo istintivo e immediato prima che si valuti se è razionale o no provarlo, o se si tratta eventualmente di errori rimediabili. Inoltre, in ambito culturale, anche un errore banale può essere spesso equiparato a un errore fatale per la disapprovazione sociale a cui viene collegato e ciò può renderlo più sgradevole degli effetti che realmente produce.
Se consideriamo dunque che per quanto riguarda la paura dell’errore si sommano ragioni di ordine evolutivo e di tipo culturale (in cui l’errore può essere associato al disonore o almeno a un disvalore personale), si capisce perché la psicologia dell’azionista Soros, che sa che la sua capacità di individuare in modo rapido e spietato gli errori è l’unica vera garanzia del suo successo, sia ancora tanto poco diffusa.
Gestire la riflessività (6)
La sesta difficoltà futurologica riguarda il rapporto tra la previsione e l’influenza che essa ha sul verificarsi degli eventi previsti. Questa relazione rientra in ciò che Popper descrive come riflessività o comportamento riflessivo. Soros, che è stato allievo di Popper alla London School of Economics, si è servito di questo concetto per spiegare il ruolo che hanno sull’andamento dei mercati le credenze degli azionisti e le informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione. Enunciati riflessivi sono gli enunciati il cui valore di verità dipende dall’effetto che producono, mentre l’effetto che producono dipende a sua volta dal fatto di essere o meno ritenuti veri. Tutti gli enunciati di valore (di cui fanno parte anche i giudizi etici) hanno, secondo Soros, un carattere riflessivo.
Soros sostiene che la riflessività agisce in modo simile al livello del profitto dei singoli e a quello dell’interesse della collettività. L’effetto riflessivo si applica quindi anche a un progetto globale. In questo caso si tratta per Soros di convincere i suoi lettori anzitutto di due cose: 1) per salvare il capitalismo mondiale, è necessario regolamentare i mercati; 2) la logica amorale del profitto individuale non è in grado da sola di garantire il benessere collettivo; a questo scopo sono necessarie azioni specifiche di più individui a livello politico e sociale.
E’ significativo inoltre che proprio attraverso la sua esperienza di osservatore dei mercati globali sia maturata in Soros la convinzione, esposta nella Crisi del capitalismo globale, che è necessario affiancare il punto di vista dell’agente amorale dei mercati economici a quello della regolamentazione statale, il punto di vista privato del profitto individuale a quello politico del benessere della collettività, il punto di vista del microfuturo dunque a quello del macrofuturo.
Se si convincono le persone che è necessario impegnarsi per il benessere della collettività e che per fare questo bisogna agire collettivamente a livello politico e non solo come singoli benefattori, esse sosterranno dei governi che si impegnano nella realizzazione di questi valori. Ma, secondo Soros, sul macrofuturo la riflessività agisce in maniera persino più diretta che nelle microprevisioni del mercato: se tutti gli individui si convincono che valori come la collettività e la tutela dei beni comuni sono essenziali si impegneranno in azioni politiche che realizzeranno questi valori, mentre una previsione sul mercato finanziario, pur cogliendo un aspetto reale può rivelarsi inefficace per il prevalere di altri effetti riflessivi derivanti da previsioni di altri azionisti, da giudizi di osservatori influenti, da azioni politiche, etc.
L’aspetto forse più interessante dell’effetto riflessivo, riguarda, nel nostro caso, il modo in cui agirà sulla mentalità orientata al futuro. Si tratta cioè di chiedersi se la capacità di immaginare scenari globali, la cosiddetta futurità, non influirà essa stessa in modo determinante sugli sviluppi futuri delle società. L’economia fondata sulla conoscenza di cui si parla tanto in questo periodo ha infatti come sua condizione la nascita di una società globale di individui con un grado di istruzione infinitamente più alto e più diffuso di quello di tutte le società del passato. L’opposizione tra l’approccio intellettuale di chi agisce ossia tra una minoranza che produce valori e modelli culturali e la maggioranza che li riceve e li fa propri passivamente, oppure li rifiuta, senza proporre in modo creativo possibilità alternative, non ha più nessuna ragione d’essere in una società in cui non c’è disparità di istruzione e conoscenze, mentre era, viceversa, nettissima nelle comunità del passato, ad esempio nel cattolicesimo, che, non a caso, ha scoraggiato la diffusione dell’alfabetizzazione e la politica dell’istruzione obbligatoria per tutti i cittadini e le cittadine.
E’ necessario allora chiedersi in che modo sia possibile favorire lo sviluppo di un sistema di valori collettivi alla cui elaborazione contribuiscono un numero sempre maggiore di individui e in cui ci sia uno scambio sempre più equilibrato tra produttori e riceventi di valori, idee e modelli culturali.
E’ plausibile immaginare uno scenario in cui tutti i fruitori di conoscenze, narrazioni e valori sono al tempo stesso anche produttori e in cui dunque le disparità in fatto di conoscenze sono minime e l’assenso a determinate credenze non è per nessun fruitore di natura solo emotiva? Ed è possibile ipotizzare che la crescita di strumenti tecnologici come Internet e dei loro utenti sia una condizione che favorirà o, persino, renderà inevitabile questa nuova forma di scambi culturali simmetrici e di diffusione e approfondimento capillari di conoscenze e valori sociali?
L’opposizione tra manovranti e manovrati nell’epoca del controllo globale (7)
L’ipotesi di un rapido superamento globale delle disuguaglianze di formazione ad opera della rivoluzione informatica sembra piuttosto improbabile. Anzitutto perché l’uso di Internet non produce necessariamente nuovi metodi di apprendimento e nuovi valori sociali e politici, almeno finché più utenti non cominciano a interrogarsi discutere insieme sul senso e sulle potenzialità di questo uso, sui nuovi costumi che produce, etc..
Attualmente l’aspetto che più colpisce nell’uso della Rete è l’enorme possibilità di controllo sugli individui che rende possibile: attraverso Internet si possono avere informazioni su milioni di persone sparse in tutto il mondo e, attraverso la pubblicità (oggi il principale introito delle imprese Internet), è possibile orientare, assecondare o deviare gusti, preferenze e convinzioni, creare nuovi desideri e bisogni attraverso l’offerta di nuovi servizi.
Probabilmente tutto ciò rimarrà a lungo monopolio di una minoranza. Infatti anche nell’ipotesi, peraltro del tutto improbabile, che, in pochi decenni, il 100% degli abitanti del pianeta avrà accesso a Internet (il che presuppone un’ancor più improbabile alfabetizzazione globale) e che tutti potranno teoricamente avere accesso a informazioni dettagliate riguardo a gruppi di persone in ogni parte del pianeta, la separazione tra manovrati e manovranti rimarrà netta.
Non si tratta infatti tanto di una questione di mezzi tecnici disponibili, ma del tipo di atteggiamento e di mentalità che rende possibile un certo uso di questi mezzi, quello appunto dei manovranti: mentre infatti ciò che chiamo “essere manovrati” si fonda su un certo tipo di comportamenti istintivi che sono riconducibili alla capacità di adattarsi ad un ambiente dato (corrispondente a quel tipo di atteggiamento previsionale conservatore ed evolutivamente antico di cui si parlava al punto 5), l’essere manovranti, ossia, in accezione positiva, produttori e agenti autonomi e responsabili è un atteggiamento che appare ai più anormale, il prodotto di un modo di vedere le cose che è ancora del tutto estraneo alla maggioranza.
Non è un caso che un film come Truman Show, che presentava una figura di manovrante, il regista di reality show che era tale solo per il suo protagonista, con connotati estremamente negativi, abbia destato molto sconcerto. Gli spettatori consideravano inquietante la prospettiva di poter essere sottoposti a un controllo globale come quello a cui è sottoposto Truman, attore a sua insaputa fin dalla sua nascita di una soap opera globale che coincide completamente con la sua vita.
Tuttavia il gradimento riscosso in tutto il mondo dai vari reality show, in cui le persone accettano di farsi riprendere istante per istante nella loro vita di ogni giorno in situazioni normali o eccezionali (ad esempio in isole deserte), dimostra che alle persone non dispiace mostrarsi al mondo anche nei momenti più intimi della loro vita privata. Quello che più probabilmente inquieta in Truman Show è, appunto, l’opposizione tra manovrato e manovrante. Il manovrante è il regista della soap opera e assume un ruolo simile a quello che l’umanità per millenni immaginò essere il ruolo di Dio. Il regista ha creato o pretende di aver creato per Truman il migliore dei mondi possibili e conduce in effetti una vera vita da creatore assorbito a seguire e filmare passo dopo passo la vita della sua creatura..
L’aspetto più significativo della vicenda è che, mentre la vita del manovrante, che deve progettare passo passo la sceneggiatura della vita reale di un solo uomo, è del tutto diversa da quella della maggior parte delle persone, la vita del manovrato, di Truman, è del tutto simile a quella di tantissimi normali cittadini americani. Un’esistenza fatta di spot televisivi, di bisogni indotti dalla pubblicità dei nuovi prodotti, di condizionamenti inconsci ad opera dei mezzi di comunicazione non è una maledizione personale di Truman. In una condizione molto simile si trovano già i cittadini dell’occidente più ricco e ci si troveranno sempre più in futuro gli utenti di Internet di cui è possibile avere un identikit molto preciso che comprende le possibilità finanziarie, le preferenze in fatto di macchine, viaggi, vestiti, cibi, vini, programmi televisivi e persino le malattie di cui soffrono e i medicinali usati.
Questo fatto è per lo più avvertito in maniera confusa e con confuso scontento da chi si trova nella condizione del manovrato. Si ha tuttavia l’impressione che il manovrato, più che essere scontento di essere manovrato, è ostile al manovratore a cui involontariamente procura un vantaggio. Egli trascura così il fatto che il punto di vista globale, esemplificato dalla Rete, ma non coincidente con essa, prescinde dal vantaggio che da esso si può eventualmente trarre (al contrario di quanto accade sui mercati finanziari v. ostacolo 3); esso è insomma estraneo sia alla logica del manovratore che a quella del manovrato. L’assunzione di questo punto di vista non coincide affatto con l’atto stesso di manovrare, si tratta piuttosto di un’estensione dello sguardo che mira a ottenere un’informazione il più possibile esaustiva, ma può anche opporsi dall’interno alle manipolazioni ed esercitare un’azione costante di vigilanza critica contro gli abusi.
Il punto di vista globale non è dunque necessariamente quello dell’ottimizzatore, ossia non è causato dall’intenzione di massimizzare i profitti: certo se il punto di vista globale è assunto allo scopo di ottenere profitti, come nei mercati finanziari, allora chi è in grado di ottenere più informazioni nel modo più rapido ed estensivo è effettivamente in grado di massimizzare i profitti.
Tuttavia la posta in gioco più importante nel caso di questa nuova rivoluzione tecnologica è l’acquisizione di nuova strategia di natura etica e cognitiva, di un diverso modo di pensare, non un vantaggio di natura pratica: il piacere che si trae dall’approdare a questa dimensione di senso relativo alla totalità prodotta dalla quella rivoluzione non può essere messo allo stesso livello di nessun beneficio utilitarista.
Si può ironizzare sul fatto che solo dopo essere diventato l’uomo più ricco del mondo Soros si è reso conto che la ricchezza da lui raggiunta era incommensurabilmente maggiore anche dell’immaginazione più fervida nell’inventarsi nuovi oggetti di desiderio e che solo allora il punto di vista del profitto individuale gli sia apparso molto meno attraente e sensato di quello del futuro della totalità, di tutto il pianeta. E’ un fatto però che il suo interesse prevalente sia diventato il macrofuturo e la sua passione la politica economica mondiale. Ha cominciato quindi a fare da consulente a Paesi colpiti dalla crisi economica come la Russia ed è diventato un filantropo su scala planetaria costituendo la Fondazione Open Society che sostiene le società dell’Europa dell’est nel loro processo di democratizzazione.
Perché il punto di vista globale si imponga a tutti i cittadini del pianeta portando alla realizzazione di governi veramente democratici ovviamente non basta Internet, e neppure che un film come Truman Show suggerisca al mondo intero che si è ormai arrivati a un grado di sviluppo tecnologico tale da controllare a sua insaputa un individuo dalla nascita alla morte.
L’unica soluzione contro questa eventualità sembra proprio quella di oltrepassare l’opposizione tra governanti e governati, almeno nelle forme politiche tradizionali in cui la delega e una forma di assenso prevalentemente emotiva giocano un ruolo fondamentale. Nell’interazione sociale ci si regola ancora in massima parte secondo valori, credenze e tradizioni ereditate e solo una formazione che sia decisamente orientata a tale scopo permette di superare un’adesione acritica a giudizi di valore ricevuti. I credo religiosi e politici agiscono ancora secondo una logica oppositiva, secondo un modello amico-nemico che ha una fortissima connotazione emotiva. Questo modello che ha dominato per secoli la cultura occidentale fa sì che, nella politica si tenda sempre a selezionare le informazioni che servono a confermare le proprie credenze e inclinazioni naturali, mentre si trascurano – sia istintivamente che deliberatamente - quelle che le smentiscono.
Per sostituire con questo tipo di interazione una mentalità neutrale capace di confrontarsi con sistemi complessi e sintesi di credenze e valori senza cercare subito amici e nemici, buoni e cattivi, è necessario un cammino lungo e faticoso, un’educazione critica che si sostituisca alla tuttora dominante pedagogia pavloviana a base di premi e punizioni.
Se non capiscono questo le società laiche dell’Occidente finiranno forse per vincere le forme di controllo oppressivo e sanguinario che ancora oggi, in alcune regioni del mondo, esercitano le religioni, ma non creeranno mai delle vere democrazie globali.
E’ in questa direzione che, nel sintetizzare il proprio modello di istruzione e di scuola, Tullio De Mauro mette in evidenza la capacità che esso deve avere di creare “un mondo in cui tutte e tutti possono essere a turno governanti e governati” e in cui perciò “tutte e tutti abbiano una sufficiente dote di compentenze per muoversi liberamente nello spazio delle società e delle culture (alte e basse, tecniche e intellettuali) e per capire la follia dello scannarsi a vicenda tra popoli, culture e credenze” (De Mauro 2004).
Riferimenti bibliografici
Bastasin, C. (1996) Alexanderplatz. Da Berlino all’Europa tedesca, Milano: Feltrinelli.
De Mauro, T. (2004) La cultura degli italiani, a cura di Francesco Erbani, Bari: Laterza.
Hegel, G. W. F. (1972) Fenomenologia dello spirito (1807), Firenze: La Nuova Italia.
Ianneo, F. (1999) Memi, Roma: Castelvecchio.
Nietzsche, F. (1994) Sull’utilità e il danno della storia per la vita (1874), Milano: Adelphi.
Soros, G. (1999) Crisi del capitalismo globale, Milano: Ponte delle Grazie.
Alla base dell’attività di prevedere gli sviluppi futuri degli eventi in settori cardine dell’economia, della società e della tecnologia fu, in quell’occasione, identificata una capacità cruciale e ancora poco sviluppata degli esseri umani; per farvi riferimento il “Financial Times Deutschland” coniò il neologismo “futurità” (“Futurität”) per indicare un determinato tipo di mentalità orientata al futuro e sostenne che acquisirla sarebbe stato un passo necessario per far fronte al nuovo millennio.
Strettamente associata alla flessibilità e alla capacità di innovare, di ampliare e ristrutturare continuamente le proprie conoscenze, la futurità è stata, a ragione, considerata un’attitudine che manca ancora alla maggioranza degli abitanti del pianeta e certamente a buona parte degli europei per una serie di ragioni che cercherò qui di analizzare.
Vorrei far notare che nel trattare la questione futuro i giornali assumevano spesso toni allarmistici. L’impressione è che si identificasse il compito da eseguire con il dare ai lettori un avvertimento di questo genere: se non si fossero adeguati, imparando a fare fronte alle nuove esigenze di una società e di un mercato del lavoro in continuo mutamento sarebbero incorsi in sicura rovina.
Il titolo con cui il quotidiano “Repubblica” aveva battezzato i suoi supplementi di inglese e di computer giudicati evidentemente gli strumenti più indispensabili per far fronte all’imminente futuro suonava sì volutamente tranquillizzante: “Futuro no problem”. Ma la stessa formula letta alla rovescia suggeriva piuttosto che, se non si fossero fatti una serie di passi indispensabili (l’apprendimento di un inglese e di conoscenze informatiche di buon livello in quel caso), il futuro avrebbe piuttosto portato problemi gravi, di difficilissima soluzione.
Non è infrequente che un addestramento di tipo pavloviano venga utilizzato anche per far acquisire una nuova abitudine di ordine culturale, un nuovo modo di pensare o, potremmo anche dire, un meme (unità culturale, secondo i teorici evoluzionisti come Richard Dawkins, creatore di questa nozione, almeno in parte paragonabile, per modalità di propagazione, al gene, v. Ianneo 1999).
Questa è stata ed è ancora, mi pare, la strada seguita per lo più anche dai mezzi di informazione che, per convincere i lettori che devono adattarsi a guardare al futuro e procedere con il suo stesso ritmo serrato, creano in essi un condizionamento negativo, producendo un certo di tipo di credenze che evocano scenari apocalittici per chi non fosse capace di adeguarsi e suscitano, di conseguenza, sentimenti di paura e di disagio.
C’è da chiedersi se questa sia davvero la strategia migliore, in particolare per un tema come il futuro. In questo modo per almeno buona parte delle persone si delineerebbe un’alternativa inaggirabile assai poco attraente e che, cosa che qui più conta, non è invece tale: forzarsi a pensare al futuro come a un gioco estremamente ed esclusivamente competitivo la cui posta è tentare di adeguarsi a trasformazioni sempre più rapide (prospettiva che suscita una grossa ansia, ma anche, in molti, un rifiuto per lo stesso modello e per l’atteggiamento a esso associato, reputato, allo stesso modo, indispensabile) o non pensarci affatto, assicurandosi – o almeno così gli si dice - un inevitabile fallimento sociale o anche asserragliandosi per difesa dietro categorie e griglie interpretative, categorie che, prescindendo qui dal loro valore pratico ed epistemologico, vengono applicate a tutto tranne che alla realtà, al mondo in cui chi le usa si trova e si troverà a vivere e ad agire, anche grazie al modo in cui quella realtà e quel mondo sono stati pensati e progettati.
Per questa ragione è forse opportuno fare un passo indietro. E chiedersi anzitutto perché è così difficile acquistare una mentalità futurologica e se si tratti di un’unica mentalità o di più atteggiamenti e modalità di interazione. Sembra infatti che la stessa nozione di futuro sia scindibile in più concetti e che dunque tutti i “futuri” che ci vengono proposti (e mediatamente imposti) in un unico blocco siano effettivamente dimensioni tra loro distinte.
Invece di assumere toni allarmistici è bene avere chiaro il fatto che non solo nessuno ci ha mai insegnato il gioco, anzi i giochi, numerosi, attraverso cui ci rivolgiamo al futuro e ci apriamo alla ‘futurità’, ma che ci è stata anzi trasmessa in molti casi l’idea che si tratti di un territorio tabù, una zona limite che è arduo varcare: per farlo è necessario superare diversi sbarramenti, prove multiple di difficoltà crescente, un po’ come quelle che devono superare gli eroi dei miti o delle favole per arrivare alla meta.
La morte e il controllo impossibile (1)
Il primo ostacolo per chi vuole guardare al futuro è banale, ma non per questo poco significativo. Chi guarda avanti, lungo il percorso lineare con cui si è soliti rappresentare il futuro, incontra e oltrepassa ben presto un evento di fronte a cui distoglie istintivamente lo sguardo, la propria morte. Questo tipo di resistenza rispetto al futuro è ben sintetizzato in diverse versioni di un mito greco, in cui forse sarà capitato di imbattervi già negli anni del liceo classico. Una delle tante varianti racconta che gli esseri umani chiesero un giorno alla divinità il dono di poter vedere in anticipo il futuro e che la divinità benignamente glielo concesse: gli umani si chinarono allora su un grande specchio e lì dentro scorsero il loro futuro. Subito la terra risuonò di pianti e lamenti: nello specchio gli esseri umani avevano visto sciagure per sé, per i loro amici e i loro familiari e naturalmente la morte, fine a cui tutti gli umani sono destinati. La morale della favola, riassunta nella formula finale: “o mythos legei”, “la favola insegna”, suona dunque che è meglio non conoscere il futuro.
E’ opportuno ricordare che il contesto culturale che fa da sfondo a questa narrazione è quello di una società in cui le forme di controllo e di influenza sugli eventi futuri sono infinitamente più limitate rispetto a oggi. Esiste una relazione precisa tra l’atto di prevedere gli eventi futuri e la possibilità di agire in modo tale da esercitare su di essi un’influenza e modificare così il loro corso. Quanto più gli individui avvertono di non aver alcuno o uno scarso controllo sul futuro degli eventi in settori fondamentali come la salute o le fonti di sussistenza (per lungo tempo costituite da pastorizia e agricoltura), tanto più si avrà una difficoltà psicologica a immaginare eventi futuri e si svilupperà un insieme di pratiche magiche nel tentativo di esercitare un’influenza benefica per gli esseri umani su fenomeni naturali come il clima e il raccolto o su eventi sociali come fondazioni di città, guerre, etc.
Ma se questo è vero, e va preso nella dovuta considerazione nel riflettere sui modi più efficaci di superare le resistenze rispetto all’acquisizione di un generale orientamente alla previsione, è altrettanto innegabile che il senso di non avere un controllo pieno e assoluto sugli eventi, sul futuro proprio e altrui, è prodotto antropologicamente comune dell’identità e strutturazione psicologica degli esseri umani. E in ogni società, anche nell’illuminato Occidente di oggi, vi sono figure che impersonano ed esaudiscono il bisogno di avere responsi sugli eventi futuri che non sono il frutto di valutazioni razionali: maghe, cartomanti, sibille, oracoli e aruspici esercitano da millenni questa funzione, formulando risposte che hanno spesso la forma ambigua dei resoconti onirici proprio perché probabilmente rendono conto dell’inclinazione a entrare in contatto con il sapere dell’inconscio e con le sue specifiche forme di simbolizzazione che, come ha rivelato la psicanalisi, costituiscono una dimensione costitutiva di ogni soggetto umano.
Poiché dunque le barriere psicologiche a immaginare il futuro a medio e lungo termine sono un retaggio antico, hanno cioè costituito un atteggiamento primario degli esseri umani per migliaia di anni e, soprattutto, derivano da caratteristiche antropologiche che appaiono culturalmente invariabili, non stupisce che, anche in tempi in cui le possibilità di controllo e prevenzione sono enormemente superiori, esse rimangano parte integrante della struttura psicologica degli esseri umani.
In effetti guardare al futuro è ancora oggi per molte persone un tabù. Si evita di prevedere anche dove ciò è possibile a causa di una paura superstiziosa che si appoggia sull’idea irrazionale che un fatto probabile di cui non si sa nulla rimarrà un fatto inesistente, non si verificherà. Perciò, in campi particolarmente minacciosi come le malattie, le persone rifiutano deliberatamente di sapere in anticipo se sono soggetti a rischio, anche quando sono invitate a farlo ed è ovviamente per loro vantaggioso farlo. Lo scarso successo delle campagne di prevenzioni dei tumori e di altre malattie dipende soprattutto da questo.
E’ assai probabile che neppure nei decenni a venire, in cui i progressi della ricerca in campo genetico permetteranno di allungare enormemente la vita, di prevenire gravi malattie e perciò di controllare e determinare buona parte del futuro delle persone, questa atavica resistenza psicologica degli umani sarà abbattuta.
Si tratta allora di interrogarsi sui modi più efficaci per eliminarla, articolando con contenuti adeguati la ricetta generale dell’Illuminismo: quella dell’istruzione nella doppia direzione del suo miglioramento qualitativo e della diffusione capillare nell’intera società globale.
Il punto di vista senza futuro: lo sguardo del dio dei filosofi (2)
Nelle società del passato e nelle comunità religiose tuttora esistenti si contrappongono due punti di vista riguardo al futuro: quello degli esseri umani, che sono incapaci di prevedere il futuro se non grazie alla rivelazione della divinità e quello di una divinità onnisciente per cui la capacità di conoscere il futuro fa parte della sua stessa natura.
La divinità, ovviamente non è in grado di prevedere il futuro, se la cosa viene espressa così è a causa di una proiezione antropomorfa: è l’essere umano, essere temporale, che chiede a Dio di svelargli il proprio futuro. Il punto di vista di Dio è viceversa uno sguardo da nessun tempo e da nessun luogo. La divinità non assume una prospettiva spaziale o temporale, ma è piuttosto la totalità eterna di tutte le prospettive.
Proprio questa concezione della divinità e la riflessione metafisica a cui ha dato vita sono incompatibili con una visione orientata al futuro. In questa concezione della divinità il futuro infatti scompare, il tempo scompare: la divinità coincide con la totalità del mondo, dello spazio e del tempo e la filosofia è il tentativo di pensare questa totalità. La filosofia di Spinoza ha portato alle sue conseguenze più radicali questa concezione metafisica della divinità. Nell’atto di comprensione della totalità la visione del filosofo coincide con la visione della divinità che è a sua volta tutt’uno con la totalità del mondo.
La mistica di Eckart esprime questa intuizione attraverso la formula secondo cui l’occhio con cui guardo Dio è lo stesso da cui lui mi guarda. Riprendendo l’immagine eckartiana, Hegel descritto la sua filosofia come realizzazione dell’identità con lo sguardo assoluto della divinità (ab-solutus, sciolto da ogni legame, da ogni prospettiva determinata). Per fare questo la filosofia si deve porre, secondo Hegel, nel punto in cui tutto è già avvenuto, nel punto in cui il tempo diventa eternità. E’ in questa coincidenza con l’eternità che diventa possibile ripensare gli eventi, portarne alla luce il senso e reinserirlo nel posto che occupa in un quadro complessivo, nella totalità resa sensata che è il sapere assoluto.
Il modello di riflessione filosofica presentato da Hegel sembra dunque incompatibile con un orientamento al futuro: filosofia si può fare solo a orologi fermi, quando il tempo diventa eternità, quando tutto è già avvenuto. Essa non può cambiare nulla degli eventi passati, né dire come questi influenzeranno gli eventi futuri.
Ma proprio la fine della storia come esito del suo ripercorrimento logico-razionale nella filosofia di Hegel ha aperto alla riflessione di questo secolo un vuoto epocale. Ed esso ha, tra le altre cose, prodotto un’inversione di punto di vista, una proiezione dei modelli interpretativi hegeliani, le figure fenomenologiche anzitutto, sul presente e sugli eventi futuri di cui saranno protagoniste e spettatrici le generazioni a venire.
Il ruolo che la Fenomenologia dello spirito (1807) di Hegel ha avuto nella cultura del Novecento, ad esempio nelle filosofie dell’esistenza e nella fenomenologia, è sintomatico di questa inversione. Non si tratta solo del fatto che le strutture di senso messe in luce da Hegel nella Fenomenologia per specifici eventi come la rivoluzione francese, la polis greca o il liberalismo economico si sono poi rivelate adeguate anche a interpretare eventi contemporanei o a costruire modelli teorici per interpretare eventi futuri. E’ stata soprattutto la passione di pensare un evento come una totalità e di coglierne il senso all’interno di un processo globale di cui sono parte, di inserirli in totalità sempre più complesse e onnicomprensive ciò che la Fenomenologia ha trasmesso alla cultura di questo secolo. Nonostante Hegel descriva il cammino della coscienza dalla prospettiva in cui esso è già interamente compiuto, l’analisi delle diverse figure fenomenologiche e delle loro relazioni può costituire un modello anche per rappresentare scenari futuri e le loro possibili interazioni.
In un periodo come questo, in cui si usa constatare l’ancora carente “futurità” nei comportamenti delle società europee, varrebbe anche la pena di rileggere in questa prospettiva un breve saggio di Nietzsche Sull’utilità e il danno della storia per la vita (1874). La malattia storica indotta dall’obbligo di assimilare conoscenze in grandi quantità che spesso rimangono sullo stomaco come “pietre mal digerite” produce, secondo Nietzsche, un atteggiamento che inibisce l’azione, porta alla reiterazione delle vecchie regole, alla tutela e al culto dei costumi ereditati dai propri padri al fine di tramandarli ai propri figli ed è ostile perciò a ogni innovazione. Soltanto la storia monumentale stimola ad un’azione eroica individuale che emula le imprese dei grandi del passato. Chi agisce ispirato da questi ultimi preferisce però confrontarsi con Alessandro Magno o con Napoleone, piuttosto che con gli uomini della società in cui si trova a vivere.
Una difficile integrazione: futuro degli individui e futuro della totalità (3)
La passione per la storia, in forma sia positiva che critica (come rifiuto e condanna del passato), è stata un tratto fondamentale della cultura europea che dovrebbe avere uno spazio maggiore nella discussione attuale sull’importanza di acquisire una mentalità orientata al futuro. Attraverso di essa è possibile distinguere due dimensioni fondamentali nell’atteggiamento verso il futuro, dimensioni che chiamo qui “microfuturo” e “macrofuturo”.
Il microfuturo riguarda l’individuo e i singoli benefici che esso può trarre dal prevedere gli sviluppi futuri di un determinato evento. La previsione riguarda qui l’obiettivo che ci si è prefissato e si può dire di avere avuto un beneficio dalla previsione soltanto se si è raggiunto tale obiettivo. Per spiegare meglio la cosa prendiamo l’esempio della borsa: qui la previsione riguarda l’andamento di un’azione ed è essenziale a far decidere l’azionista se e quando vendere o comprare. Se la previsione è azzeccata essa avrà dunque come effetto un guadagno. Naturalmente è possibile immaginare un osservatore dei mercati azionari che azzecca tutte le previsioni, ma non investe nulla, né consiglia nessun altro nei suoi investimenti. Tuttavia si tratterebbe di un gioco anomalo che è del resto dipendente dal gioco normale, esso è infatti possibile solo se esistano azionisti che prevedono e poi agiscono effettivamente di conseguenza. Sul microfuturo come atteggiamento tipico della cultura anglosassone e americana e sul quello che sembra essere oggi il suo campo di applicazione prediletto, il mercato azionario, tornerò all’ostacolo n.4.
Il macrofuturo è invece il prodotto di previsioni di eventi collettivi, previsioni che non hanno come scopo quello di determinare singoli benefici per singoli individui, ma quello di seguire delle tendenze globali, di interrogarsi su questioni che riguardano intere collettività o gruppi (ad esempio l’ecologia, l’urbanistica, l’alfabetizzazione, la condizione sociale delle donne). La ricerca futurologica costruisce degli scenari in cui si individuano delle tendenze nello sviluppo (per questa ragione la futurologia si definisce anche “ricerca delle tendenze”,“Trendsforschung”, etc.) a partire da situazioni presenti e passate. Uno dei primi modelli di previsione futurologica viene creato da Dennis L. Meadows, in uno studio commissionato dal Club of Rome nel 1972.
Meadows partiva dall’analisi quantitativa di fattori determinanti come lo sviluppo demografico o la diminuzione delle materie prime nel passato per prevedere i futuri sviluppi di quegli stessi fattori. La sua indagine macrofuturologica di Meadows si ancorava immediatamente alla prevenzione di disastri di cui l’analisi metteva in luce la probabilità. Si trattava ad esempio di agire tempestivamente per impedire di lasciare alle generazioni future un pianeta desertificato e ormai completamente privo di risorse. Non è un caso che il movimento ambientalista europeo, che ha una vocazione futurologica di questo tipo, consideri l’opera di Meadows una delle sue fonti ispiratrici.
La dimensione del macrofuturo è possibile soltanto a partire da un’assunzione di natura etica, ossia dall’adozione del punto di vista di una collettività presente e futura di un certo tipo, come un valore in sé che deve essere tutelato. Carlo Bastasin nel suo libro Alexanderplatz. Da Berlino all’Europa tedesca (1996) osserva che la Germania dal dopo guerra a oggi ha puntato, più di ogni altro paese europeo, sulla “valorizzazione del presente nella preservazione del futuro” (p.225), ossia sulla realizzabilità di condizioni sociali e politiche che riguardano il benessere della società nel suo insieme e in particolare delle generazioni future. Nella Germania attuale la globalizzazione economica, che esprimerebbe solo forme di microfuturo, che riguardano cioè il profitto di determinati individui o di gruppi di individui, è considerata un fenomeno che può mettere a rischio il proprio modello di macrofuturo. Esso va però distinto anche dalle visioni del futuro elaborate agli inizi del secolo precedente, in cui il socialismo e la Chiesa fornivano alle masse un sistema di valori.
In questa opposizione di macrofuturo e microfuturo si scontrano, secondo Bastasin modello tedesco da un lato e modello anglossassone ed americano. E’ prevedibile che nel compimento dell’integrazione europea questo contrasto si acuirà ulteriormente opponendo sia gli stati della Comunità Europea tra di loro sia Europa e Stati Uniti. E’ sempre Carlo Bastasin che scrive: “l’intolleranza con cui gli anglosassoni osservano e criticano il modello tedesco nell’economia sociale di mercato è legato al fatto che questo modello mette in questione qualche cosa di più del modello anglosassone dove tutto ciò che conta è la libera concorrenza, l’economicità delle azioni e la razionalità (l’ottimizzazione) di breve termine. Un sistema come quello tedesco dove gli obiettivi non sono mai di breve termine, dove il profitto di un anno può essere sacrificato in previsione del futuro, viene percepito come un atto di accusa agli anglosassoni che legittimano comportamenti più simili alla massimizzazione soggettiva, finendo per far la figura degli egoisti” (p.170). Ma le controaccuse degli anglosassoni al modello tedesco non sono solo difensive e infondate. La pianificazione di un futuro di benessere per l’intera comunità nell’economia sociale di mercato tedesca si è servita di un sistema di consenso e di controllo a base prevalentemente emotiva delle credenze e dei valori dei cittadini, un sistema dunque che presuppone una struttura gerarchica e una forte asimmetria tra governanti e governati che devono essere indotti a comportarsi in modo da realizzare le previsioni compiute dai governanti.
Da questo punto di vista è certamente un limite di alcune posizioni del dibattito attuale sul ‘futuro del macrofuturo’ che la caduta del sistema di credenze e di relazioni collettive del cattolicesimo e del socialismo sia considerata come un elemento negativo e che si ritenga necessario trovare dei sostituti sostanzialmente uguali in grado di appagare il presunto bisogno di sicurezza e tutela delle masse. Di fronte a questo atteggiamento, con cui parte dell’élite intellettuale europea sembra considerare insuperabile l’opposizione tra i governanti capaci di ragionare e la massa bisognosa della retorica della tranquillizzazione, la cultura anglosassone ha buon gioco di rivendicare per sé i valori della libertà e della democraticità e anche una diversa concezione di uguaglianza.
La paura dell’errore (4)
La passione del mondo anglosassone è indubbiamente, come osserva Bastasin, il microfuturo, ossia la pianificazione adeguata da parte degli individui del proprio futuro allo scopo di garantirsi il successo economico, sociale e culturale.
Questo gioco con il futuro si esprime al meglio nelle previsioni fatte dagli agenti del mercato azionario. Qui la previsione è tipicamente a breve o medio termine ed è immediatamente legata a una conseguenza pratica, la perdita o la vincita dell’azionista. Il fatto che si tratti di previsioni a breve o medio termine e relative a un oggetto ben preciso (le azioni) dovrebbe rendere il rapporto degli individui con il microfuturo in questo piuttosto semplice e accessibile. In realtà è vero esattamente il contrario: in un mondo di agenti economici privi di regole e di controllo statale, le variabili e le possibilità da considerare nella previsione sono talmente tante che è praticamente impossibile non sbagliare. Ed è proprio il rapporto con l’errore a costituire uno dei punti di opposizione più importanti tra mentalità microfuturologica e macrofuturologica. Il tema dell’atteggiamento individuale e collettivo rispetto all’errore e dei suoi risvolti politici e sociali è infatti centrale rispetto alla mentalità futurologica.
Il sistema pedagogico tuttora dominante in Europa si fonda sulla capacità di istillare la paura dell’errore. In un modello come quello anglosassone e statunitense (che promuove l’affermazione individuale, lo spirito di iniziativa e di innovazione) esitare ad agire (e soprattutto agire in modo nuovo) per paura di sbagliare è evidentemente un intralcio, viceversa in un modello sociale tradizionale che tutela lo status quo del sistema socio-economico esistente istillare la paura dell’errore è piuttosto funzione dell’autoconservazione della totalità.
Dal punto di vista della tradizione si sbaglia anche quando si percorrono strade nuove su cui non c’è ancora consenso sociale. Studi sociologici hanno mostrato che proprio nelle società più tradizionali l’errore è associato a sentimenti come forte imbarazzo e vergogna, mentre nelle società occidentali si sente spesso manifestare l’attonita, snobistica constatazione secondo cui la gente non si vergogna più di nulla, cosa che si dovrebbe da un certo punto di vista accogliere con sollievo (auspicando semmai che sia la consizione di manifestazioni culturali più complesse, personali e meditate), visto il carattere paralizzante, conservatore e assolutamente non produttivo di un’emozione viscerale come la vergogna.
Tuttavia le istituzioni scolastiche e accademiche rimangono comunque, in questo senso, roccaforte della tradizione: i docenti hanno la facoltà di decidere cosa è o cosa non è un errore, senza che su questo vi siano per lo più possibilità istituzionalizzate di discussione, contrattazione e critica da parte dei discenti. Qui la paura dell’errore, l’ansia da esame sono ancora sentimenti diffusissimi a cui si aggiungono quelli di vergogna e di umiliazione (sollecitati da atteggiamenti vari, ben noti a tutti) nelle situazioni a cui viene data una valutazione negativa.
L’abito di accettare la tradizione come portatrice di verità indiscussa, la cultura dell’auctoritas sono stati oggetto di una critica radicale almeno dall’Illuminismo. Tuttavia quello dell’esame critico della tradizione e della sovranità intellettuale ed emotiva di fronte alle controreazioni da parte dell’autorità sono rimasti fenomeni minoritari.
Dal punto di vista della programmazione politica del macrofuturo ciò offre indubitabili vantaggi. Il fatto che i cittadini accettino credenze ricevute e proseguano in modelli di comportamento tradizionali è una grossa agevolazione per la previsione e la pianificazione politico-economica, così come, in modo particolarmemente accentuato in Italia, per la perpetuazione indiscussa di una classe politica e dirigente del tutto refrattaria a qualsiasi trasformazione e cambio generazionale.
Per questo in modo più o meno consapevole, il modello politico e l’economia sociale di mercato tedesca, hanno guardato con irritazione le innovazioni che introducono variabili che richiedono di pensare una serie di effetti a catena, mutando ad esempio profondamente modi di comunicare, di consumare, di trascorrere il tempo libero.
Non è un caso, come ha ricordato in diverse occasioni il settimanale tedesco “Der Spiegel”, che proprio la ricerca futurologica tedesca, all’inizio degli anni novanta, considerò l’esplosione della professione di programmatori e creatori di software un fenomeno passeggero destinato ad estinguersi in pochi anni.
La Germania non riuscì ovviamente neppure a prevedere in anticipo le enormi potenzialità di Internet in fatto di trasformazioni sociali, crescita economica e creazione di posti di lavoro. Una conseguenza di questo errore è che il paese si è trovato, tra le altre cose, privo di migliaia di informatici che l’ex governo socialdemocratico di Schröder, attraverso un progetto finalizzato a questo scopo, ha cercato, con esiti variabili, di importare dall’India. Una delle cause di questo insuccesso previsionale è stata probabilmente l’inclinazione della programmazione socio-economica a considerare le innovazioni anzitutto come scomodo intralcio al proprio lavoro.
Chi pianifica lo stato sociale, facendosi carico del benessere della collettività presente e futura ha la vita più facile se in essa un numero estremamente basso di individui, più capaci dei pianificatori di cogliere le potenzialità di ogni nuova innovazione, ne traggono velocemente il massimo profitto. Sul piano politico molte nazioni europee orientate allo stato sociale si sono servite di vincoli legislativi per tenere a freno questi individui, sul piano psicologico essi sono stati frenati, come si diceva, anche con lo spauracchio dell’errore, con la paura di rischiare, mentre sul piano etico li si è combattuti attraverso la convinzione che grosse disparità di condizioni economiche sociali tra esseri umani debbano essere evitate con ogni mezzo, soprattutto se producono situazioni di miseria nella maggioranza. Il modello individualistico neoliberalista solitamente contesta allo stato la legittimità e i vantaggi dei vincoli che pone al libero mercato, denuncia come illusoria ed ipocrita l’etica altruistica dell’egualitarismo e rivendica il diritto di pensare e agire con la più assoluta libertà individuale.
Per vincere l’atteggiamento psicologico che è alla base della politica dei vincoli e della burocratizzazione di cui tanto si parla l’Europa non potrà che fare perno sull’eliminazione della nevrosi da errore e sulla struttura retorico-ideologica su cui si innesta.
Il segnale della possibilità di un’integrazione proficua tra microfuturo e macrofuturo viene dal mondo anglosassone ed esemplare in questo tempo è l’esperienza dell’investitore finanziario Geoge Soros, uno degli uomini più ricchi e influenti del mondo. Nella Crisi del capitalismo globale (1999), interrogandosi sulle ragioni del suo successo professionale, Soros racconta che esso è stato prodotto anzitutto dalla capacità di non aver paura di scoprire errori nelle proprie scelte di azionista e di dedicarsi anzi accanitamente a scoprirne sempre di nuovi. Soros ha finito per accorgersi che la sua propensione a scoprire in modo veloce e sistematico i propri errori è un dono raro e che la maggior parte delle persone è viceversa incline a ignorare i propri errori e a concentrare l’attenzione su ciò che ha fatto bene, piuttosto che su quello che si può migliorare. A questa doppia ragione (non solo la passione per la perfettibilità di Soros, cioè, ma anche la carenza della medesima nella maggioranza degli individui) si deve, a suo avviso, la straordinaria fortuna che egli si è costruito sul mercato borsistico. Individuando rapidamente gli errori che aveva fatto nel valutare un’azione, Soros era infatti in grado di comprare o vendere molto prima degli altri azionisti. La rapida scoperta dei propri errori e il conseguente costante perfezionamento delle sue azioni di speculatore sul mercato globale sono espressioni di capacità che Soros ha al principio usato solo per il proprio vantaggio economico, compiendo esclusivamente previsioni nell’ambito del microfuturo.
La previsione conservatrice: l’inferenza percettiva (5)
Promuovere il superamento della paura dell’errore è un passo essenziale per sviluppare una mentalità orientata al futuro in grado di integrare dimensione micro- e macrofuturologica. Ma si può vincere davvero la paura di fare errori quando si cerca di prevedere il futuro? O la paura dell’errore, oltre che un prodotto culturale, è anche un indispensabile dispositivo cognitivo forgiato dall’evoluzione senza il quale la specie umana, e non solo essa, non sarebbe mai sopravvissuta?
Quando si affronta il tema delle previsioni futurologiche si usa sempre premettere che è impossibile avere la certezza che una determinata previsione si avvererà. Ma per quanto riguarda la probabilità che si verifichi un evento ipotizzato c’è una differenza nettissima tra previsioni a medio/lungo termine e previsioni a breve termine basate su inferenze percettive intorno all’ambiente circostante. Questa capacità inferenziale, che è stata descritta, fin dall’antichità, dalle teorie del segno naturale, fa sì che da un cielo annuvolato, dal ringhio o dall’atto di scoprire i denti di un cane, dalle orme su un terreno si possano fare ipotesi su quello che accadrà (o anche, come nel caso delle orme, su quello che è già accaduto) ed eventualmente scegliere anticipatamente il tipo di azione più adeguato all’inferenza compiuta. Ancora più sofisticato è l’insieme delle valutazioni che possiamo trarre, a livello conscio e inconscio dal comportamento, dai gesti, dall’espressione e dall’atteggiamento complessivo di altri individui. Naturalmente anche in questi casi possiamo commettere errori. Si tratta però di errori nel complesso talmente poco frequenti che sviluppiamo presto un sentimento di fiducia, di certezza riguardo a questi sistemi di inferenze.
Per agevolare ulteriormente questa capacità previsionale della mente, le culture umane hanno sviluppato un insieme di abiti, riti e tradizioni che rendono l’ambiente circostante il più possibile prevedibile. Si può dire cioè che nel costruire i propri ambienti culturali gli esseri umani tendono ad aumentarne la prevedibilità in modo tale da riuscire a conoscere in anticipo la maggior parte delle risposte. L’ambiente culturale viene perciò incontro al bisogno umano di prevedere gli eventi, per questo il passaggio ad un ambiente culturale sconosciuto, e quindi solo in minima parte prevedibile, è assai meno tranquillizzante e implica un impiego molto superiore di attenzione, visto che non si può più fare conto sulla fiducia in inferenze ormai automatiche.
Questa previsione naturale, istintiva degli eventi corrisponde a una psicologia molto conservatrice: chi difende il modello flessibile di un ambiente in perenne trasformazione o dà per certo che la popolazione del futuro sarà in perenne movimento non può non soffermarsi sugli ostacoli psicologici e quindi sulle forti resistenze che hanno gli individui al cambiamento continuo, visto che esso mette in scacco il sistema istintivo di previsioni che si sono costruiti abitando sempre lo stesso ambiente. Nessun appello alla flessibilità è sensato se non si interroga su quali meccanismi psicologici si oppongono alla possibilità di un riadeguamento continuo a una realtà in perpetuo mutamento.
Il sentimento di paura e di incertezza che suscita un luogo o una situazione nuova, nonostante le variazioni individuali, anche notevoli, tra pavidi e audaci, pigri e curiosi, abitudinari ed esploratori, è dunque comune alla maggior parte degli esseri umani a causa del suo valore adattativo, ossia per i vantaggi rispetto alla sopravvivenza che dà agli individui che lo possiedono. In tale atteggiamento risiede forse anche una delle ragione della progressiva omogeneizzazione del territorio urbano in tutto il pianeta che va di pari passo con il progredire della globalizzazione e, in particolare, del turismo come movimento planetario. Questo indubitabile impoverimento della molteplicità delle culture umane è spesso ascritto a malvagità o noncuranza da neocolonizzatori degli occidentali. Ricordare che il comportamento che lo produce è viceversa il più istintivo non significa affatto, ovviamente, legittimarlo, ma piuttosto invitare a rendersi davvero conto dell’impegno che richiede superarlo.
Perciò non si può mai sottolineare abbastanza il fatto che l’inclinazione a sfuggire situazioni sconosciute, a cui si può non essere in grado di far fronte in modo adeguato, ha avuto nell’evoluzione una ragione adattativa essenziale. In un ambiente con scarse risorse alimentari, molti animali pericolosi e altri gruppi umani aggressivi, compiere un errore significava mettere a repentaglio la propria vita. Poiché è probabile che in un tale ambiente evolutivo siano vissuti gli esseri umani e le specie da cui deriva la specie umana per milioni di anni non stupisce che la paura dell’errore sia una disposizione psicologia così diffusa.
Certo si può obiettare che nelle società contemporanee buona parte degli errori che gli esseri umani fanno non sono errori fatali, almeno considerati singolarmente - ma è del resto difficile valutare il ruolo che essi, interagendo con molti altri fattori, hanno nel determinare eventi futuri.
Tuttavia la paura dell’errore è un sentimento che viene suscitato in modo istintivo e immediato prima che si valuti se è razionale o no provarlo, o se si tratta eventualmente di errori rimediabili. Inoltre, in ambito culturale, anche un errore banale può essere spesso equiparato a un errore fatale per la disapprovazione sociale a cui viene collegato e ciò può renderlo più sgradevole degli effetti che realmente produce.
Se consideriamo dunque che per quanto riguarda la paura dell’errore si sommano ragioni di ordine evolutivo e di tipo culturale (in cui l’errore può essere associato al disonore o almeno a un disvalore personale), si capisce perché la psicologia dell’azionista Soros, che sa che la sua capacità di individuare in modo rapido e spietato gli errori è l’unica vera garanzia del suo successo, sia ancora tanto poco diffusa.
Gestire la riflessività (6)
La sesta difficoltà futurologica riguarda il rapporto tra la previsione e l’influenza che essa ha sul verificarsi degli eventi previsti. Questa relazione rientra in ciò che Popper descrive come riflessività o comportamento riflessivo. Soros, che è stato allievo di Popper alla London School of Economics, si è servito di questo concetto per spiegare il ruolo che hanno sull’andamento dei mercati le credenze degli azionisti e le informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione. Enunciati riflessivi sono gli enunciati il cui valore di verità dipende dall’effetto che producono, mentre l’effetto che producono dipende a sua volta dal fatto di essere o meno ritenuti veri. Tutti gli enunciati di valore (di cui fanno parte anche i giudizi etici) hanno, secondo Soros, un carattere riflessivo.
Soros sostiene che la riflessività agisce in modo simile al livello del profitto dei singoli e a quello dell’interesse della collettività. L’effetto riflessivo si applica quindi anche a un progetto globale. In questo caso si tratta per Soros di convincere i suoi lettori anzitutto di due cose: 1) per salvare il capitalismo mondiale, è necessario regolamentare i mercati; 2) la logica amorale del profitto individuale non è in grado da sola di garantire il benessere collettivo; a questo scopo sono necessarie azioni specifiche di più individui a livello politico e sociale.
E’ significativo inoltre che proprio attraverso la sua esperienza di osservatore dei mercati globali sia maturata in Soros la convinzione, esposta nella Crisi del capitalismo globale, che è necessario affiancare il punto di vista dell’agente amorale dei mercati economici a quello della regolamentazione statale, il punto di vista privato del profitto individuale a quello politico del benessere della collettività, il punto di vista del microfuturo dunque a quello del macrofuturo.
Se si convincono le persone che è necessario impegnarsi per il benessere della collettività e che per fare questo bisogna agire collettivamente a livello politico e non solo come singoli benefattori, esse sosterranno dei governi che si impegnano nella realizzazione di questi valori. Ma, secondo Soros, sul macrofuturo la riflessività agisce in maniera persino più diretta che nelle microprevisioni del mercato: se tutti gli individui si convincono che valori come la collettività e la tutela dei beni comuni sono essenziali si impegneranno in azioni politiche che realizzeranno questi valori, mentre una previsione sul mercato finanziario, pur cogliendo un aspetto reale può rivelarsi inefficace per il prevalere di altri effetti riflessivi derivanti da previsioni di altri azionisti, da giudizi di osservatori influenti, da azioni politiche, etc.
L’aspetto forse più interessante dell’effetto riflessivo, riguarda, nel nostro caso, il modo in cui agirà sulla mentalità orientata al futuro. Si tratta cioè di chiedersi se la capacità di immaginare scenari globali, la cosiddetta futurità, non influirà essa stessa in modo determinante sugli sviluppi futuri delle società. L’economia fondata sulla conoscenza di cui si parla tanto in questo periodo ha infatti come sua condizione la nascita di una società globale di individui con un grado di istruzione infinitamente più alto e più diffuso di quello di tutte le società del passato. L’opposizione tra l’approccio intellettuale di chi agisce ossia tra una minoranza che produce valori e modelli culturali e la maggioranza che li riceve e li fa propri passivamente, oppure li rifiuta, senza proporre in modo creativo possibilità alternative, non ha più nessuna ragione d’essere in una società in cui non c’è disparità di istruzione e conoscenze, mentre era, viceversa, nettissima nelle comunità del passato, ad esempio nel cattolicesimo, che, non a caso, ha scoraggiato la diffusione dell’alfabetizzazione e la politica dell’istruzione obbligatoria per tutti i cittadini e le cittadine.
E’ necessario allora chiedersi in che modo sia possibile favorire lo sviluppo di un sistema di valori collettivi alla cui elaborazione contribuiscono un numero sempre maggiore di individui e in cui ci sia uno scambio sempre più equilibrato tra produttori e riceventi di valori, idee e modelli culturali.
E’ plausibile immaginare uno scenario in cui tutti i fruitori di conoscenze, narrazioni e valori sono al tempo stesso anche produttori e in cui dunque le disparità in fatto di conoscenze sono minime e l’assenso a determinate credenze non è per nessun fruitore di natura solo emotiva? Ed è possibile ipotizzare che la crescita di strumenti tecnologici come Internet e dei loro utenti sia una condizione che favorirà o, persino, renderà inevitabile questa nuova forma di scambi culturali simmetrici e di diffusione e approfondimento capillari di conoscenze e valori sociali?
L’opposizione tra manovranti e manovrati nell’epoca del controllo globale (7)
L’ipotesi di un rapido superamento globale delle disuguaglianze di formazione ad opera della rivoluzione informatica sembra piuttosto improbabile. Anzitutto perché l’uso di Internet non produce necessariamente nuovi metodi di apprendimento e nuovi valori sociali e politici, almeno finché più utenti non cominciano a interrogarsi discutere insieme sul senso e sulle potenzialità di questo uso, sui nuovi costumi che produce, etc..
Attualmente l’aspetto che più colpisce nell’uso della Rete è l’enorme possibilità di controllo sugli individui che rende possibile: attraverso Internet si possono avere informazioni su milioni di persone sparse in tutto il mondo e, attraverso la pubblicità (oggi il principale introito delle imprese Internet), è possibile orientare, assecondare o deviare gusti, preferenze e convinzioni, creare nuovi desideri e bisogni attraverso l’offerta di nuovi servizi.
Probabilmente tutto ciò rimarrà a lungo monopolio di una minoranza. Infatti anche nell’ipotesi, peraltro del tutto improbabile, che, in pochi decenni, il 100% degli abitanti del pianeta avrà accesso a Internet (il che presuppone un’ancor più improbabile alfabetizzazione globale) e che tutti potranno teoricamente avere accesso a informazioni dettagliate riguardo a gruppi di persone in ogni parte del pianeta, la separazione tra manovrati e manovranti rimarrà netta.
Non si tratta infatti tanto di una questione di mezzi tecnici disponibili, ma del tipo di atteggiamento e di mentalità che rende possibile un certo uso di questi mezzi, quello appunto dei manovranti: mentre infatti ciò che chiamo “essere manovrati” si fonda su un certo tipo di comportamenti istintivi che sono riconducibili alla capacità di adattarsi ad un ambiente dato (corrispondente a quel tipo di atteggiamento previsionale conservatore ed evolutivamente antico di cui si parlava al punto 5), l’essere manovranti, ossia, in accezione positiva, produttori e agenti autonomi e responsabili è un atteggiamento che appare ai più anormale, il prodotto di un modo di vedere le cose che è ancora del tutto estraneo alla maggioranza.
Non è un caso che un film come Truman Show, che presentava una figura di manovrante, il regista di reality show che era tale solo per il suo protagonista, con connotati estremamente negativi, abbia destato molto sconcerto. Gli spettatori consideravano inquietante la prospettiva di poter essere sottoposti a un controllo globale come quello a cui è sottoposto Truman, attore a sua insaputa fin dalla sua nascita di una soap opera globale che coincide completamente con la sua vita.
Tuttavia il gradimento riscosso in tutto il mondo dai vari reality show, in cui le persone accettano di farsi riprendere istante per istante nella loro vita di ogni giorno in situazioni normali o eccezionali (ad esempio in isole deserte), dimostra che alle persone non dispiace mostrarsi al mondo anche nei momenti più intimi della loro vita privata. Quello che più probabilmente inquieta in Truman Show è, appunto, l’opposizione tra manovrato e manovrante. Il manovrante è il regista della soap opera e assume un ruolo simile a quello che l’umanità per millenni immaginò essere il ruolo di Dio. Il regista ha creato o pretende di aver creato per Truman il migliore dei mondi possibili e conduce in effetti una vera vita da creatore assorbito a seguire e filmare passo dopo passo la vita della sua creatura..
L’aspetto più significativo della vicenda è che, mentre la vita del manovrante, che deve progettare passo passo la sceneggiatura della vita reale di un solo uomo, è del tutto diversa da quella della maggior parte delle persone, la vita del manovrato, di Truman, è del tutto simile a quella di tantissimi normali cittadini americani. Un’esistenza fatta di spot televisivi, di bisogni indotti dalla pubblicità dei nuovi prodotti, di condizionamenti inconsci ad opera dei mezzi di comunicazione non è una maledizione personale di Truman. In una condizione molto simile si trovano già i cittadini dell’occidente più ricco e ci si troveranno sempre più in futuro gli utenti di Internet di cui è possibile avere un identikit molto preciso che comprende le possibilità finanziarie, le preferenze in fatto di macchine, viaggi, vestiti, cibi, vini, programmi televisivi e persino le malattie di cui soffrono e i medicinali usati.
Questo fatto è per lo più avvertito in maniera confusa e con confuso scontento da chi si trova nella condizione del manovrato. Si ha tuttavia l’impressione che il manovrato, più che essere scontento di essere manovrato, è ostile al manovratore a cui involontariamente procura un vantaggio. Egli trascura così il fatto che il punto di vista globale, esemplificato dalla Rete, ma non coincidente con essa, prescinde dal vantaggio che da esso si può eventualmente trarre (al contrario di quanto accade sui mercati finanziari v. ostacolo 3); esso è insomma estraneo sia alla logica del manovratore che a quella del manovrato. L’assunzione di questo punto di vista non coincide affatto con l’atto stesso di manovrare, si tratta piuttosto di un’estensione dello sguardo che mira a ottenere un’informazione il più possibile esaustiva, ma può anche opporsi dall’interno alle manipolazioni ed esercitare un’azione costante di vigilanza critica contro gli abusi.
Il punto di vista globale non è dunque necessariamente quello dell’ottimizzatore, ossia non è causato dall’intenzione di massimizzare i profitti: certo se il punto di vista globale è assunto allo scopo di ottenere profitti, come nei mercati finanziari, allora chi è in grado di ottenere più informazioni nel modo più rapido ed estensivo è effettivamente in grado di massimizzare i profitti.
Tuttavia la posta in gioco più importante nel caso di questa nuova rivoluzione tecnologica è l’acquisizione di nuova strategia di natura etica e cognitiva, di un diverso modo di pensare, non un vantaggio di natura pratica: il piacere che si trae dall’approdare a questa dimensione di senso relativo alla totalità prodotta dalla quella rivoluzione non può essere messo allo stesso livello di nessun beneficio utilitarista.
Si può ironizzare sul fatto che solo dopo essere diventato l’uomo più ricco del mondo Soros si è reso conto che la ricchezza da lui raggiunta era incommensurabilmente maggiore anche dell’immaginazione più fervida nell’inventarsi nuovi oggetti di desiderio e che solo allora il punto di vista del profitto individuale gli sia apparso molto meno attraente e sensato di quello del futuro della totalità, di tutto il pianeta. E’ un fatto però che il suo interesse prevalente sia diventato il macrofuturo e la sua passione la politica economica mondiale. Ha cominciato quindi a fare da consulente a Paesi colpiti dalla crisi economica come la Russia ed è diventato un filantropo su scala planetaria costituendo la Fondazione Open Society che sostiene le società dell’Europa dell’est nel loro processo di democratizzazione.
Perché il punto di vista globale si imponga a tutti i cittadini del pianeta portando alla realizzazione di governi veramente democratici ovviamente non basta Internet, e neppure che un film come Truman Show suggerisca al mondo intero che si è ormai arrivati a un grado di sviluppo tecnologico tale da controllare a sua insaputa un individuo dalla nascita alla morte.
L’unica soluzione contro questa eventualità sembra proprio quella di oltrepassare l’opposizione tra governanti e governati, almeno nelle forme politiche tradizionali in cui la delega e una forma di assenso prevalentemente emotiva giocano un ruolo fondamentale. Nell’interazione sociale ci si regola ancora in massima parte secondo valori, credenze e tradizioni ereditate e solo una formazione che sia decisamente orientata a tale scopo permette di superare un’adesione acritica a giudizi di valore ricevuti. I credo religiosi e politici agiscono ancora secondo una logica oppositiva, secondo un modello amico-nemico che ha una fortissima connotazione emotiva. Questo modello che ha dominato per secoli la cultura occidentale fa sì che, nella politica si tenda sempre a selezionare le informazioni che servono a confermare le proprie credenze e inclinazioni naturali, mentre si trascurano – sia istintivamente che deliberatamente - quelle che le smentiscono.
Per sostituire con questo tipo di interazione una mentalità neutrale capace di confrontarsi con sistemi complessi e sintesi di credenze e valori senza cercare subito amici e nemici, buoni e cattivi, è necessario un cammino lungo e faticoso, un’educazione critica che si sostituisca alla tuttora dominante pedagogia pavloviana a base di premi e punizioni.
Se non capiscono questo le società laiche dell’Occidente finiranno forse per vincere le forme di controllo oppressivo e sanguinario che ancora oggi, in alcune regioni del mondo, esercitano le religioni, ma non creeranno mai delle vere democrazie globali.
E’ in questa direzione che, nel sintetizzare il proprio modello di istruzione e di scuola, Tullio De Mauro mette in evidenza la capacità che esso deve avere di creare “un mondo in cui tutte e tutti possono essere a turno governanti e governati” e in cui perciò “tutte e tutti abbiano una sufficiente dote di compentenze per muoversi liberamente nello spazio delle società e delle culture (alte e basse, tecniche e intellettuali) e per capire la follia dello scannarsi a vicenda tra popoli, culture e credenze” (De Mauro 2004).
Riferimenti bibliografici
Bastasin, C. (1996) Alexanderplatz. Da Berlino all’Europa tedesca, Milano: Feltrinelli.
De Mauro, T. (2004) La cultura degli italiani, a cura di Francesco Erbani, Bari: Laterza.
Hegel, G. W. F. (1972) Fenomenologia dello spirito (1807), Firenze: La Nuova Italia.
Ianneo, F. (1999) Memi, Roma: Castelvecchio.
Nietzsche, F. (1994) Sull’utilità e il danno della storia per la vita (1874), Milano: Adelphi.
Soros, G. (1999) Crisi del capitalismo globale, Milano: Ponte delle Grazie.