| Segnala il documento | Stampa | ||||
| Prefazione a "On Liberty" di J. S. Mill in Saggio sulla libertà, Milano, Il Saggiatore (1981, 1991) |
| di Giulio Giorello e Marco Mondadori |
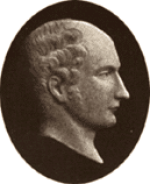
Libertà. Frase da conservatore.
Flaubert, Dizionario dei luoghi comuni.
«Napoli, 17 febbraio 1855
[ ... ] Piú penso al progetto di un volume sulla Libertà, piú mi convinco che sarà letto e farà sensazione1. »
Cosí Mill a Harriet Taylor in una lettera spedita nel corso del suo viaggio in Italia. Il saggio veniva pubblicato tre anni dopo, nel 1858, poco dopo la morte di Harriet, cui è dedicato. Tra il 1861 e il 1870, curando la revisione finale della propria Autobiografia, Mill precisava:
« La Libertà probabilmente sopravviverà piú a lungo di qualsiasi altro mio scritto. [ ... ] Ciò perché l'unione della sua [di Harriet Taylor] mente con la mia ha fatto di quel saggio una specie di manuale filosofico su una singola verità cui i cambiamenti verificantesi progressivamente nella società moderna tendono a dare un rilievo sempre piú forte: vale a dire l'importanza per l'uomo e la società di una larga varietà di caratteri e di una completa libertà della natura umana di espandersi in direzioni innumerevoli e contrastanti2.»
Tale esito - questa è l'argomentazione dominante in On Liberty - è determinato da istituzioni disegnate in armonia con il principio secondo cui « l'umanità è giustificata, individualmente o collettivamente, a interferire sulla libertà di azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi: il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di una comunità civilizzata contro la sua volontà è per evitare danno agli altri3»
Si tratta evidentemente di un principio forte di limitazione dell'intervento statale in tutte le sfere della società civile, e piú specificamente di limitazione del raggio d'azione della cosí detta « majority tale » alle pratiche sociali che danneggino positivamente gli interessi di gruppi di persone non coinvolte volontariamente nelle stesse. Proprio per questo, « On Liberty è píú importante per noi oggi del suo libro sulla Subjection of Women. È piú importante perché la causa che sostiene ha avuto meno successo. C'è, nel complesso, molto meno libertà oggi di quanta ce ne fosse cento anni fa; e non c'è ragione di supporre che le restrizioni sulla libertà siano destinate a diminuire in un futuro prevedibile »4. Così B. Russell nel 1951. Questa tendenza persiste - e non è certo estranea a proposte di democrazia « avanzata », come ad es. i due modelli di « democrazia partecipativa »5 di Macpherson, o al modello di « democrazia di massa »6 di Ingrao. I contorni di questi modelli non sono affatto chiari. Tuttavia, questa tendenza è implicita in tutte le forme di « partecipazione » che vadano oltre quelle costitutive della « democrazia di sviluppo »7, già caratterizzate in forma paradigmatica, sulla base di un caso storico, da A. de Tocqueville in La Democrazia in America. La miglior ridescrízione è quella dello stesso Mill: « Tocqueville vede la causa prima della libertà americana e la sua sicurezza non tanto nell'elezione del Presidente e del Congresso tramite suffragio popolare, quanto nell'amministrazione di quasi tutti gli affari della società da parte del popolo stesso. [ ... ].La distribuzione di cariche amministrative il piú estensivamente possibile nella massa popolare costituisce, per il nostro autore, il solo mezzo per renderla atta a un'efficiente partecipazione alla direzione della cosa pubblica. [ ... ] Comunque possano essere strutturate altre costituzioni, il carattere di un popolo sarà, ne siamo persuasi, essenzialmente volgare e servile, ove lo spirito pubblico non venga coltivato grazie a una partecipazione estensiva dei piú agli affari del governo [ ... ] »8.
Non basta. Lo stesso Mill che - riprendendo Tocqueville - individua nella partecipazione uno degli strumenti piú efficaci per l'educazione di larghe masse alla gestione della cosa pubblica e all'esercizio delle libertà, vede proprio in essa una possibile minaccia alla realizzazione del « principio di von Humboldt »: l'assoluta ed essenziale importanza dello sviluppo umano nella sua piú ricca diversità, che costituisce il « motto » di On Liberty9 . In circostanze ben specificate, in circostanze in cui cioè « il livellamento delle condizioni di vita ha compiuto maggiori progressi dello spirito di libertà »10, questo stesso meccanismo di partecipazione tenderà a produrre « quello che il Nostro [Tocqueville] definisce "il dispotismo della maggioranza" »11 . « La tirannia che ci fa paura, ed è sommamente temuta dal Tocqueville, è di un altro genere - e non opera sul corpo, bensí sullo spirito »12. « Quindi, la protezione dalla tirannide del magistrato non è sufficiente: è necessario anche proteggersi dalla tirannia dell'opinione e del sentimento predominanti, dalla tendenza della società a imporre come norme di condotta, con mezzi diversi dalle pene legali, le proprie idee e usanze a chi dissente, a ostacolare lo sviluppo - e a prevenire, se possibile, la formazione di qualsiasi individualità discordante, e a costringere tutti i caratteri a conformarsi al suo modello »
Il limite cui tende questo processo era stato anticipato da Bentham nel suo Panopticon: il progetto di una prigione-modello, di una prigione in cui l'ispettore ha la facoltà di vedere a colpo d'occhio tutto quello che succede; una prigione circolare dove un ispettore è nella posizione di controllare tutte le celle disposte concentricamente intorno a una torre centrale: un sistema di schermi rende invisibile l’ispettore che vede tutto. «essere incessantemente sotto gli occhi dell’ispettore significa perdere di fatto la capacità di fare del male, se non addirittura il desiderio di farlo »13 . Sostituiamo all'ispettore di Bentham l'opinione pubblica di Tocqueville e di Mill e otteniamo quella degenerazione della democrazia di conflitto temuta da entrambi: « trovandosi tutti piú o meno sul medesimo piano per quanto riguarda le condizioni economiche, e similmente dal punto di vista dell'intelligenza e del sapere, l'unica autorità che ispira una involontaria deferenza è quella del numero. [ ... ] "La fede nell'opinione pubblica", dice Tocqueville, "diventa in quelle contrade una specie di religione, e la maggioranza è il suo profeta" »14
Ancora nella sua recensione a La Democrazia in America, Mill identificava chiaramente il disagio della democrazia di conflitto nella possibilità implicita nella « majority rule » di determinare una stagnazione intellettuale e morale. La Cina giocava il ruolo di contromodello. « Il moderno dominio della pubblica opínione è - in forma disorganizzata - ciò che il sistema educativo e politico cinese è in forma organizzata; e se l'individualità non riuscirà a farsi valere contro questo giogo, l'Europa, nonostante il suo nobile passato e il suo proclamato Cristianesimo, tenderà a diventare un'altra Cina ». Ma, « se tutte le cose che sono diventassero fumo, le narici le riconoscerebbero come distinte l'una dall'altra »15 . Fuor di metafora, l'uniformità di modi di vita, di opinioni, di interessi cui tende a degenerare una democrazia di conflitto, è contrastata da uno dei principi costitutivi di quest'ultima: il principio di von Humboldt. « Non è solo l'incontrollata ascesa del potere popolare a essere formidabile, ma quella di qualsiasi forza. Non esiste potere in seno alla società la cui influenza non diventi dannosa quand'esso regni incontrollato, non appena divenga esente da qualsiasi necessità di essere nel giusto, o allorché sia in grado di far prevalere la propria volontà senza previa lotta16»
Il conflitto, il dissenso tra diversi punti di vista, sono dunque garanzie di base di una società aperta17 . In questo, un grande modello è la dinamica della conoscenza scientifica. « In ogni campo in cui è possibile una differenza di opinioni, la verità dipende dall'individuazione dell'equilibrio tra due gruppi di ragioni contrastanti. Anche nella filosofia naturale, è sempre possibile fornire un'altra spiegazione degli stessi fatti; una teoria geocentrica invece di quella eliocentrica; il flogisto invece dell'ossigeno [ ... ] » . « Se si vietasse di dubitare della filosofia di Newton, gli uomini non potrebbero sentirsi cosí certi della sua verità come lo sono. Le nostre convinzioni piú giustificate non riposano su altra salvaguardia che un invito permanente a tutto il mondo a dimostrarle infondate ». Mill coglie qui l'intreccio tra crescita della conoscenza e critica: la proliferazione di teorie rivali come fattore di progresso scientifico. Cent'anni dopo riscopriranno questo punto di vista I. Lakatos e P. Feyerabend18; contro lo stesso Mill che aveva tentato di salvare « le verità matematiche » dalla precarietà di ogni ipotesi scientifica esposta al vaglio della critica. La congettura di Eulero, il principio di continuità di Cauchy o magari il principio di Dirichlet o ancora le funzioni generalizzate di Dirac, il labirinto degli infinitesimi, « l'immenso oceano » degli indivisibili19 : tutti casi in cui almeno una ricostruzione razionale ha scoperto il ruolo decisivo del conflitto intellettuale, della dialettica di obiezione e risposta, nella costruzione di soluzioni a problemi mal definiti. In matematica, « non ci sono obiezioni, e non ci sono risposte alle obiezioni », sosteneva Mill. Già nella sua forma dialogica, nella successione di obiezioni e risposte in cui si articola, Dimostrazioni e Confutazioni di Lakatos è forse la critica migliore a tutt'oggi disponibile della concezione conservatrice e autoritaria delle matematiche che è sopravvissuta alle stesse formulazioni di Mill20 .
« Ma come! (ci si può chiedere), la mancanza di unanimità è una condizione indispensabile per il vero sapere? È necessario che una parte dell'umanità persista nell'errore perché qualcuno si possa render conto della verità? [....] l'intelligenza esiste solo finché non ha raggiunto il suo scopo? i frutti della vittoria si dileguano proprio perché completa? ». In primo luogo, ci guardiamo bene dal sostenere che a lungo andare il conflitto tra programmi non produca di fatto un vincitore: forze e non vortici, energia e non calorico, ossigeno e non flogisto, metodo ?-? e non infinitesimi. Ma - questo è il punto - il contenuto stesso del programma vincente risulta modellato precisamente dal conflitto con i rivali; di piú, esso sarà tanto piú ricco quanto piú a lungo dura il conflitto stesso. Il conflitto implica infatti una sfida permanente ai ricercatori a risolvere nuovi problemi, a estendere il campo delle « applicazioni riuscite » e, alla retroguardia, a replicare entro il proprio programma i successi di quelli rivali. Pluralità dei programmi non significa perciò convivenza pacifica, ma lotta per la sopraffazione. « Infine, o [uno di essi] ha il sopravvento e diventa l'opinione generale oppure il suo progresso s'arresta: mantiene il terreno che s'è conquistato, ma smette di espandersi. [ ... ] Le controversie si acquietano e gradualmente si spengono. [ ... ] [I suoi promotori], invece di essere come una volta costantemente all'erta per difendersi dal mondo, o per portarlo dalla propria parte, si sono quietati e ammansiti ». Questo modello che Mill applica allo sviluppo delle « dottrine morali e le religioni », ricostruzioni razionali come quelle di Kuhn21 hanno mostrato che si applica anche allo sviluppo delle teorie scientifiche. Contrariamente a quanto alcuni critici di Kuhn hanno sostenuto, il limite di tali ricostruzioni non è l'enfasi sulla « funzione del dogma » nella « ricerca normale », bensí la « tesi del monopolio », per dirla con Watkins22. Si tratta, come è noto, della tesi secondo cui l'efficacia della ricerca normale dipende dal dominio di un unico dogma, o anche di una pluralità di dogmi non in conflitto tra loro. La nostra ipotesi invece è che in queste circostanze il progresso ristagni. In ogni caso, questa è l'opinione di Mill. È però « fatale la tendenza degli uomini a smettere di pensare a una questione quando non è piú dubbia ». Essa « è la causa di metà dei loro errori. Un autore contemporaneo ha giustamente parlato del "profondo sonno dogmatico indotto da un'opinione definitiva” ». Bene. Ma allora « se vi sono persone che negano un'opinione generalmente accettata, o che lo farebbero se la legge o il pubblico glielo permettessero, ringraziamole ». « Questa disciplina è cosí essenziale a una reale comprensione delle questioni morali e umane [quelle scientifiche incluse] che se una verità fondamentale non trova oppositori, è indispensabile inventarli [corsivo nostro] e munirli dei piú validi argomenti che il piú astuto avvocato dei diavolo riesce ad inventare ». In tutti i campi in cui operi questa disciplina, nessuna vittoria può mai essere definitiva, nessun programma, per quanto duramente battuto, può essere relegato in polverosi scaffali. « II progresso è stato spesso conseguito attraverso "critiche attinte dal passato" [ ... ] . Dopo Aristotele e Tolomeo, l'idea che la terra si muova - quella strana, antica e "del tutto ridicola" opinione pitagorica - fu gettata nell'immondezzaio della storia, solo per essere richiamata in vita da Copernico, che ne fece un'arma per la sconfitta di coloro che l'avevano temporaneamente sconfitta 23.» Invece di contemplare - tra passività e impotenza - « i resti o residui della traduzione »25 , di piangere sul destino dei vinti, si tratta invece dí sviluppare creativamente - usando argomenti - qualunque « resto o residuo » promettente del programma sconfitto. Dopo tutto, « un gruppo di ricercatori (appoggiato da una ricca società che finanzi pochi esperimenti ben pianificati) può con successo mandare avanti qualsiasi programma fantastico o, se lo desidera, rovesciare invece qualsiasi pilastro di "conoscenza affermata”, ad arbitrio scelto » . Qui sta il nucleo di una « teoria dei resti o residui della traduzione ».
La linea principale dell'argomento di Mill nel II cap. di On Liberty consiste dunque essenzialmente nel mostrare la connessione tra « libertà di opinione e libertà di espressione », che costituiscono evidentemente le condizioni di possibilità del dissenso, e crescita della conoscenza. Tuttavia, « se il valore della libertà è strumentale, semplicemente perché di fatto la libera ricerca è il modo per massimizzare le nostre possibilità di scoprire nuove verità, allora la verità può avere soltanto un valore provvisorio26 » . L'obiezione di Ryan è chiara: dovremmo forse rinunciare a queste libertà se risultasse che - di fatto - il tasso di crescita della conoscenza è maggiore in un diverso ambiente intellettuale? Questa è però una eventualità estremamente improbabile, se gli argomenti di Mill, e i loro raffinamenti successivi, sono validi. Né costituiscono controesempi casi isolati di società totalitarie caratterizzate da un forte tasso di crescita della conoscenza. Ma quale conoscenza, e per che periodi di tempo? È certo compatibile con tali argomenti che questo riguardi la conoscenza scientifica in senso stretto per periodi relativamente brevi di tempo. Lo stesso Mill nota che « vi sono stati, e vi potranno ancora essere grandi pensatori isolati in una atmosfera generale di servitú mentale ». Ma a lungo andare, « il genio può respirare liberamente soltanto in una atmosfera di libertà ». Non è questo tuttavia il punto principale. Per scoprirlo, dobbiamo estendere la prospettiva dall'ambito stretto dell'impresa scientifica a quello delle istituzioni di base della società in generale.
È a questo livello che il principio secondo cui:
(i) ciascun individuo deve avere un uguale diritto al sistema totale massimo di uguali libertà fondamentali compatibile con un simile sistema di libertà per tutti;
(ii) la libertà può essere ristretta solo a vantaggio della libertà stessa27 ,
svolge il suo ruolo fondamentale. Sappiamo già qual è secondo Mill l'argomento principale a suo favore: istituzioni che lo soddisfino sono quelle che meglio consentono lo sviluppo di « una larga varietà di caratteri » e l'espansione della « natura umana [ ... ] in direzioni innumerevoli e contrastanti », che meglio consentono cioè la realizzazione del principio di von Humboldt, per lo meno dal « momento in cui gli uomini sono diventati capaci di migliorare attraverso la discussione libera e tra eguali ». « La natura umana non è una macchina da costruire secondo un modello e da regolare perché compia esattamente il lavoro assegnato, ma un albero, che ha bisogno di crescere e di svilupparsi in ogni direzione, secondo le tendenze delle forze interiori che lo rendono una persona vivente » . Perciò, « è utile che [ ... ] vi siano differenti esperimenti di vita [ ... ] e che la validità di modi di vivere diversi sia verificata nella pratica quando lo si voglia », « che vi sia la piú ampia libertà di svolgere ogni attività inconsueta affinché col tempo emergano chiaramente quelle che meritano di diventare consuetudini ». « Proprio perché la tirannia dell'opinione è tale da rendere riprovevole l'eccentricità, per infrangere l'oppressione è auspicabile che gli uomini siano eccentrici ». « L'Europa deve a questa pluralità di percorsi tutto il suo sviluppo progressivo e multiforme » [c.vo nostro]. Perciò, « la libertà è l'unico fattore infallibile e permanente di progresso, poiché fa si che i potenziali centri indipendenti di irradiamento del progresso siano tanti quanti gli individui ».
Molti hanno criticato Mill di aver ritagliato questo modello sulla propria esperienza privilegiata di intellettuale o, ancora peggio, sulle proprie vicende private. Si tratterebbe, ancora una volta, del borghese che difende i propri privilegi, tra cui quello all'eccentricità. Può darsi. Ma è irrilevante agli effetti della valutazione del modello. Il problema è un altro. Che l'intellettuale svolga il suo ruolo - e questo è il suo ruolo: implacabile nella critica e eccentrico negli esperimenti di vita. Ma che le istituzioni di base - e in primo luogo quelle educative - siano disegnate in modo da consentire a tutti le stesse opportunità. Questo implica un delicato equilibrio tra intervento statale e iniziativa privata in campo educativo. « Tutto ciò che si è affermato sull'importanza dell'individualità del carattere e della diversità di opinioni e comportamenti implica, con la stessa incommensurabile importanza, la diversità di educazione. Una educazione di Stato generalizzata non è altro che un sistema per modellare gli uomini tutti uguali; e poiché il modello è quello gradito al potere dominante - sia esso il monarca, il clero, l'aristocrazia, la maggioranza dei contemporanei - quanto piú è efficace ed ha successo, tanto maggiore è il dispotismo che instaura sulla mente. [ ... ] Un'educazione istituita e fondata dallo Stato dovrebbe essere tutt'al piú un esperimento in competizione con molti altri, condotto come esempio e stimolo che contribuisca a mantenere un certo livello qualitativo generale ». Tuttavia, le disuguaglianze economiche possono distorcere l'uguale possibilità di accesso all'educazione. Il ruolo dell'intervento statale non è però quello di assumersi la gestione dell'educazione, ma di correggere queste distorsioni in modo da consentire uguali opportunità di accesso all'« esperimento educativo » preferito.
Questo è solo un caso particolare. La scelta collettiva - in questa prospettiva - dovrebbe essere il risultato di una molteplicità di scelte di individui ciascuno libero « di perseguire il proprio bene a suo modo ». « Ciascuno è l'unico autentico guardiano della propria salute sia fisica sia mentale e spirituale ». « Questo è naturalmente solo il ben noto principio della sovranità del consumatore, spesso discusso nella letteratura dell'economia del benessere: gli interessi di ciascun individuo devono essere definiti fondamentalmente nei termini delle sue proprie preferenze personali e non nei termini di ciò che qualcun altro pensa sia "bene per lui"28 » .
L'enfasi sui produttori nell'ambito della sinistra - ereditata da una concezione « centrata » del sistema sociale29 - è perciò quanto meno fuorviante, poiché implica l'imposizione all'intera società delle « preferenze » di una sua parte sempre meno significativa, almeno nella misura in cui la nozione di « lavoro produttivo » venga interpretata in termini marxiani stretti. Essa implica in ogni caso una divisione arbitraria tra « produttori » e altri sempre piú importanti strati sociali fuori dal « processo produttivo », come donne, giovani, anziani, intellettuali, e altri ancora.
La « rivoluzione copernicana » per la sinistra consiste allora precisamente nel superamento del « dogma dei sistemi centrati » e nel riconoscimento del sistema sociale come un sistema di interazioni tra gruppi (o individui) con « funzioni di utilità30 » diverse (e usualmente in conflitto), tra cui nessuna rappresenta gli interessi universali dell'intera umanità. Problema della sinistra in quanto forza di governo diventa allora quella di « incollare » tali funzioni di utilità individuali (o di gruppo) in una funzione di scelta sociale che massimizzi l'utilità media, soggetta al solo vincolo di compatibilità con il principio di von Humboldt. Problema della sinistra in quanto forza di opposizione diventa invece quello di rappresentare politicamente un'opportuna media delle funzioni di utilità di una parte sociale: quella dei piú svantaggiati.
Tutto questo esclude ogni concentrazione del potere « per organizzare la vita sociale secondo un piano unitario31 » . « I mali cominciano quando il governo, invece di far appello ai poteri dei singoli e delle associazioni, si sostituisce ad essi; quando invece di informare, consigliare, e talvolta denunciare, impone dei vincoli, ordina loro di tenersi in disparte e agisce in loro vece ». « Uno Stato che rimpicciolisce i suoi uomini perché possano essere strumenti più docili nelle sue mani, anche se a fini benefici, scoprirà che con dei piccoli uomini non si possono compiere cose veramente grandi; e che la perfezione meccanica cui ha tutto sacrificato alla fine non gli servirà a nulla, perché mancherà la forza vitale che, per fare funzionare meglio la macchina, ha preferito bandire ».
Giulio Giorello e Marco Mondadori
Milano, dicembre 1980
Note
1 F.A. Hayek, J. S. Mill and H. Taylor. Their friendship and subsequent marriage. Routledge and Kegan Paul, London, 1951, pp. 222-3. Purtroppo, non vi saranno altri riferimenti storici in questa prefazione: niente benthamiti, niente Westminster Review, niente Reform Bill del 1832, niente storia d’amore di Mill con Harriet Taylor. Può ben darsi che tutte queste circostanze, ed altre ancora più banali, abbiano «influenzato» l’opinione esposta in On liberty. «Mediante quale processo di pensiero egli sia giunto a questa opinione, benchè sia come tale una questione interessante e importante, è logicamente irrilevante rispetto alla questione se l’opinione stessa sia corretta, [ ... ] In breve, la verità e la falsità filosofica, piuttosto che i fatti storici, sono al centro della nostra attenzione in questo saggio.» (B. Russell, A critical exposition of the philosophy of Leibniz, Allen and Unnwin, London, 1964, p. XII.)
2 J.S. Mill, Autobiografia, a cura di F. Restaino, Laterza, Bari, 1976, p. 197, c.vo nostro.
3 Una parte importante del saggio di Mill è volta precisamente a dare una formulazione di questo principio in grado di sfuggire alle obiezioni piú ovvie basate sulla impossibilità di distinguere tra azioni che riguardano solo chi le compie e azioni che riguardano anche gli altri - le prime totalmente libere, le seconde soggette a controllo sociale. Evitiamo di discutere questo problema perché ci sembra che la proposta di Mill (si veda in particolare il cap. zv, pp. 106 sgg.) sia soddisfacente. E' chiaro che essa non dà alcun criterio meccanico di distinzione tra i due tipi di azione, e quindi di applicazione del principio. Ma questo significa semplicemente che ogni particolare applicazione del principio sarà solo congetturale, e quindi aperta alla critica. Proprio come dovremmo aspettarci. Su questo punto si veda in ogni caso, C.L. Ten, Mill on liberty, Oxford University Press, Oxford, 1981.
4 B. Russell, Portraits from memory, Allen and Unwin, London, 1951. Ora in J.B. Schneewind, a cura di, Mill, A collection of critical essays, MacMillan, London, 1969, p. 11.
5 Difficilmente compatibile con l'analisi che sviluppiamo piú oltre - seguendo Mill - ci sembra in particolare il passo seguente di C.B. Macpherson, La vita e i tempi della democrazia liberale, a cura di E.A. Albertoni, Il Saggiatore, Milano, 1980, p. 117: « Rimane una domanda: può questo modello di democrazia partecipativa [modello 4b, di cui alle pp. 115.7] essere chiamato modello di democrazia liberale? Io credo di sì. [...]. La sua garanzia non sta nell'esistenza di partiti alternativi, poiché è concepibile che dopo qualche decade essi possano scomparire in condizioni di maggiore ricchezza e di diffuse opportunità di partecipazione da parte dei cittadini, diverse che i partiti politici » [c.vo nostro]. O Macpherson interpreta la nozione di partito in un senso particolarmente stretto - e in tal caso la proposta di Macpherson è poco interessante - o, in caso contrario, il suo modello 4b - e a fortiori il 4a - sono incompatibili con qualunque nozione ragionevole di democrazia, e in particolare con le conseguenze del principio di von Humboldt, per cui si veda piú oltre.
6 « Una concezione [...] estremamente lineare, rifuggente dal giuoco di equilibrio; una politica precisa, tagliente, senza equivoci, a cui corrispondono il periodare stesso dello scrittore [...] contrassegnato dal procedere a mezzo di alternative, per nette contrapposizioni di frasi, [...] seccamente differenziate dalla disgiuntiva "o" [...], e la struttura generale dei discorso, [...] basato [...] sul netto rilievo di ciascuno dei periodi. » Cosi F. Chabod su Machiavelli (Scritti su Machiavelli, Einaudi, Torino, 1964, p. 201). Questo invece il periodare e la struttura generale del discorso di P. Ingrao:
(i) « La direzione socialista del nuovo Stato proletario può realizzarsi anche attraverso una pluralità di forze politiche ». (Masse e potere, Editori Riuniti, Roma, 1977, p. 182-3.)
(ii) « [...] possono esserci piú partiti che traggono origine dalla classe operaia e la costruzione di una volontà politica unitaria può scaturire anche da una dialettica fra di essi ». (Ibid., p. 183.)
(iii) « La nostra risposta affermativa circa il metodo della maggioranza e della minoranza comporta a mio parere anche un'altra risposta: e cioè che noi prospettiamo l'organizzazione di un potere socialista e di uno Stato proletario in cui determinati diritti politici siano riconosciuti a tutti, anche a uomini e gruppi che non sono di orientamento socialista ». (Ibid., p. 184.)
(iv) « Noi manteniamo tutta intera la nostra posizione classista e la critica marxista e leninista ai vecchi ordinamenti, nell'atto stesso in cui prospettiamo una gestione del potere in cui determinati diritti di libertà siano riconosciuti anche a forze non socialiste». (Ibid., p. 185.)
I corsivi sono naturalmente nostri.
7 Questo termine di Macpherson (cfr. op. cit., pp. 46 sgg.) è a nostro parere fuorviante. « Il piú alto e il piú armonioso sviluppo delle sue [dell'uomo] facoltà » (Cfr. Macpherson, op. cit., p. 49, che cita una frase di von Humboldt citata da J.S. Mill, Saggio sulla libertà, p. 86) è una conseguenza della possibilità di conflitto tra opinioni, esperimenti di vita, tradizioni diverse. Il termine più appropriato per descrivere il modello di Mill ci sembra perciò « democrazia di conflitto ».
8 Cfr. J.S. Mill, Sulla «Democrazia in America» di Tocqueville, a cura di D. Cofrancesco, Guida editore, Napoli, 1971, pp. 111-3.
9 Si veda ad es. la seguente formulazione di von Humboldt nello spirito della nostra argomentazione: «Il piú alto ideale di coesistenza umana sarebbe secondo me quello in cui ognuno si sviluppasse esclusivamente da se stesso e per se stesso. La natura fisica e morale avvicinerebbe allora gli uomini reciprocamente gli uni e gli altri, e come i combattimenti in guerra sono piú onorevoli di quelli dell'arena, e le lotte di cittadini esacerbati piú gloriose di quelle di mercenari che obbediscono all'altrui comando, cosí il conflitto delle forze di questi uomini costituirebbe nel contempo e una prova e una produzione della piú alta energia ». (Stato, società e storia, a cura di N. Merker, Editori Riuniti, Roma, 1974, p. 76.)
10 Cfr. J.S. Mill, Sulla «Democrazia in America» di Tocqueville, cit., p. 109.
11 Ibid., p. 123.
12 Ibid., p. 127.
12 Cfr. J. Bentham, citato e discusso in E. Halévy, The Growth of philosophical radicalism, Faber and Faber, London, 1972, p. 83.
14 Cfr. J.S. Mill, Sulla «Democrazia in America » di Tocqueville, cit., p. 128-9.
15 Cfr. G. Colli, a cura di, La sapienza greca, vol. III, Eraclito, Adelphi, Milano, 1980, p. 59 (14A48 = 22B7 Diels-Kranz).
16 Cfr. J.S. Mill, Sulla «Democrazia in America» di Tocqueville, cit., p. 166.
17 Ovviamente, essi non costituiscono affatto una garanzia della sua stabilità. È solo nella soluzione del problema della stabilità che gioca un ruolo fondamentale la nozione di consenso. Il consenso riguarda le istituzioni di base della società ed è plausibile assumere che consenso vi sarebbe - e quindi stabilità - nel caso in cui queste ultime fossero giuste. Una ipotesi interessante circa la giustizia delle istituzioni di base è quella avanzata da J. Harsanyi (per cui si veda Rational behavior and bargaining equilibrium in games and social situations, Cambridge University Press, Cambridge, 1977; Essays on ethics, social behavior and scientific explanation, Reidel, Dordrecht, 1976, in particolare il saggio « Can the maximin principle serve as a basis for morality. A critique of J. Rawls's theory », pp. 37-63) nella stessa tradizione intellettuale di J.S. Mill, quella utilitaristica. Essa è basata sul principio di massimizzazione dell'utilità media, per cui si veda la nota 30. In questo contesto, la conseguenza piú significativa di questo principio - date alcune assunzioni empiriche circa le condizioni al contorno assai poco problematiche - è che istituzioni di base giuste soddisfano il principio già citato a p. 8, il principio cioè che costituisce la condizione stessa di possi¬bilità del conflitto, del dissenso intellettuale. Consenso e dissenso si sostengono perciò reciprocamente in una sorta di circolo virtuoso per lo meno in una società le cui istituzioni di base siano giuste.
18 Per quanto riguarda I. Lakatos, si veda l'ormai classico, « La falsificazione e la metodologia dei programmi di ricerca scientifici », in Critica e crescita della conoscenza, a cura di I. Lakatos e A. Musgrave, Feltrinelli, Milano, 1976, in particolare le pp. 197 sgg.; « Newton's effect on scientific standards », in The methodology of scientific research programmes, a cura di J. Worrall e G. Curry, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge, 1978; e per quanto riguarda P.K. Feyerabend, si veda « How to be a good empiricist », Philosophy of science, The Delaware Seminar, vol. 2, a cura di B. Baumrin, Interscience Publishers, 1963, pp. 3-39; « Consolazioni per lo specialista », in Critica e crescita della conoscenza, cit.; Contro il metodo, Lampugnani Nigri Editore, Milano, 1973. C'è tuttavia chi non se ne è ancora accorto e insiste, come E. Bellone, nel dissociare crescita della conoscenza e critica, relegando quest'ultima - come una mala erba - « nei giardini degli umanisti » (« L'Unità », 5 luglio 1977, p. 3). L'esito è ovviamente « la costruzione di una società socialista nel consenso » (« L'Unità », 29 agosto 1980, p. 3, c.vo nostro). Il consenso è solo una traduzione stile 1984 della dittatura del proletariato. O il socialismo si costruisce nel dissenso o non si costruisce affatto.
19 Per la congettura di Eulero, si veda il cap. i di I. Lakatos, Dimostrazioni e confutazioni. La logica della scoperta matematica, Feltrinelli, Milano, 1979; per il principio di continuità di Cauchy, si veda I. Lakatos, ibid., Appendice I e Mathematics, science and epistemology, a cura di J. Worral e G. Curry, vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 1978, pp. 43-60 (« Cauchy and the continuum: the significance of non-standard analysis for the history and philosophy of mathematics »); per il principio di Dirichlet si veda G. Giorello, « Mathematische Abstraktion, Dialektik der wissenschaftlichen Forschungsprogramme and Naturerkenntnis », in P. Plath e H.J. Sandkiiler, a cura di, Theorie and Labor. Dialektik als Programm der Naturwissenschaft, Pahl-Rugenstein, Kdln, 1978, pp. 270-297; per le funzioni generalizzate di Dirac, si veda L. Schwartz, « La function 6 et les noyaux », in A. Salam e E.P. Wigner, a cura di, Aspects of quantum mechanics, Cambridge University Press, New York, 1972, pp. 179-182; per il labirinto degli infinitesimi, si veda A. Robinson, Non-standard analysis, North Holland, Amsterdam, 1966, in particolare cap. x, e « The metaphysics of the calculus », in I. Lakatos, a cura di, Problems in the philosophy of ma¬thematics, North Holland, Amsterdam, 1967, pp. 28-46; per «l'immenso oceano » degli indivisibili, si veda E. Giusti, Bonaventura Cavalieri and the theory of indivisibles, di prossima pubblicazione.
20 Cfr. in particolare p. 43 di I. Lakatos, Dimostrazioni e confutazioni, cit.: « La forma dialogica riflette la dialettica della storia ».
21 Si veda in particolare T.S. Kuhn, « The function of dogma in scientific research », in A. Crombie, a cura di, Scientific change, Heinemann, London, 1963, pp. 347-395; La struttura delle rivoluzioni scientifiche, trad. it. di A. Carugo, Einaudi, Torino, 19782; e The essential tension, University of Chicago Press, Chicago, 1977, in particolare alle pp. 225-239.
22 Cfr. J.W.N. Watkins, « Contro la scienza normale », in Critica e crescita della conoscenza, cit., p. 104.
23 Cfr. P.K. Feyerabend, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anar¬chica della conoscenza, trad. it. di L. Sosio, Feltrinelli, Milano, 1979, p. 41.
b Cfr. S. Tagliagambe, « Scene da un matrimonio: la difficile convivenza di epistemologia e storia della scienza », in AA.VV., Scienza e storia. Analisi critica e problemi attuali, « Critica Marxista » - Editori Riuniti, 1980, p. 41, che discute M. Vegetti, « Ragione scientifica e ragioni dell'ideologia: un intervento», in « Quaderni della Fondazione Feltrinelli », 4/5, 1979, p. 142.
25 Cfr. I. Lakatos, « La falsificazione e la metodologia dei programmi di ricerca scientifici », cit., p. 266. Per il solito Bellone, già citato alla nota 18, si tratta qui di « fantasmi filosofici ». (Cfr. Il mondo di carta, Mondadori, Milano, 1976, p. 27.) L'incubo delle « scuole filosofiche » gioca davvero dei pessimi scherzi.
26 Cfr. A. Ryan, J.S. Mill, Routledge and Kegan, London, 1974, p. 129.
27 È questa la riformulazione che J. Rawls dà in A theory of justice, Oxford University Press, Oxford, 1973, p. 250, del principio di libertà di Mill. L'interessante difesa che Rawls fa di questo principio è tuttavia basata su una linea d'argomentazione del tutto diversa da quella di Mill.
28 Cfr. J. Harsanyi, Rational behavior and bargaining equilibrium in games and social situations, Cambridge University Press, Cambridge, 1977, p. 52.
29 Cfr. G. Giorello e M. Mondadori, L'eclisse dei sistemi, « Rinascita », 1979, n. 23, pp. 41-2.
30 Per questa nozione si veda in particolare J. Harsanyi, Rational behavior and bargaining equilibrium in games and social situations, cit., pp. 16-47, oppure Luce and Raiffa, Games and decisions, Wiley, New York, 1957, pp. 12-38.
31 Cfr. FA. Hayek, The road to serfdom, Routledge and Kegan, London, 1944, p. 107.
Flaubert, Dizionario dei luoghi comuni.
«Napoli, 17 febbraio 1855
[ ... ] Piú penso al progetto di un volume sulla Libertà, piú mi convinco che sarà letto e farà sensazione1. »
Cosí Mill a Harriet Taylor in una lettera spedita nel corso del suo viaggio in Italia. Il saggio veniva pubblicato tre anni dopo, nel 1858, poco dopo la morte di Harriet, cui è dedicato. Tra il 1861 e il 1870, curando la revisione finale della propria Autobiografia, Mill precisava:
« La Libertà probabilmente sopravviverà piú a lungo di qualsiasi altro mio scritto. [ ... ] Ciò perché l'unione della sua [di Harriet Taylor] mente con la mia ha fatto di quel saggio una specie di manuale filosofico su una singola verità cui i cambiamenti verificantesi progressivamente nella società moderna tendono a dare un rilievo sempre piú forte: vale a dire l'importanza per l'uomo e la società di una larga varietà di caratteri e di una completa libertà della natura umana di espandersi in direzioni innumerevoli e contrastanti2.»
Tale esito - questa è l'argomentazione dominante in On Liberty - è determinato da istituzioni disegnate in armonia con il principio secondo cui « l'umanità è giustificata, individualmente o collettivamente, a interferire sulla libertà di azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi: il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di una comunità civilizzata contro la sua volontà è per evitare danno agli altri3»
Si tratta evidentemente di un principio forte di limitazione dell'intervento statale in tutte le sfere della società civile, e piú specificamente di limitazione del raggio d'azione della cosí detta « majority tale » alle pratiche sociali che danneggino positivamente gli interessi di gruppi di persone non coinvolte volontariamente nelle stesse. Proprio per questo, « On Liberty è píú importante per noi oggi del suo libro sulla Subjection of Women. È piú importante perché la causa che sostiene ha avuto meno successo. C'è, nel complesso, molto meno libertà oggi di quanta ce ne fosse cento anni fa; e non c'è ragione di supporre che le restrizioni sulla libertà siano destinate a diminuire in un futuro prevedibile »4. Così B. Russell nel 1951. Questa tendenza persiste - e non è certo estranea a proposte di democrazia « avanzata », come ad es. i due modelli di « democrazia partecipativa »5 di Macpherson, o al modello di « democrazia di massa »6 di Ingrao. I contorni di questi modelli non sono affatto chiari. Tuttavia, questa tendenza è implicita in tutte le forme di « partecipazione » che vadano oltre quelle costitutive della « democrazia di sviluppo »7, già caratterizzate in forma paradigmatica, sulla base di un caso storico, da A. de Tocqueville in La Democrazia in America. La miglior ridescrízione è quella dello stesso Mill: « Tocqueville vede la causa prima della libertà americana e la sua sicurezza non tanto nell'elezione del Presidente e del Congresso tramite suffragio popolare, quanto nell'amministrazione di quasi tutti gli affari della società da parte del popolo stesso. [ ... ].La distribuzione di cariche amministrative il piú estensivamente possibile nella massa popolare costituisce, per il nostro autore, il solo mezzo per renderla atta a un'efficiente partecipazione alla direzione della cosa pubblica. [ ... ] Comunque possano essere strutturate altre costituzioni, il carattere di un popolo sarà, ne siamo persuasi, essenzialmente volgare e servile, ove lo spirito pubblico non venga coltivato grazie a una partecipazione estensiva dei piú agli affari del governo [ ... ] »8.
Non basta. Lo stesso Mill che - riprendendo Tocqueville - individua nella partecipazione uno degli strumenti piú efficaci per l'educazione di larghe masse alla gestione della cosa pubblica e all'esercizio delle libertà, vede proprio in essa una possibile minaccia alla realizzazione del « principio di von Humboldt »: l'assoluta ed essenziale importanza dello sviluppo umano nella sua piú ricca diversità, che costituisce il « motto » di On Liberty9 . In circostanze ben specificate, in circostanze in cui cioè « il livellamento delle condizioni di vita ha compiuto maggiori progressi dello spirito di libertà »10, questo stesso meccanismo di partecipazione tenderà a produrre « quello che il Nostro [Tocqueville] definisce "il dispotismo della maggioranza" »11 . « La tirannia che ci fa paura, ed è sommamente temuta dal Tocqueville, è di un altro genere - e non opera sul corpo, bensí sullo spirito »12. « Quindi, la protezione dalla tirannide del magistrato non è sufficiente: è necessario anche proteggersi dalla tirannia dell'opinione e del sentimento predominanti, dalla tendenza della società a imporre come norme di condotta, con mezzi diversi dalle pene legali, le proprie idee e usanze a chi dissente, a ostacolare lo sviluppo - e a prevenire, se possibile, la formazione di qualsiasi individualità discordante, e a costringere tutti i caratteri a conformarsi al suo modello »
Il limite cui tende questo processo era stato anticipato da Bentham nel suo Panopticon: il progetto di una prigione-modello, di una prigione in cui l'ispettore ha la facoltà di vedere a colpo d'occhio tutto quello che succede; una prigione circolare dove un ispettore è nella posizione di controllare tutte le celle disposte concentricamente intorno a una torre centrale: un sistema di schermi rende invisibile l’ispettore che vede tutto. «essere incessantemente sotto gli occhi dell’ispettore significa perdere di fatto la capacità di fare del male, se non addirittura il desiderio di farlo »13 . Sostituiamo all'ispettore di Bentham l'opinione pubblica di Tocqueville e di Mill e otteniamo quella degenerazione della democrazia di conflitto temuta da entrambi: « trovandosi tutti piú o meno sul medesimo piano per quanto riguarda le condizioni economiche, e similmente dal punto di vista dell'intelligenza e del sapere, l'unica autorità che ispira una involontaria deferenza è quella del numero. [ ... ] "La fede nell'opinione pubblica", dice Tocqueville, "diventa in quelle contrade una specie di religione, e la maggioranza è il suo profeta" »14
Ancora nella sua recensione a La Democrazia in America, Mill identificava chiaramente il disagio della democrazia di conflitto nella possibilità implicita nella « majority rule » di determinare una stagnazione intellettuale e morale. La Cina giocava il ruolo di contromodello. « Il moderno dominio della pubblica opínione è - in forma disorganizzata - ciò che il sistema educativo e politico cinese è in forma organizzata; e se l'individualità non riuscirà a farsi valere contro questo giogo, l'Europa, nonostante il suo nobile passato e il suo proclamato Cristianesimo, tenderà a diventare un'altra Cina ». Ma, « se tutte le cose che sono diventassero fumo, le narici le riconoscerebbero come distinte l'una dall'altra »15 . Fuor di metafora, l'uniformità di modi di vita, di opinioni, di interessi cui tende a degenerare una democrazia di conflitto, è contrastata da uno dei principi costitutivi di quest'ultima: il principio di von Humboldt. « Non è solo l'incontrollata ascesa del potere popolare a essere formidabile, ma quella di qualsiasi forza. Non esiste potere in seno alla società la cui influenza non diventi dannosa quand'esso regni incontrollato, non appena divenga esente da qualsiasi necessità di essere nel giusto, o allorché sia in grado di far prevalere la propria volontà senza previa lotta16»
Il conflitto, il dissenso tra diversi punti di vista, sono dunque garanzie di base di una società aperta17 . In questo, un grande modello è la dinamica della conoscenza scientifica. « In ogni campo in cui è possibile una differenza di opinioni, la verità dipende dall'individuazione dell'equilibrio tra due gruppi di ragioni contrastanti. Anche nella filosofia naturale, è sempre possibile fornire un'altra spiegazione degli stessi fatti; una teoria geocentrica invece di quella eliocentrica; il flogisto invece dell'ossigeno [ ... ] » . « Se si vietasse di dubitare della filosofia di Newton, gli uomini non potrebbero sentirsi cosí certi della sua verità come lo sono. Le nostre convinzioni piú giustificate non riposano su altra salvaguardia che un invito permanente a tutto il mondo a dimostrarle infondate ». Mill coglie qui l'intreccio tra crescita della conoscenza e critica: la proliferazione di teorie rivali come fattore di progresso scientifico. Cent'anni dopo riscopriranno questo punto di vista I. Lakatos e P. Feyerabend18; contro lo stesso Mill che aveva tentato di salvare « le verità matematiche » dalla precarietà di ogni ipotesi scientifica esposta al vaglio della critica. La congettura di Eulero, il principio di continuità di Cauchy o magari il principio di Dirichlet o ancora le funzioni generalizzate di Dirac, il labirinto degli infinitesimi, « l'immenso oceano » degli indivisibili19 : tutti casi in cui almeno una ricostruzione razionale ha scoperto il ruolo decisivo del conflitto intellettuale, della dialettica di obiezione e risposta, nella costruzione di soluzioni a problemi mal definiti. In matematica, « non ci sono obiezioni, e non ci sono risposte alle obiezioni », sosteneva Mill. Già nella sua forma dialogica, nella successione di obiezioni e risposte in cui si articola, Dimostrazioni e Confutazioni di Lakatos è forse la critica migliore a tutt'oggi disponibile della concezione conservatrice e autoritaria delle matematiche che è sopravvissuta alle stesse formulazioni di Mill20 .
« Ma come! (ci si può chiedere), la mancanza di unanimità è una condizione indispensabile per il vero sapere? È necessario che una parte dell'umanità persista nell'errore perché qualcuno si possa render conto della verità? [....] l'intelligenza esiste solo finché non ha raggiunto il suo scopo? i frutti della vittoria si dileguano proprio perché completa? ». In primo luogo, ci guardiamo bene dal sostenere che a lungo andare il conflitto tra programmi non produca di fatto un vincitore: forze e non vortici, energia e non calorico, ossigeno e non flogisto, metodo ?-? e non infinitesimi. Ma - questo è il punto - il contenuto stesso del programma vincente risulta modellato precisamente dal conflitto con i rivali; di piú, esso sarà tanto piú ricco quanto piú a lungo dura il conflitto stesso. Il conflitto implica infatti una sfida permanente ai ricercatori a risolvere nuovi problemi, a estendere il campo delle « applicazioni riuscite » e, alla retroguardia, a replicare entro il proprio programma i successi di quelli rivali. Pluralità dei programmi non significa perciò convivenza pacifica, ma lotta per la sopraffazione. « Infine, o [uno di essi] ha il sopravvento e diventa l'opinione generale oppure il suo progresso s'arresta: mantiene il terreno che s'è conquistato, ma smette di espandersi. [ ... ] Le controversie si acquietano e gradualmente si spengono. [ ... ] [I suoi promotori], invece di essere come una volta costantemente all'erta per difendersi dal mondo, o per portarlo dalla propria parte, si sono quietati e ammansiti ». Questo modello che Mill applica allo sviluppo delle « dottrine morali e le religioni », ricostruzioni razionali come quelle di Kuhn21 hanno mostrato che si applica anche allo sviluppo delle teorie scientifiche. Contrariamente a quanto alcuni critici di Kuhn hanno sostenuto, il limite di tali ricostruzioni non è l'enfasi sulla « funzione del dogma » nella « ricerca normale », bensí la « tesi del monopolio », per dirla con Watkins22. Si tratta, come è noto, della tesi secondo cui l'efficacia della ricerca normale dipende dal dominio di un unico dogma, o anche di una pluralità di dogmi non in conflitto tra loro. La nostra ipotesi invece è che in queste circostanze il progresso ristagni. In ogni caso, questa è l'opinione di Mill. È però « fatale la tendenza degli uomini a smettere di pensare a una questione quando non è piú dubbia ». Essa « è la causa di metà dei loro errori. Un autore contemporaneo ha giustamente parlato del "profondo sonno dogmatico indotto da un'opinione definitiva” ». Bene. Ma allora « se vi sono persone che negano un'opinione generalmente accettata, o che lo farebbero se la legge o il pubblico glielo permettessero, ringraziamole ». « Questa disciplina è cosí essenziale a una reale comprensione delle questioni morali e umane [quelle scientifiche incluse] che se una verità fondamentale non trova oppositori, è indispensabile inventarli [corsivo nostro] e munirli dei piú validi argomenti che il piú astuto avvocato dei diavolo riesce ad inventare ». In tutti i campi in cui operi questa disciplina, nessuna vittoria può mai essere definitiva, nessun programma, per quanto duramente battuto, può essere relegato in polverosi scaffali. « II progresso è stato spesso conseguito attraverso "critiche attinte dal passato" [ ... ] . Dopo Aristotele e Tolomeo, l'idea che la terra si muova - quella strana, antica e "del tutto ridicola" opinione pitagorica - fu gettata nell'immondezzaio della storia, solo per essere richiamata in vita da Copernico, che ne fece un'arma per la sconfitta di coloro che l'avevano temporaneamente sconfitta 23.» Invece di contemplare - tra passività e impotenza - « i resti o residui della traduzione »25 , di piangere sul destino dei vinti, si tratta invece dí sviluppare creativamente - usando argomenti - qualunque « resto o residuo » promettente del programma sconfitto. Dopo tutto, « un gruppo di ricercatori (appoggiato da una ricca società che finanzi pochi esperimenti ben pianificati) può con successo mandare avanti qualsiasi programma fantastico o, se lo desidera, rovesciare invece qualsiasi pilastro di "conoscenza affermata”, ad arbitrio scelto » . Qui sta il nucleo di una « teoria dei resti o residui della traduzione ».
La linea principale dell'argomento di Mill nel II cap. di On Liberty consiste dunque essenzialmente nel mostrare la connessione tra « libertà di opinione e libertà di espressione », che costituiscono evidentemente le condizioni di possibilità del dissenso, e crescita della conoscenza. Tuttavia, « se il valore della libertà è strumentale, semplicemente perché di fatto la libera ricerca è il modo per massimizzare le nostre possibilità di scoprire nuove verità, allora la verità può avere soltanto un valore provvisorio26 » . L'obiezione di Ryan è chiara: dovremmo forse rinunciare a queste libertà se risultasse che - di fatto - il tasso di crescita della conoscenza è maggiore in un diverso ambiente intellettuale? Questa è però una eventualità estremamente improbabile, se gli argomenti di Mill, e i loro raffinamenti successivi, sono validi. Né costituiscono controesempi casi isolati di società totalitarie caratterizzate da un forte tasso di crescita della conoscenza. Ma quale conoscenza, e per che periodi di tempo? È certo compatibile con tali argomenti che questo riguardi la conoscenza scientifica in senso stretto per periodi relativamente brevi di tempo. Lo stesso Mill nota che « vi sono stati, e vi potranno ancora essere grandi pensatori isolati in una atmosfera generale di servitú mentale ». Ma a lungo andare, « il genio può respirare liberamente soltanto in una atmosfera di libertà ». Non è questo tuttavia il punto principale. Per scoprirlo, dobbiamo estendere la prospettiva dall'ambito stretto dell'impresa scientifica a quello delle istituzioni di base della società in generale.
È a questo livello che il principio secondo cui:
(i) ciascun individuo deve avere un uguale diritto al sistema totale massimo di uguali libertà fondamentali compatibile con un simile sistema di libertà per tutti;
(ii) la libertà può essere ristretta solo a vantaggio della libertà stessa27 ,
svolge il suo ruolo fondamentale. Sappiamo già qual è secondo Mill l'argomento principale a suo favore: istituzioni che lo soddisfino sono quelle che meglio consentono lo sviluppo di « una larga varietà di caratteri » e l'espansione della « natura umana [ ... ] in direzioni innumerevoli e contrastanti », che meglio consentono cioè la realizzazione del principio di von Humboldt, per lo meno dal « momento in cui gli uomini sono diventati capaci di migliorare attraverso la discussione libera e tra eguali ». « La natura umana non è una macchina da costruire secondo un modello e da regolare perché compia esattamente il lavoro assegnato, ma un albero, che ha bisogno di crescere e di svilupparsi in ogni direzione, secondo le tendenze delle forze interiori che lo rendono una persona vivente » . Perciò, « è utile che [ ... ] vi siano differenti esperimenti di vita [ ... ] e che la validità di modi di vivere diversi sia verificata nella pratica quando lo si voglia », « che vi sia la piú ampia libertà di svolgere ogni attività inconsueta affinché col tempo emergano chiaramente quelle che meritano di diventare consuetudini ». « Proprio perché la tirannia dell'opinione è tale da rendere riprovevole l'eccentricità, per infrangere l'oppressione è auspicabile che gli uomini siano eccentrici ». « L'Europa deve a questa pluralità di percorsi tutto il suo sviluppo progressivo e multiforme » [c.vo nostro]. Perciò, « la libertà è l'unico fattore infallibile e permanente di progresso, poiché fa si che i potenziali centri indipendenti di irradiamento del progresso siano tanti quanti gli individui ».
Molti hanno criticato Mill di aver ritagliato questo modello sulla propria esperienza privilegiata di intellettuale o, ancora peggio, sulle proprie vicende private. Si tratterebbe, ancora una volta, del borghese che difende i propri privilegi, tra cui quello all'eccentricità. Può darsi. Ma è irrilevante agli effetti della valutazione del modello. Il problema è un altro. Che l'intellettuale svolga il suo ruolo - e questo è il suo ruolo: implacabile nella critica e eccentrico negli esperimenti di vita. Ma che le istituzioni di base - e in primo luogo quelle educative - siano disegnate in modo da consentire a tutti le stesse opportunità. Questo implica un delicato equilibrio tra intervento statale e iniziativa privata in campo educativo. « Tutto ciò che si è affermato sull'importanza dell'individualità del carattere e della diversità di opinioni e comportamenti implica, con la stessa incommensurabile importanza, la diversità di educazione. Una educazione di Stato generalizzata non è altro che un sistema per modellare gli uomini tutti uguali; e poiché il modello è quello gradito al potere dominante - sia esso il monarca, il clero, l'aristocrazia, la maggioranza dei contemporanei - quanto piú è efficace ed ha successo, tanto maggiore è il dispotismo che instaura sulla mente. [ ... ] Un'educazione istituita e fondata dallo Stato dovrebbe essere tutt'al piú un esperimento in competizione con molti altri, condotto come esempio e stimolo che contribuisca a mantenere un certo livello qualitativo generale ». Tuttavia, le disuguaglianze economiche possono distorcere l'uguale possibilità di accesso all'educazione. Il ruolo dell'intervento statale non è però quello di assumersi la gestione dell'educazione, ma di correggere queste distorsioni in modo da consentire uguali opportunità di accesso all'« esperimento educativo » preferito.
Questo è solo un caso particolare. La scelta collettiva - in questa prospettiva - dovrebbe essere il risultato di una molteplicità di scelte di individui ciascuno libero « di perseguire il proprio bene a suo modo ». « Ciascuno è l'unico autentico guardiano della propria salute sia fisica sia mentale e spirituale ». « Questo è naturalmente solo il ben noto principio della sovranità del consumatore, spesso discusso nella letteratura dell'economia del benessere: gli interessi di ciascun individuo devono essere definiti fondamentalmente nei termini delle sue proprie preferenze personali e non nei termini di ciò che qualcun altro pensa sia "bene per lui"28 » .
L'enfasi sui produttori nell'ambito della sinistra - ereditata da una concezione « centrata » del sistema sociale29 - è perciò quanto meno fuorviante, poiché implica l'imposizione all'intera società delle « preferenze » di una sua parte sempre meno significativa, almeno nella misura in cui la nozione di « lavoro produttivo » venga interpretata in termini marxiani stretti. Essa implica in ogni caso una divisione arbitraria tra « produttori » e altri sempre piú importanti strati sociali fuori dal « processo produttivo », come donne, giovani, anziani, intellettuali, e altri ancora.
La « rivoluzione copernicana » per la sinistra consiste allora precisamente nel superamento del « dogma dei sistemi centrati » e nel riconoscimento del sistema sociale come un sistema di interazioni tra gruppi (o individui) con « funzioni di utilità30 » diverse (e usualmente in conflitto), tra cui nessuna rappresenta gli interessi universali dell'intera umanità. Problema della sinistra in quanto forza di governo diventa allora quella di « incollare » tali funzioni di utilità individuali (o di gruppo) in una funzione di scelta sociale che massimizzi l'utilità media, soggetta al solo vincolo di compatibilità con il principio di von Humboldt. Problema della sinistra in quanto forza di opposizione diventa invece quello di rappresentare politicamente un'opportuna media delle funzioni di utilità di una parte sociale: quella dei piú svantaggiati.
Tutto questo esclude ogni concentrazione del potere « per organizzare la vita sociale secondo un piano unitario31 » . « I mali cominciano quando il governo, invece di far appello ai poteri dei singoli e delle associazioni, si sostituisce ad essi; quando invece di informare, consigliare, e talvolta denunciare, impone dei vincoli, ordina loro di tenersi in disparte e agisce in loro vece ». « Uno Stato che rimpicciolisce i suoi uomini perché possano essere strumenti più docili nelle sue mani, anche se a fini benefici, scoprirà che con dei piccoli uomini non si possono compiere cose veramente grandi; e che la perfezione meccanica cui ha tutto sacrificato alla fine non gli servirà a nulla, perché mancherà la forza vitale che, per fare funzionare meglio la macchina, ha preferito bandire ».
Giulio Giorello e Marco Mondadori
Milano, dicembre 1980
Note
1 F.A. Hayek, J. S. Mill and H. Taylor. Their friendship and subsequent marriage. Routledge and Kegan Paul, London, 1951, pp. 222-3. Purtroppo, non vi saranno altri riferimenti storici in questa prefazione: niente benthamiti, niente Westminster Review, niente Reform Bill del 1832, niente storia d’amore di Mill con Harriet Taylor. Può ben darsi che tutte queste circostanze, ed altre ancora più banali, abbiano «influenzato» l’opinione esposta in On liberty. «Mediante quale processo di pensiero egli sia giunto a questa opinione, benchè sia come tale una questione interessante e importante, è logicamente irrilevante rispetto alla questione se l’opinione stessa sia corretta, [ ... ] In breve, la verità e la falsità filosofica, piuttosto che i fatti storici, sono al centro della nostra attenzione in questo saggio.» (B. Russell, A critical exposition of the philosophy of Leibniz, Allen and Unnwin, London, 1964, p. XII.)
2 J.S. Mill, Autobiografia, a cura di F. Restaino, Laterza, Bari, 1976, p. 197, c.vo nostro.
3 Una parte importante del saggio di Mill è volta precisamente a dare una formulazione di questo principio in grado di sfuggire alle obiezioni piú ovvie basate sulla impossibilità di distinguere tra azioni che riguardano solo chi le compie e azioni che riguardano anche gli altri - le prime totalmente libere, le seconde soggette a controllo sociale. Evitiamo di discutere questo problema perché ci sembra che la proposta di Mill (si veda in particolare il cap. zv, pp. 106 sgg.) sia soddisfacente. E' chiaro che essa non dà alcun criterio meccanico di distinzione tra i due tipi di azione, e quindi di applicazione del principio. Ma questo significa semplicemente che ogni particolare applicazione del principio sarà solo congetturale, e quindi aperta alla critica. Proprio come dovremmo aspettarci. Su questo punto si veda in ogni caso, C.L. Ten, Mill on liberty, Oxford University Press, Oxford, 1981.
4 B. Russell, Portraits from memory, Allen and Unwin, London, 1951. Ora in J.B. Schneewind, a cura di, Mill, A collection of critical essays, MacMillan, London, 1969, p. 11.
5 Difficilmente compatibile con l'analisi che sviluppiamo piú oltre - seguendo Mill - ci sembra in particolare il passo seguente di C.B. Macpherson, La vita e i tempi della democrazia liberale, a cura di E.A. Albertoni, Il Saggiatore, Milano, 1980, p. 117: « Rimane una domanda: può questo modello di democrazia partecipativa [modello 4b, di cui alle pp. 115.7] essere chiamato modello di democrazia liberale? Io credo di sì. [...]. La sua garanzia non sta nell'esistenza di partiti alternativi, poiché è concepibile che dopo qualche decade essi possano scomparire in condizioni di maggiore ricchezza e di diffuse opportunità di partecipazione da parte dei cittadini, diverse che i partiti politici » [c.vo nostro]. O Macpherson interpreta la nozione di partito in un senso particolarmente stretto - e in tal caso la proposta di Macpherson è poco interessante - o, in caso contrario, il suo modello 4b - e a fortiori il 4a - sono incompatibili con qualunque nozione ragionevole di democrazia, e in particolare con le conseguenze del principio di von Humboldt, per cui si veda piú oltre.
6 « Una concezione [...] estremamente lineare, rifuggente dal giuoco di equilibrio; una politica precisa, tagliente, senza equivoci, a cui corrispondono il periodare stesso dello scrittore [...] contrassegnato dal procedere a mezzo di alternative, per nette contrapposizioni di frasi, [...] seccamente differenziate dalla disgiuntiva "o" [...], e la struttura generale dei discorso, [...] basato [...] sul netto rilievo di ciascuno dei periodi. » Cosi F. Chabod su Machiavelli (Scritti su Machiavelli, Einaudi, Torino, 1964, p. 201). Questo invece il periodare e la struttura generale del discorso di P. Ingrao:
(i) « La direzione socialista del nuovo Stato proletario può realizzarsi anche attraverso una pluralità di forze politiche ». (Masse e potere, Editori Riuniti, Roma, 1977, p. 182-3.)
(ii) « [...] possono esserci piú partiti che traggono origine dalla classe operaia e la costruzione di una volontà politica unitaria può scaturire anche da una dialettica fra di essi ». (Ibid., p. 183.)
(iii) « La nostra risposta affermativa circa il metodo della maggioranza e della minoranza comporta a mio parere anche un'altra risposta: e cioè che noi prospettiamo l'organizzazione di un potere socialista e di uno Stato proletario in cui determinati diritti politici siano riconosciuti a tutti, anche a uomini e gruppi che non sono di orientamento socialista ». (Ibid., p. 184.)
(iv) « Noi manteniamo tutta intera la nostra posizione classista e la critica marxista e leninista ai vecchi ordinamenti, nell'atto stesso in cui prospettiamo una gestione del potere in cui determinati diritti di libertà siano riconosciuti anche a forze non socialiste». (Ibid., p. 185.)
I corsivi sono naturalmente nostri.
7 Questo termine di Macpherson (cfr. op. cit., pp. 46 sgg.) è a nostro parere fuorviante. « Il piú alto e il piú armonioso sviluppo delle sue [dell'uomo] facoltà » (Cfr. Macpherson, op. cit., p. 49, che cita una frase di von Humboldt citata da J.S. Mill, Saggio sulla libertà, p. 86) è una conseguenza della possibilità di conflitto tra opinioni, esperimenti di vita, tradizioni diverse. Il termine più appropriato per descrivere il modello di Mill ci sembra perciò « democrazia di conflitto ».
8 Cfr. J.S. Mill, Sulla «Democrazia in America» di Tocqueville, a cura di D. Cofrancesco, Guida editore, Napoli, 1971, pp. 111-3.
9 Si veda ad es. la seguente formulazione di von Humboldt nello spirito della nostra argomentazione: «Il piú alto ideale di coesistenza umana sarebbe secondo me quello in cui ognuno si sviluppasse esclusivamente da se stesso e per se stesso. La natura fisica e morale avvicinerebbe allora gli uomini reciprocamente gli uni e gli altri, e come i combattimenti in guerra sono piú onorevoli di quelli dell'arena, e le lotte di cittadini esacerbati piú gloriose di quelle di mercenari che obbediscono all'altrui comando, cosí il conflitto delle forze di questi uomini costituirebbe nel contempo e una prova e una produzione della piú alta energia ». (Stato, società e storia, a cura di N. Merker, Editori Riuniti, Roma, 1974, p. 76.)
10 Cfr. J.S. Mill, Sulla «Democrazia in America» di Tocqueville, cit., p. 109.
11 Ibid., p. 123.
12 Ibid., p. 127.
12 Cfr. J. Bentham, citato e discusso in E. Halévy, The Growth of philosophical radicalism, Faber and Faber, London, 1972, p. 83.
14 Cfr. J.S. Mill, Sulla «Democrazia in America » di Tocqueville, cit., p. 128-9.
15 Cfr. G. Colli, a cura di, La sapienza greca, vol. III, Eraclito, Adelphi, Milano, 1980, p. 59 (14A48 = 22B7 Diels-Kranz).
16 Cfr. J.S. Mill, Sulla «Democrazia in America» di Tocqueville, cit., p. 166.
17 Ovviamente, essi non costituiscono affatto una garanzia della sua stabilità. È solo nella soluzione del problema della stabilità che gioca un ruolo fondamentale la nozione di consenso. Il consenso riguarda le istituzioni di base della società ed è plausibile assumere che consenso vi sarebbe - e quindi stabilità - nel caso in cui queste ultime fossero giuste. Una ipotesi interessante circa la giustizia delle istituzioni di base è quella avanzata da J. Harsanyi (per cui si veda Rational behavior and bargaining equilibrium in games and social situations, Cambridge University Press, Cambridge, 1977; Essays on ethics, social behavior and scientific explanation, Reidel, Dordrecht, 1976, in particolare il saggio « Can the maximin principle serve as a basis for morality. A critique of J. Rawls's theory », pp. 37-63) nella stessa tradizione intellettuale di J.S. Mill, quella utilitaristica. Essa è basata sul principio di massimizzazione dell'utilità media, per cui si veda la nota 30. In questo contesto, la conseguenza piú significativa di questo principio - date alcune assunzioni empiriche circa le condizioni al contorno assai poco problematiche - è che istituzioni di base giuste soddisfano il principio già citato a p. 8, il principio cioè che costituisce la condizione stessa di possi¬bilità del conflitto, del dissenso intellettuale. Consenso e dissenso si sostengono perciò reciprocamente in una sorta di circolo virtuoso per lo meno in una società le cui istituzioni di base siano giuste.
18 Per quanto riguarda I. Lakatos, si veda l'ormai classico, « La falsificazione e la metodologia dei programmi di ricerca scientifici », in Critica e crescita della conoscenza, a cura di I. Lakatos e A. Musgrave, Feltrinelli, Milano, 1976, in particolare le pp. 197 sgg.; « Newton's effect on scientific standards », in The methodology of scientific research programmes, a cura di J. Worrall e G. Curry, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge, 1978; e per quanto riguarda P.K. Feyerabend, si veda « How to be a good empiricist », Philosophy of science, The Delaware Seminar, vol. 2, a cura di B. Baumrin, Interscience Publishers, 1963, pp. 3-39; « Consolazioni per lo specialista », in Critica e crescita della conoscenza, cit.; Contro il metodo, Lampugnani Nigri Editore, Milano, 1973. C'è tuttavia chi non se ne è ancora accorto e insiste, come E. Bellone, nel dissociare crescita della conoscenza e critica, relegando quest'ultima - come una mala erba - « nei giardini degli umanisti » (« L'Unità », 5 luglio 1977, p. 3). L'esito è ovviamente « la costruzione di una società socialista nel consenso » (« L'Unità », 29 agosto 1980, p. 3, c.vo nostro). Il consenso è solo una traduzione stile 1984 della dittatura del proletariato. O il socialismo si costruisce nel dissenso o non si costruisce affatto.
19 Per la congettura di Eulero, si veda il cap. i di I. Lakatos, Dimostrazioni e confutazioni. La logica della scoperta matematica, Feltrinelli, Milano, 1979; per il principio di continuità di Cauchy, si veda I. Lakatos, ibid., Appendice I e Mathematics, science and epistemology, a cura di J. Worral e G. Curry, vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 1978, pp. 43-60 (« Cauchy and the continuum: the significance of non-standard analysis for the history and philosophy of mathematics »); per il principio di Dirichlet si veda G. Giorello, « Mathematische Abstraktion, Dialektik der wissenschaftlichen Forschungsprogramme and Naturerkenntnis », in P. Plath e H.J. Sandkiiler, a cura di, Theorie and Labor. Dialektik als Programm der Naturwissenschaft, Pahl-Rugenstein, Kdln, 1978, pp. 270-297; per le funzioni generalizzate di Dirac, si veda L. Schwartz, « La function 6 et les noyaux », in A. Salam e E.P. Wigner, a cura di, Aspects of quantum mechanics, Cambridge University Press, New York, 1972, pp. 179-182; per il labirinto degli infinitesimi, si veda A. Robinson, Non-standard analysis, North Holland, Amsterdam, 1966, in particolare cap. x, e « The metaphysics of the calculus », in I. Lakatos, a cura di, Problems in the philosophy of ma¬thematics, North Holland, Amsterdam, 1967, pp. 28-46; per «l'immenso oceano » degli indivisibili, si veda E. Giusti, Bonaventura Cavalieri and the theory of indivisibles, di prossima pubblicazione.
20 Cfr. in particolare p. 43 di I. Lakatos, Dimostrazioni e confutazioni, cit.: « La forma dialogica riflette la dialettica della storia ».
21 Si veda in particolare T.S. Kuhn, « The function of dogma in scientific research », in A. Crombie, a cura di, Scientific change, Heinemann, London, 1963, pp. 347-395; La struttura delle rivoluzioni scientifiche, trad. it. di A. Carugo, Einaudi, Torino, 19782; e The essential tension, University of Chicago Press, Chicago, 1977, in particolare alle pp. 225-239.
22 Cfr. J.W.N. Watkins, « Contro la scienza normale », in Critica e crescita della conoscenza, cit., p. 104.
23 Cfr. P.K. Feyerabend, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anar¬chica della conoscenza, trad. it. di L. Sosio, Feltrinelli, Milano, 1979, p. 41.
b Cfr. S. Tagliagambe, « Scene da un matrimonio: la difficile convivenza di epistemologia e storia della scienza », in AA.VV., Scienza e storia. Analisi critica e problemi attuali, « Critica Marxista » - Editori Riuniti, 1980, p. 41, che discute M. Vegetti, « Ragione scientifica e ragioni dell'ideologia: un intervento», in « Quaderni della Fondazione Feltrinelli », 4/5, 1979, p. 142.
25 Cfr. I. Lakatos, « La falsificazione e la metodologia dei programmi di ricerca scientifici », cit., p. 266. Per il solito Bellone, già citato alla nota 18, si tratta qui di « fantasmi filosofici ». (Cfr. Il mondo di carta, Mondadori, Milano, 1976, p. 27.) L'incubo delle « scuole filosofiche » gioca davvero dei pessimi scherzi.
26 Cfr. A. Ryan, J.S. Mill, Routledge and Kegan, London, 1974, p. 129.
27 È questa la riformulazione che J. Rawls dà in A theory of justice, Oxford University Press, Oxford, 1973, p. 250, del principio di libertà di Mill. L'interessante difesa che Rawls fa di questo principio è tuttavia basata su una linea d'argomentazione del tutto diversa da quella di Mill.
28 Cfr. J. Harsanyi, Rational behavior and bargaining equilibrium in games and social situations, Cambridge University Press, Cambridge, 1977, p. 52.
29 Cfr. G. Giorello e M. Mondadori, L'eclisse dei sistemi, « Rinascita », 1979, n. 23, pp. 41-2.
30 Per questa nozione si veda in particolare J. Harsanyi, Rational behavior and bargaining equilibrium in games and social situations, cit., pp. 16-47, oppure Luce and Raiffa, Games and decisions, Wiley, New York, 1957, pp. 12-38.
31 Cfr. FA. Hayek, The road to serfdom, Routledge and Kegan, London, 1944, p. 107.