| Segnala il documento | Stampa | ||||
| Link |
| Creazionisti all'arrembaggio |
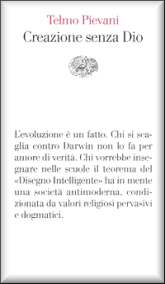
I neocreazionisti adottano varie modalità creative di attacco, basate su tre strategie argomentative e retoriche facilmente delineabili. La prima è: “qualunque cosa succeda, tu nega l’evidenza”. Esistono casistiche recanti ogni tipo di evidenza empirica circa l’azione effettiva della selezione naturale nella trasformazione delle specie? Bene, allora affermiamo che la selezione naturale non è mai stata provata empiricamente oppure che la selezione naturale agisce solo come filtro negativo, ma non ha potere di modificare le specie in positivo. Oppure, ancora, che la selezione naturale ha una definizione tautologica.
Teorie e spaventapasseri
Non è una strategia banale come sembra: consiste nel sottrarsi al dibattito scientifico in atto, sostenere accuse false, negare la realtà empirica condivisa in un determinato campo di studi e portare in questo modo la discussione su un piano totalmente ideologico. L’azione in positivo della selezione naturale è stata ampiamente osservata in laboratorio. Elementi di circolarità nella definizione di una legge di natura non ne pregiudicano il potere esplicativo, altrimenti dovremmo rinunciare a metà della fisica moderna. Si tratta pertanto di una versione particolare di “revisionismo” storico, ma applicato alla scienza. Non vi si nega la realtà di fatti storici certi, ma quella dell’esistenza di fenomeni e processi naturali osservati e documentati da più di un secolo dalla comunità scientifica mondiale. L’effetto desiderato sul piano comunicativo è molto chiaro: obbligare gli avversari a retrocedere, ad uscire dal loro normale terreno di dibattito e a ribadire ciò che davano per scontato da decenni.
La seconda strategia è frutto di eguale sofisticazione sul piano della retorica pubblica e consiste nella puntigliosa strumentalizzazione delle controversie interne alla comunità scientifica, spacciate per difficoltà insormontabili. Gli attivisti del Discovery Institute di Seattle l’hanno battezzata “strategia del cuneo”: infilarsi nelle contraddizioni della teoria evoluzionistica e farla esplodere dall’interno, arrivando alla conclusione che debba essere almeno insegnata nelle scuole una possibile spiegazione alternativa. Il cuneo ha quindi un lato rivolto ai contenuti della teoria darwiniana e un lato rivolto alle incursioni nelle istituzioni educative. Ecco allora che alcuni importanti dibattiti evoluzionistici - come quelli relativi al neutralismo genico, alla teoria degli equilibri punteggiati e alla biologia evolutiva dello sviluppo - pur essendo in realtà tentativi di estendere e non di confutare la capacità esplicativa del programma di ricerca darwiniano, vengono presentati come dilanianti antinomie pronte a deflagrare e a fare implodere la teoria dell’evoluzione da un momento all’altro. Preparate i paramenti per il funerale di Darwin!
Siamo qui dinanzi a una versione raffinata della prima strategia, negare l’evidenza, ma con l’aggiunta di un ulteriore errore: confondere il legittimo, e anche acceso, dibattito fra posizioni diverse riguardo a punti specifici della spiegazione evoluzionistica con la debolezza intrinseca o la contraddittorietà interna della teoria nella sua interezza. In altri campi, programmi di ricerca potentissimi come la meccanica quantistica brulicano di controversie talvolta radicali, al limite dell’eterodossia, ma nessuno si sogna per questo motivo di non usare i derivati tecnologici di quella teoria ogni mattina o di censurarne l’insegnamento nelle scuole. Il trattamento riservato alla teoria dell’evoluzione è del tutto “particolare”.
La terza strategia ha conquistato addirittura il soglio pontificio. E’ il vecchio artificio della caricatura: prendere un aspetto particolare di un volto, o fuor di metafora di una teoria, e deformarlo, ingigantirlo fino a farlo diventare il tratto dominante. Si associa per esempio l’evoluzione biologica all’idea che saremmo tutti “figli del caso e di una storia senza senso”. Ancora una volta, si vuole che il dibattito prescinda completamente dai contenuti reali della teoria, che non presenta affatto un impianto esplicativo casualistico, essendo la mutazione casuale soltanto la materia prima di un processo di trasformazione assai più articolato che include una molteplicità di meccanismi evolutivi per nulla casuali, primo fra tutti la selezione naturale. Le mutazioni sono “contingenti” rispetto ai loro potenziali effetti adattativi in un ambiente e talvolta si possono fissare in una popolazione per “derive” casuali, ma il motore selettivo dell’evoluzione è un processo sostanzialmente deterministico. L’evoluzione darwiniana non è un lancio di dadi. Eppure la strategia funziona: la teoria da squalificare viene trasformata in uno spaventapasseri e poi si picchia duro. Che la teoria dell’evoluzione sia o meno una “minaccia per la dignità umana” è opinabile, ma è sicuramente scorretto attribuire tale minaccia a qualcosa che la teoria non ha mai sostenuto.
Attenti al cuneo (della verità)
Il campione che assomma in sé l’intero spettro di queste pirotecniche retoriche è senza dubbio il volenteroso avvocato americano Phillip E. Johnson, autore del famigerato Darwin on Trial del 1993, volume che non può mancare nella prima fila della biblioteca del buon creazionista. Vi si troveranno descritte tutte le perfidie della visione “darwinista” della realtà, a cominciare dal materialismo, dall’ateismo, dall’ormai desueto illuminismo (che in ogni caso è un frutto, degenerato, del cristianesimo), per giungere al positivismo (anzi, bisogna dire al “vetero-positivismo”), al comunismo (ebbene sì, nonostante Lysenko), al terrorismo, alla “cultura di morte” di chi nega “l’inviolabilità dell’embrione”, e ovviamente al tanto vituperato “riduzionismo”, che non si capisce mai bene cosa sia ma è comunque la sentina di ogni male in Terra, a prescindere.
“Il cuneo della verità” è il titolo minaccioso di un altro lavoro di questo volenteroso carnefice del naturalismo. Il crociato sfodera tutte le sue armi avvocatizie, le consumate tecniche dell’arringa, i trucchi da dibattito politico televisivo: citazioni riportate senza contesto, terminologia parascientifica del tutto inventata, distorsione degli argomenti degli avversari, attacco alla persona quando non fanno più presa altri argomenti, ammiccamenti alla pancia irrazionale del teleutente, risposte arroganti ed elusive ai commentatori critici. Il discredito contro la scienza colpisce a casaccio: modestamente, da Francis Crick ad Albert Einstein, non si salva nessuno. L’evoluzione diventa automaticamente “scientismo”, cioè l’idea che la scienza sia l’unica forma di conoscenza ammissibile da cui tutte le altre dovrebbero dipendere: una categoria che gode dell’interessante caratteristica di avere il differenziale massimo fra il numero di volte in cui viene richiamata come uno spauracchio da chiunque e il numero esiguo di esempi concreti a cui si riferisce.
Quando il fascino della toga non basta più, subentrano i toni eccitati da imbonitore e da predicatore del sud, di quelli che urlano “l’amore è la risposta!” con la stessa faccia che avrebbe un terrorista pronto a farsi esplodere con il mondo intero. Subentrano le previsioni apocalittiche del profeta che annuncia il crollo imminente del darwinismo, la sua definitiva scomparsa entro il bicentenario del 2009, che si trasformerà in un funerale definitivo. Poi però, per paura della verifica imminente, si corregge e precisa che la teoria darwiniana sarà morta e sepolta sicuramente per il bicentenario dell’Origine delle specie del 2059. Sempre meglio spostare un po’ più in là la fine del mondo…
Prima che il cuneo della verità ci travolga o ci faccia qualche altro brutto scherzo, osserviamo quanto simili strategie di manipolazione della realtà pongano un serio problema di metodo e di etica della comunicazione a chi non vi aderisce: gli scienziati devono accettare o no il dialogo in pubblico con i neocreazionisti? I due eterni duellanti della biologia evoluzionistica, Stephen J. Gould e Richard Dawkins, convennero di firmare insieme una lettera, nel dicembre del 2001, nella quale proponevano a tutti i colleghi di non aderire più agli inviti ai dibattiti con i neocreazionisti - almeno nelle sedi universitarie, nei campus e nei musei scientifici – per non offrire loro l’implicita ammissione nelle arene accademiche di discussione, vanificando così ogni “effetto cuneo”. La subitanea scomparsa di Gould, pochi mesi dopo, ha impedito che la lettera suscitasse un adeguato dibattito. Niles Eldredge, amico e collega di quest’ultimo, ha mostrato però il suo disaccordo per la proposta: a suo avviso, la scienza non deve sottrarsi mai al confronto e deve rispondere apertamente ai suoi avversari, convincendo il pubblico con la forza delle sue argomentazioni. Anche in Italia se ne dibatte, fra chi pugnacemente vorrebbe ribattere colpo su colpo e chi un po’ snobisticamente invita a non dare retta, e a non offrire pubblicità gratuita, a una sfida intellettuale che non merita nemmeno di essere colta.
Vi sono buone ragioni in entrambi gli schieramenti. Invitare un avvocato creazionista sul palco di Harvard significa francamente concedergli un onore non meritato e, forse, la presenza paritaria di uno scienziato rischierebbe di avallare in modo ambiguo un eccesso di “politicamente corretto”, come se davvero si scontrassero due teorie scientifiche alternative e non invece una spiegazione scientifica e un dogma di fede. E’ un fraintendimento che ricorre spesso nei dibattiti o nei finti processi che riguardano Darwin. D’altro canto, nei casi di discussione pubblica sulla stampa e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, perché gli scienziati dovrebbero concedere ai neocreazionisti una platea mediatica senza contraddittorio, di fronte a un pubblico di massa che difficilmente ha gli strumenti per discernere il grano dal loglio?
Il problema è che esiste una forte asimmetria fra le modalità di comunicazione dei due fronti: il neocreazionista pone questioni fasulle ma semplici, dirette, elementari, che non richiedono alcuna competenza né preparazione per essere colte; lo scienziato per rispondere adeguatamente deve ricorrere a una spiegazione molto più articolata, a volte impossibile da sintetizzare in poche parole e nei tempi serrati dei dibattiti mediatici, perché ha bisogno di introdurre definizioni e concetti poco noti. Di fronte a un uditorio di non esperti i neocreazionisti godono di un vantaggio iniziale: possono fare in modo che la scienza si ritiri sempre sulla difensiva, come se fosse realmente in difficoltà rispetto alle obiezioni ideologiche della controparte. Non è un gioco leale. L’evoluzionista deve rispettare, volente o nolente, un codice di comportamento che preveda un minimo di precisione, di onestà intellettuale e di argomentazione. L’avversario non ha regole. Il libro del tal creazionista è stato stroncato dalle critiche? Segno che esprimeva verità scomode. Non è stato degnato nemmeno di una recensione? Segno che la scienza ha la coda di paglia e non affronta il dissenso. Non se ne esce.
Non a caso, Johnson sottolinea spesso nei suoi libri, con un certo compiacimento, di volersi rivolgere a un pubblico che non ha alcuna conoscenza scientifica ed è incline a diffidare della scienza. L’intento di giocare sulla presunta ignoranza altrui è dunque palese. Del resto, tutti diffidiamo un po’ della scienza (tranne quando un’ambulanza ci sta portando al pronto soccorso). Ma Johnson si fa vanto di non essere uno scienziato, perché in questo modo non sarà vittima dello specialismo che limita la visione dei ricercatori. Egli si definisce “una mente aperta” che sfida le bugie scientifiche. Non si capisce bene perché un avvocato dovrebbe essere meglio di uno scienziato, pur specialista, nello spiegare l’evoluzione, ma chiaramente il tentativo è quello di sostituirsi come nuovo “mediatore” fra un mondo della scienza arroccato sulle proprie ideologie e il popolo ingenuo dei non addetti ai lavori. Così il paladino dell’antidarwinismo amatoriale può spingersi a sfidare l’autorità dei padri della teoria evoluzionistica, dipingendoli come difensori di un “verbo” dogmatico e compiendo in questo modo un perfetto rovesciamento della realtà. Il fondamentalista cristiano che accusa la scienza di essere diventata una religione.
Se Johnson può dire la sua sull’evoluzione, tutti lo possono fare. Suona molto democratico. Opportunamente, nell’aprile del 2005, la rivista Nature ha lanciato con grande risalto un allarme autocritico proprio su questo punto: la debolezza della comunicazione e delle capacità persuasive degli scienziati nella controversia fra evoluzione e creazionismo, non soltanto sui media, ma anche nei college e nei campus universitari. Le responsabilità degli scienziati nel non saper trasmettere con sufficiente coinvolgimento i contenuti della ricerca scientifica si sommano all’attrattiva irresistibile che può avere per un ragazzo, magari proveniente da famiglie molto religiose degli stati della “cintura della Bibbia”, una proposta che cerchi di conciliare a buon mercato scienza e fede. Il tecnicismo, l’astrattezza severa, un certo pragmatismo punitivo, taluni trionfalismi acritici completano l’opera nefasta che impedisce alla scienza di mostrarsi per ciò che è: un’impresa collettiva di conoscenza, una forma alta di cultura che nella sua miscela di rigore e di immaginazione trova le ragioni del suo fascino ma anche della sua non sempre immediata specificità.
Sull’altro fronte, poi, c’è chi fa politica, non scienza. In assenza di programmi di ricerca empirici, di pubblicazioni su riviste specializzate, di dati sperimentali confrontabili e verificabili, i neocreazionisti spingono il loro cuneo con le armi del lobbismo più spregiudicato e di una politica culturale aggressiva: stringono alleanze con gruppi di pressione cristiani fondamentalisti, organizzano conferenze nei campus, raduni e cene per raccogliere fondi, reclutano studenti, vendono libri e opuscoli a mani basse. Il nemico è quello di sempre, cioè l’ateismo naturalistico immorale che si infiltrerebbe nelle scuole grazie alla vulgata darwiniana: il re degli spaventapasseri.
Teorie e spaventapasseri
Non è una strategia banale come sembra: consiste nel sottrarsi al dibattito scientifico in atto, sostenere accuse false, negare la realtà empirica condivisa in un determinato campo di studi e portare in questo modo la discussione su un piano totalmente ideologico. L’azione in positivo della selezione naturale è stata ampiamente osservata in laboratorio. Elementi di circolarità nella definizione di una legge di natura non ne pregiudicano il potere esplicativo, altrimenti dovremmo rinunciare a metà della fisica moderna. Si tratta pertanto di una versione particolare di “revisionismo” storico, ma applicato alla scienza. Non vi si nega la realtà di fatti storici certi, ma quella dell’esistenza di fenomeni e processi naturali osservati e documentati da più di un secolo dalla comunità scientifica mondiale. L’effetto desiderato sul piano comunicativo è molto chiaro: obbligare gli avversari a retrocedere, ad uscire dal loro normale terreno di dibattito e a ribadire ciò che davano per scontato da decenni.
La seconda strategia è frutto di eguale sofisticazione sul piano della retorica pubblica e consiste nella puntigliosa strumentalizzazione delle controversie interne alla comunità scientifica, spacciate per difficoltà insormontabili. Gli attivisti del Discovery Institute di Seattle l’hanno battezzata “strategia del cuneo”: infilarsi nelle contraddizioni della teoria evoluzionistica e farla esplodere dall’interno, arrivando alla conclusione che debba essere almeno insegnata nelle scuole una possibile spiegazione alternativa. Il cuneo ha quindi un lato rivolto ai contenuti della teoria darwiniana e un lato rivolto alle incursioni nelle istituzioni educative. Ecco allora che alcuni importanti dibattiti evoluzionistici - come quelli relativi al neutralismo genico, alla teoria degli equilibri punteggiati e alla biologia evolutiva dello sviluppo - pur essendo in realtà tentativi di estendere e non di confutare la capacità esplicativa del programma di ricerca darwiniano, vengono presentati come dilanianti antinomie pronte a deflagrare e a fare implodere la teoria dell’evoluzione da un momento all’altro. Preparate i paramenti per il funerale di Darwin!
Siamo qui dinanzi a una versione raffinata della prima strategia, negare l’evidenza, ma con l’aggiunta di un ulteriore errore: confondere il legittimo, e anche acceso, dibattito fra posizioni diverse riguardo a punti specifici della spiegazione evoluzionistica con la debolezza intrinseca o la contraddittorietà interna della teoria nella sua interezza. In altri campi, programmi di ricerca potentissimi come la meccanica quantistica brulicano di controversie talvolta radicali, al limite dell’eterodossia, ma nessuno si sogna per questo motivo di non usare i derivati tecnologici di quella teoria ogni mattina o di censurarne l’insegnamento nelle scuole. Il trattamento riservato alla teoria dell’evoluzione è del tutto “particolare”.
La terza strategia ha conquistato addirittura il soglio pontificio. E’ il vecchio artificio della caricatura: prendere un aspetto particolare di un volto, o fuor di metafora di una teoria, e deformarlo, ingigantirlo fino a farlo diventare il tratto dominante. Si associa per esempio l’evoluzione biologica all’idea che saremmo tutti “figli del caso e di una storia senza senso”. Ancora una volta, si vuole che il dibattito prescinda completamente dai contenuti reali della teoria, che non presenta affatto un impianto esplicativo casualistico, essendo la mutazione casuale soltanto la materia prima di un processo di trasformazione assai più articolato che include una molteplicità di meccanismi evolutivi per nulla casuali, primo fra tutti la selezione naturale. Le mutazioni sono “contingenti” rispetto ai loro potenziali effetti adattativi in un ambiente e talvolta si possono fissare in una popolazione per “derive” casuali, ma il motore selettivo dell’evoluzione è un processo sostanzialmente deterministico. L’evoluzione darwiniana non è un lancio di dadi. Eppure la strategia funziona: la teoria da squalificare viene trasformata in uno spaventapasseri e poi si picchia duro. Che la teoria dell’evoluzione sia o meno una “minaccia per la dignità umana” è opinabile, ma è sicuramente scorretto attribuire tale minaccia a qualcosa che la teoria non ha mai sostenuto.
Attenti al cuneo (della verità)
Il campione che assomma in sé l’intero spettro di queste pirotecniche retoriche è senza dubbio il volenteroso avvocato americano Phillip E. Johnson, autore del famigerato Darwin on Trial del 1993, volume che non può mancare nella prima fila della biblioteca del buon creazionista. Vi si troveranno descritte tutte le perfidie della visione “darwinista” della realtà, a cominciare dal materialismo, dall’ateismo, dall’ormai desueto illuminismo (che in ogni caso è un frutto, degenerato, del cristianesimo), per giungere al positivismo (anzi, bisogna dire al “vetero-positivismo”), al comunismo (ebbene sì, nonostante Lysenko), al terrorismo, alla “cultura di morte” di chi nega “l’inviolabilità dell’embrione”, e ovviamente al tanto vituperato “riduzionismo”, che non si capisce mai bene cosa sia ma è comunque la sentina di ogni male in Terra, a prescindere.
“Il cuneo della verità” è il titolo minaccioso di un altro lavoro di questo volenteroso carnefice del naturalismo. Il crociato sfodera tutte le sue armi avvocatizie, le consumate tecniche dell’arringa, i trucchi da dibattito politico televisivo: citazioni riportate senza contesto, terminologia parascientifica del tutto inventata, distorsione degli argomenti degli avversari, attacco alla persona quando non fanno più presa altri argomenti, ammiccamenti alla pancia irrazionale del teleutente, risposte arroganti ed elusive ai commentatori critici. Il discredito contro la scienza colpisce a casaccio: modestamente, da Francis Crick ad Albert Einstein, non si salva nessuno. L’evoluzione diventa automaticamente “scientismo”, cioè l’idea che la scienza sia l’unica forma di conoscenza ammissibile da cui tutte le altre dovrebbero dipendere: una categoria che gode dell’interessante caratteristica di avere il differenziale massimo fra il numero di volte in cui viene richiamata come uno spauracchio da chiunque e il numero esiguo di esempi concreti a cui si riferisce.
Quando il fascino della toga non basta più, subentrano i toni eccitati da imbonitore e da predicatore del sud, di quelli che urlano “l’amore è la risposta!” con la stessa faccia che avrebbe un terrorista pronto a farsi esplodere con il mondo intero. Subentrano le previsioni apocalittiche del profeta che annuncia il crollo imminente del darwinismo, la sua definitiva scomparsa entro il bicentenario del 2009, che si trasformerà in un funerale definitivo. Poi però, per paura della verifica imminente, si corregge e precisa che la teoria darwiniana sarà morta e sepolta sicuramente per il bicentenario dell’Origine delle specie del 2059. Sempre meglio spostare un po’ più in là la fine del mondo…
Prima che il cuneo della verità ci travolga o ci faccia qualche altro brutto scherzo, osserviamo quanto simili strategie di manipolazione della realtà pongano un serio problema di metodo e di etica della comunicazione a chi non vi aderisce: gli scienziati devono accettare o no il dialogo in pubblico con i neocreazionisti? I due eterni duellanti della biologia evoluzionistica, Stephen J. Gould e Richard Dawkins, convennero di firmare insieme una lettera, nel dicembre del 2001, nella quale proponevano a tutti i colleghi di non aderire più agli inviti ai dibattiti con i neocreazionisti - almeno nelle sedi universitarie, nei campus e nei musei scientifici – per non offrire loro l’implicita ammissione nelle arene accademiche di discussione, vanificando così ogni “effetto cuneo”. La subitanea scomparsa di Gould, pochi mesi dopo, ha impedito che la lettera suscitasse un adeguato dibattito. Niles Eldredge, amico e collega di quest’ultimo, ha mostrato però il suo disaccordo per la proposta: a suo avviso, la scienza non deve sottrarsi mai al confronto e deve rispondere apertamente ai suoi avversari, convincendo il pubblico con la forza delle sue argomentazioni. Anche in Italia se ne dibatte, fra chi pugnacemente vorrebbe ribattere colpo su colpo e chi un po’ snobisticamente invita a non dare retta, e a non offrire pubblicità gratuita, a una sfida intellettuale che non merita nemmeno di essere colta.
Vi sono buone ragioni in entrambi gli schieramenti. Invitare un avvocato creazionista sul palco di Harvard significa francamente concedergli un onore non meritato e, forse, la presenza paritaria di uno scienziato rischierebbe di avallare in modo ambiguo un eccesso di “politicamente corretto”, come se davvero si scontrassero due teorie scientifiche alternative e non invece una spiegazione scientifica e un dogma di fede. E’ un fraintendimento che ricorre spesso nei dibattiti o nei finti processi che riguardano Darwin. D’altro canto, nei casi di discussione pubblica sulla stampa e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, perché gli scienziati dovrebbero concedere ai neocreazionisti una platea mediatica senza contraddittorio, di fronte a un pubblico di massa che difficilmente ha gli strumenti per discernere il grano dal loglio?
Il problema è che esiste una forte asimmetria fra le modalità di comunicazione dei due fronti: il neocreazionista pone questioni fasulle ma semplici, dirette, elementari, che non richiedono alcuna competenza né preparazione per essere colte; lo scienziato per rispondere adeguatamente deve ricorrere a una spiegazione molto più articolata, a volte impossibile da sintetizzare in poche parole e nei tempi serrati dei dibattiti mediatici, perché ha bisogno di introdurre definizioni e concetti poco noti. Di fronte a un uditorio di non esperti i neocreazionisti godono di un vantaggio iniziale: possono fare in modo che la scienza si ritiri sempre sulla difensiva, come se fosse realmente in difficoltà rispetto alle obiezioni ideologiche della controparte. Non è un gioco leale. L’evoluzionista deve rispettare, volente o nolente, un codice di comportamento che preveda un minimo di precisione, di onestà intellettuale e di argomentazione. L’avversario non ha regole. Il libro del tal creazionista è stato stroncato dalle critiche? Segno che esprimeva verità scomode. Non è stato degnato nemmeno di una recensione? Segno che la scienza ha la coda di paglia e non affronta il dissenso. Non se ne esce.
Non a caso, Johnson sottolinea spesso nei suoi libri, con un certo compiacimento, di volersi rivolgere a un pubblico che non ha alcuna conoscenza scientifica ed è incline a diffidare della scienza. L’intento di giocare sulla presunta ignoranza altrui è dunque palese. Del resto, tutti diffidiamo un po’ della scienza (tranne quando un’ambulanza ci sta portando al pronto soccorso). Ma Johnson si fa vanto di non essere uno scienziato, perché in questo modo non sarà vittima dello specialismo che limita la visione dei ricercatori. Egli si definisce “una mente aperta” che sfida le bugie scientifiche. Non si capisce bene perché un avvocato dovrebbe essere meglio di uno scienziato, pur specialista, nello spiegare l’evoluzione, ma chiaramente il tentativo è quello di sostituirsi come nuovo “mediatore” fra un mondo della scienza arroccato sulle proprie ideologie e il popolo ingenuo dei non addetti ai lavori. Così il paladino dell’antidarwinismo amatoriale può spingersi a sfidare l’autorità dei padri della teoria evoluzionistica, dipingendoli come difensori di un “verbo” dogmatico e compiendo in questo modo un perfetto rovesciamento della realtà. Il fondamentalista cristiano che accusa la scienza di essere diventata una religione.
Se Johnson può dire la sua sull’evoluzione, tutti lo possono fare. Suona molto democratico. Opportunamente, nell’aprile del 2005, la rivista Nature ha lanciato con grande risalto un allarme autocritico proprio su questo punto: la debolezza della comunicazione e delle capacità persuasive degli scienziati nella controversia fra evoluzione e creazionismo, non soltanto sui media, ma anche nei college e nei campus universitari. Le responsabilità degli scienziati nel non saper trasmettere con sufficiente coinvolgimento i contenuti della ricerca scientifica si sommano all’attrattiva irresistibile che può avere per un ragazzo, magari proveniente da famiglie molto religiose degli stati della “cintura della Bibbia”, una proposta che cerchi di conciliare a buon mercato scienza e fede. Il tecnicismo, l’astrattezza severa, un certo pragmatismo punitivo, taluni trionfalismi acritici completano l’opera nefasta che impedisce alla scienza di mostrarsi per ciò che è: un’impresa collettiva di conoscenza, una forma alta di cultura che nella sua miscela di rigore e di immaginazione trova le ragioni del suo fascino ma anche della sua non sempre immediata specificità.
Sull’altro fronte, poi, c’è chi fa politica, non scienza. In assenza di programmi di ricerca empirici, di pubblicazioni su riviste specializzate, di dati sperimentali confrontabili e verificabili, i neocreazionisti spingono il loro cuneo con le armi del lobbismo più spregiudicato e di una politica culturale aggressiva: stringono alleanze con gruppi di pressione cristiani fondamentalisti, organizzano conferenze nei campus, raduni e cene per raccogliere fondi, reclutano studenti, vendono libri e opuscoli a mani basse. Il nemico è quello di sempre, cioè l’ateismo naturalistico immorale che si infiltrerebbe nelle scuole grazie alla vulgata darwiniana: il re degli spaventapasseri.
| Il blog di Massimo Pigliucci | |
| Il suo sito: "rationally speaking" | |
| The Panda's Thumb |