| Segnala il documento | Stampa | ||||
| Machiavelli, Galileo e il dilemma della filosofia |
| di Mario De Caro |
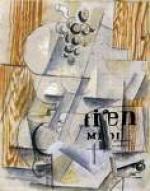
Quando diedero rispettivamente avvio alla scienza politica e alla scienza naturale moderne, Niccolò Machiavelli e Galileo Galilei certo non potevano immaginare che da lì a poco la cultura italiana – che ai loro tempi si irradiava sull’intero Occidente – sarebbe entrata in una crisi profondissima, dalla quale in sostanza non si sarebbe più ripresa. Ma se il contributo di quei due grandi fu l’ultimo veramente rilevante che il nostro paese offrì all’elaborazione delle categorie intellettuali della Modernità, esso almeno fu decisivo; e ciò non soltanto per le sorti della scienza politica e di quella della natura. Con le loro riflessioni, infatti, Machiavelli e Galileo diedero l’impulso iniziale all’elaborazione di due fondamentali prospettive di indagine sul mondo umano che continuano ancora oggi ad esercitare un’enorme influenza: per esempio, come si vedrà, nel contesto della vivace querelle attualmente in corso attorno al concetto di “natura umana”.
Il comune denominatore di queste due concezioni che, originando da Machiavelli e Galileo, si propagano sino ad oggi è il loro carattere integralmente secolarizzato. Con quei grandi pensatori, infatti, l’indagine sulle leggi immutabili della politica e della natura si sviluppò al riparo dalle interferenze teologiche, che invece avevano continuato ad investire molte delle più significative esperienze filosofiche del Rinascimento. Al di là di questo aspetto comune, tuttavia, la concezione machiavelliana e quella galileiana contribuirono in maniera molto diversa all’opera di riconcettualizzazione del mondo umano che, nella nuova prospettiva post-teologica, prendeva allora le mosse. Laddove in Machiavelli dominava l’idea della costitutiva storicità del mondo degli uomini, nella prospettiva galileiana era implicita la possibilità della riconduzione, senza residui, dell’indagine su tale mondo alle scienze naturali. Due punti di vista, questi, che avrebbero segnato la dialettica filosofica nei secoli a venire e che la segnano ancora oggi, in forma di cruciale spartiacque all’interno della più generale visione secolarizzata del mondo.
La nuova prospettiva antropologica di Machiavelli è bene illustrata da una celebre doppia analogia del Principe. Gli esseri umani sono come i centauri, per una parte razionali e per un’altra animali (ma in proposito va ricordato che la concezione machiavelliana della razionalità è modernamente incentrata sulla valutazione delle azioni in base al rapporto mezzi-fini, non sulle idealizzazioni angelicate che ne avevano date i neoplatonici fiorentini). La parte animale degli uomini, poi, è a sua volta bipartita: per metà implica l’astuzia della volpe e per l’altra metà la forza bruta del leone. Ma l’antropologia machiavelliana è zoomorfica solo metaforicamente, a suggerire l’ispirazione materialistica del quadro concettuale. Ciò che realmente conta è che tale antropologia si caratterizza come intrinsecamente storica. In questa prospettiva, la storia e solo la storia – intesa in un senso profondamente laico, depurato di ogni finalismo – permette di comprendere le invarianti dell’agire umano; più specificamente, soltanto lo studio dei concreti exempla del passato rende possibile individuare le leggi immutabili cui l’agire politico obbedisce. In questo senso, Machiavelli è all’origine di una concezione dell’umano che avrà grande fortuna.
Di assai diverso impianto, pur sullo sfondo di una comune ispirazione secolarizzante, è la concezione dell’umano che origina in Galileo. Per la “philosophia naturalis” dello scienziato pisano, infatti, l’ambito del reale si limita esclusivamente alle proprietà matematizzabili delle cose: ovvero alle loro dimensioni, alle loro forme, al moto, al numero. In questa prospettiva, come si legge nel Saggiatore, per investigare ciò che esiste è indispensabile “rimuovere” preliminarmente l’“animale” umano dal contesto dell’indagine. E ciò significa che il mondo dei colori, dei sapori, delle sensazioni – e, più in generale, il mondo di tutto ciò che è legato al punto di vista soggettivo – è costituito in realtà di puri “nomi”, di mere apparenze, e va dunque espunto dal novero di ciò che esiste e dunque anche dall’ambito del conoscibile. Come dirà poi Husserl, la concezione galileiana del mondo presuppone la deliberata rimozione del “mondo della vita”. Una rimozione che fu certo utile, anzi indispensabile, per i formidabili sviluppi successivi della scienza della natura; ma molto più controversa rispetto alle sue implicazioni per le future scienze dell’uomo e per la stessa filosofia.
Da una parte, dunque, si pone l’idea machiavelliana che la specificità dell’essere umano vada rintracciata nella sua storicità, nel suo essere un “animale storico”, per così dire. L’indagine sull’ambito umano, in questo quadro, non potrà che porsi da una prospettiva che privilegia la dimensione storica dell’esistenza. Dall’altra parte, si pone l’idea galileiana che nella natura umana non ci sia nulla di peculiare, che tutto ciò che a noi pare differenziarci dai corpi fisici sia in realtà illusorio e dunque vada ignorato. In questa prospettiva, le indagini sul mondo umano non potranno che informarsi allo spirito delle scienze naturali.
Riflessione intrinsecamente storica, secondo la prospettiva machiavelliana, oppure impresa contigua alla scienza naturale, secondo quella galileiana? Sono queste le opzioni principali che, secondo le indicazioni dei due nostri massimi pensatori, si aprono alla riflessione sul mondo umano una volta assunto come quadro concettuale di sfondo quello della secolarizzazione. Oggi, naturalmente, vi sono differenze intellettualmente rilevanti rispetto alla prima Modernità: lo strumentario scientifico, in particolare, è ora radicalmente diverso, sia per gli immensi progressi conseguiti negli ultimi secoli dalle scienze della natura sia per i contributi offerti dai nuovi ambiti delle scienze umane. Eppure non è difficile constatare che la dualità tra le prospettive con cui Machiavelli e Galilei concepirono rispettivamente lo studio del mondo umano si perpetua ancora oggi, e ciò anche in contesti culturali – come la filosofia anglosassone contemporanea – nei quali non sempre c’è piena consapevolezza delle radici storiche di tale contrapposizione. In questo senso, è particolarmente significativo mettere a confronto le opere più recenti di Daniel Dennett e di Bernard Williams, due tra i massimi esponenti di quel mondo filosofico.
Dennett oggi è forse il più noto promotore di una filosofia programmaticamente scientifica, che nella sua ispirazione ricorda chiaramente il positivismo ottocentesco e, andando più indietro, la concezione di ispirazione galileiana che investe la scienza naturale – e solo la scienza naturale – del compito di fornire una comprensione esaustiva del reale. Secondo la prospettiva dennettiana, dunque, la missione della filosofia è quella di “chiarire e unificare le prospettive spesso divergenti [delle scienze] in una singola visione dell’universo”. In questo quadro, Dennett ha operato molteplici tentativi di ricondurre nell’alveo delle scienze naturali i concetti fondamentali con cui la tradizione filosofica e le scienze umane hanno indagato la natura e la cultura dell’animale-uomo: dal concetto di coscienza a quello di intenzionalità, da quello di libero arbitrio a quello di responsabilità morale. La sua strategia, soprattutto negli ultimi anni, si incentra soprattutto sull’uso di categorie e forme di spiegazione tratte dalla teoria dell’evoluzione (ma senza ignorare gli apporti della neurofisiologia, dell’intelligenza artificiale, della genetica, della fisica).
In questo spirito, con il recente volume Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon (Viking, New York 2006), Dennett si è proposto di “naturalizzare” il fenomeno delle religioni. La sua tesi fondamentale è che i “sistemi sociali i cui membri credono in uno o più agenti soprannaturali di cui ricercano l’approvazione” possano essere adeguatamente comprese indagandone i vantaggi adattativi. In questa luce, per fare un esempio, Dennett congettura che il tasso di sopravvivenza dell’Homo sapiens fosse superiore a quello dei suoi cugini ominidi in forza dell’“effetto placebo” connesso alle pratiche degli sciamani: pratiche che solo un contesto religioso poteva rendere possibili. Le pratiche religiose, dunque, si perpetuarono perché offrivano un vantaggio evolutivo importante. E spiegazioni simili, secondo Dennett, possono essere offerte anche rispetto mondo religioso contemporaneo: la sua idea è che oggi i sistemi di credenze confessionali competano tra di loro nel tentativo di procurarsi il maggior numero di fedeli e il compito dello scienziato-filosofo sia quello di valutare quantitativamente le loro capacità di espansione. Solo le religioni più adeguate ai contesti sociali e culturali possono sopravvivere ed espandersi: e così, secondo Dennett, se ne possono spiegare la fortuna e il senso.
Un tale ragionamento, ovviamente, ignora le religioni che non cercano affatto di espandersi, come per esempio quella dei drusi che pure è sopravvissuta per centinaia di anni; ma non è questo il punto centrale. E neppure è interessante discutere se ricerche sociologico-culturali di impianto evoluzionistico come questa siano legittime: lo sono certamente, e in taluni casi esse possono anche essere illuminanti. Ciò che è importante determinare, però, è se tali ricerche possano dare esaustivamente conto della fenomenologia religiosa o perlomeno dei suoi aspetti più rilevanti, come ritiene Dennett (e un domanda analoga potrebbe riguardare i concetti filosofici che egli, con procedure analoghe, tenta di ricondurre alle categorie delle scienze naturali).
Per rispondere a questa domanda, è utile rivolgersi ad un’altra proposta filosofica: quella sviluppata da Bernard Williams in un importante volume uscito postumo, Philosophy as a Historical Discipline (Princeton University Press, Princeton 2006). Se Dennett concepisce l’indagine sul mondo umano in una chiave che potremmo definire neogalileiana, Williams si pone piuttosto da una prospettiva che ricorda quella, caratterizzata dalla centralità filosofica della storia, propria di Machiavelli. Ciò che rende questo volume di particolare interesse è che Williams proviene da un ambiente culturale tradizionalmente alieno dalle prospettive storiche a ovvero la filosofia analitica (della quale egli è stato uno dei maggiori interpreti). Questa origine, peraltro, fa sì che Williams non compia il passo teoreticamente arrischiato – non raro in altri contesti filosofici – di far seguire alla critica di concezioni del genere di quella di Dennett l’adesione a forme estreme di relativismo o di irrazionalismo. Williams non nega affatto che sia legittimo porre alla scienza l’obiettivo di offrire una visione complessiva, unitaria e definitiva del mondo naturale (ciò che Williams chiama la “concezione assoluta del mondo”). Ciò che è errato, tuttavia, è ritenere che, siccome tale aspirazione è legittima, allora tutte le forme di comprensione della realtà debbano essere riconducibili, almeno idealmente, alle scienze della natura.
In realtà, sostiene Williams, non c’è ragione di credere che il mondo umano possa essere compreso soltanto con le modalità delle scienze naturali, per esempio con lo strumentario della teoria dell’evoluzione. Così, ciò che una spiegazione in termini evolutivi può riuscire a fare è soltanto di dare conto della capacità peculiarmente umana di elaborare pratiche culturali: ma essa non può spiegare senso, contenuto e natura di tali pratiche. Scrive Williams: “È proprio il fatto che le variazioni e gli sviluppi delle pratiche culturali non sono determinate a livello evolutivo che fa sì che la caratteristica umana di vivere all’interno della cultura produca un successo evolutivo così straordinario”. Se è così, analisi come quella che Dennett offre dei fenomeni religiosi tutt’al più possono aiutare a comprendere la capacità umana di produrre le pratiche del culto, ma non possono esaurire il significato delle pratiche medesime.
Ma qual è allora, in questa prospettiva, il compito della filosofia? La risposta di Williams è che – a parte casi peculiari del tutto legittimi, come per esempio quando essa si occupa dei fondamenti delle discipline scientifiche, quali la meccanica quantistica o la stessa teoria dell’evoluzione – la filosofia è parte di una più generale impresa umanistica, che ha come obiettivo l’autocomprensione. E a questa impresa la filosofia può contribuire sia con un’opera di chiarificazione concettuale sia, soprattutto, dando conto dell’irriducibile contingenza che informa le categorie e i valori delle nostre concezioni etico-politiche. Le idee e i valori che ci appaiono corretti in ambito pratico, infatti, sono innegabilmente un lascito in qualche misura accidentale del nostro passato: se tale passato fosse stato diverso, le nostre opinioni etico-politiche, e più in generale la nostra cultura, avrebbero potuto essere diverse (come prova il fatto che altre epoche e altre comunità hanno valori e concezioni diversi dai nostri). In ragione di questa ineliminabile contingenza storica, il tentativo – proprio di molte concezioni filosofiche – di dedurre a priori un insieme di tesi valide universalmente non potrà mai esaurire il compito della filosofia; né potrà farlo, come si è detto, uno studio puramente empirico dei fenomeni culturali. Nel vagliare le pretese di universalità della nostra cultura, allora, la filosofia non può ignorarne la genesi contingente. È per questa ragione che la filosofia è intimamente legata alla storia: “la comprensione riflessiva delle nostre idee e delle nostre motivazioni, che mi pare sia universalmente considerata come un obiettivo della filosofia”, scrive Williams, “implica la comprensione storica”. Il vecchio Niccolò ne sarebbe stato contento.
Mario De Caro
Pubblicato su Il Manifesto del 4 ottobre 2006, p.12
SCHEDA.
Nella prima parte del Novecento, i filosofi più influenti nel mondo anglosassone (da Frege a Wittgenstein, da Moore a Carnap) hanno disdegnato ogni contaminazione della loro riflessione tanto con la storia quanto quelle con la scienza. Quest’epoca sembra ormai tramontata e oggi, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, un robusto schieramento di filosofi filo-scientifici si contrappone a una meno numerosa, ma non meno vivace, falange di filosofi attenti alla dimensione storica dei problemi. Nel primo gruppo si segnalano, oltre a Daniel Dennett (del quale si vedano anche L’evoluzione della libertà, Cortina, Milano 2004, e Sweet Dreams. Illusioni filosofiche sulla coscienza, Cortina, Milano 2006, rispettivamente dedicati ai tentativi di naturalizzare il libero arbitrio e la coscienza), Jerry Fodor (del quale si veda Mente e linguaggio, Laterza, Roma-Bari 2001) e Paul Churchland (Il motore della ragione, la sede dell’anima, Il Saggiatore, Milano 1998).
Del filone filo-storico fanno invece parte, oltre a Williams, Hilary Putnam (Ragione, verità e storia, Il Saggiatore, Milano 1994) e Robert Brandom (Tales of the Mighty Dead, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2002).
Il comune denominatore di queste due concezioni che, originando da Machiavelli e Galileo, si propagano sino ad oggi è il loro carattere integralmente secolarizzato. Con quei grandi pensatori, infatti, l’indagine sulle leggi immutabili della politica e della natura si sviluppò al riparo dalle interferenze teologiche, che invece avevano continuato ad investire molte delle più significative esperienze filosofiche del Rinascimento. Al di là di questo aspetto comune, tuttavia, la concezione machiavelliana e quella galileiana contribuirono in maniera molto diversa all’opera di riconcettualizzazione del mondo umano che, nella nuova prospettiva post-teologica, prendeva allora le mosse. Laddove in Machiavelli dominava l’idea della costitutiva storicità del mondo degli uomini, nella prospettiva galileiana era implicita la possibilità della riconduzione, senza residui, dell’indagine su tale mondo alle scienze naturali. Due punti di vista, questi, che avrebbero segnato la dialettica filosofica nei secoli a venire e che la segnano ancora oggi, in forma di cruciale spartiacque all’interno della più generale visione secolarizzata del mondo.
La nuova prospettiva antropologica di Machiavelli è bene illustrata da una celebre doppia analogia del Principe. Gli esseri umani sono come i centauri, per una parte razionali e per un’altra animali (ma in proposito va ricordato che la concezione machiavelliana della razionalità è modernamente incentrata sulla valutazione delle azioni in base al rapporto mezzi-fini, non sulle idealizzazioni angelicate che ne avevano date i neoplatonici fiorentini). La parte animale degli uomini, poi, è a sua volta bipartita: per metà implica l’astuzia della volpe e per l’altra metà la forza bruta del leone. Ma l’antropologia machiavelliana è zoomorfica solo metaforicamente, a suggerire l’ispirazione materialistica del quadro concettuale. Ciò che realmente conta è che tale antropologia si caratterizza come intrinsecamente storica. In questa prospettiva, la storia e solo la storia – intesa in un senso profondamente laico, depurato di ogni finalismo – permette di comprendere le invarianti dell’agire umano; più specificamente, soltanto lo studio dei concreti exempla del passato rende possibile individuare le leggi immutabili cui l’agire politico obbedisce. In questo senso, Machiavelli è all’origine di una concezione dell’umano che avrà grande fortuna.
Di assai diverso impianto, pur sullo sfondo di una comune ispirazione secolarizzante, è la concezione dell’umano che origina in Galileo. Per la “philosophia naturalis” dello scienziato pisano, infatti, l’ambito del reale si limita esclusivamente alle proprietà matematizzabili delle cose: ovvero alle loro dimensioni, alle loro forme, al moto, al numero. In questa prospettiva, come si legge nel Saggiatore, per investigare ciò che esiste è indispensabile “rimuovere” preliminarmente l’“animale” umano dal contesto dell’indagine. E ciò significa che il mondo dei colori, dei sapori, delle sensazioni – e, più in generale, il mondo di tutto ciò che è legato al punto di vista soggettivo – è costituito in realtà di puri “nomi”, di mere apparenze, e va dunque espunto dal novero di ciò che esiste e dunque anche dall’ambito del conoscibile. Come dirà poi Husserl, la concezione galileiana del mondo presuppone la deliberata rimozione del “mondo della vita”. Una rimozione che fu certo utile, anzi indispensabile, per i formidabili sviluppi successivi della scienza della natura; ma molto più controversa rispetto alle sue implicazioni per le future scienze dell’uomo e per la stessa filosofia.
Da una parte, dunque, si pone l’idea machiavelliana che la specificità dell’essere umano vada rintracciata nella sua storicità, nel suo essere un “animale storico”, per così dire. L’indagine sull’ambito umano, in questo quadro, non potrà che porsi da una prospettiva che privilegia la dimensione storica dell’esistenza. Dall’altra parte, si pone l’idea galileiana che nella natura umana non ci sia nulla di peculiare, che tutto ciò che a noi pare differenziarci dai corpi fisici sia in realtà illusorio e dunque vada ignorato. In questa prospettiva, le indagini sul mondo umano non potranno che informarsi allo spirito delle scienze naturali.
Riflessione intrinsecamente storica, secondo la prospettiva machiavelliana, oppure impresa contigua alla scienza naturale, secondo quella galileiana? Sono queste le opzioni principali che, secondo le indicazioni dei due nostri massimi pensatori, si aprono alla riflessione sul mondo umano una volta assunto come quadro concettuale di sfondo quello della secolarizzazione. Oggi, naturalmente, vi sono differenze intellettualmente rilevanti rispetto alla prima Modernità: lo strumentario scientifico, in particolare, è ora radicalmente diverso, sia per gli immensi progressi conseguiti negli ultimi secoli dalle scienze della natura sia per i contributi offerti dai nuovi ambiti delle scienze umane. Eppure non è difficile constatare che la dualità tra le prospettive con cui Machiavelli e Galilei concepirono rispettivamente lo studio del mondo umano si perpetua ancora oggi, e ciò anche in contesti culturali – come la filosofia anglosassone contemporanea – nei quali non sempre c’è piena consapevolezza delle radici storiche di tale contrapposizione. In questo senso, è particolarmente significativo mettere a confronto le opere più recenti di Daniel Dennett e di Bernard Williams, due tra i massimi esponenti di quel mondo filosofico.
Dennett oggi è forse il più noto promotore di una filosofia programmaticamente scientifica, che nella sua ispirazione ricorda chiaramente il positivismo ottocentesco e, andando più indietro, la concezione di ispirazione galileiana che investe la scienza naturale – e solo la scienza naturale – del compito di fornire una comprensione esaustiva del reale. Secondo la prospettiva dennettiana, dunque, la missione della filosofia è quella di “chiarire e unificare le prospettive spesso divergenti [delle scienze] in una singola visione dell’universo”. In questo quadro, Dennett ha operato molteplici tentativi di ricondurre nell’alveo delle scienze naturali i concetti fondamentali con cui la tradizione filosofica e le scienze umane hanno indagato la natura e la cultura dell’animale-uomo: dal concetto di coscienza a quello di intenzionalità, da quello di libero arbitrio a quello di responsabilità morale. La sua strategia, soprattutto negli ultimi anni, si incentra soprattutto sull’uso di categorie e forme di spiegazione tratte dalla teoria dell’evoluzione (ma senza ignorare gli apporti della neurofisiologia, dell’intelligenza artificiale, della genetica, della fisica).
In questo spirito, con il recente volume Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon (Viking, New York 2006), Dennett si è proposto di “naturalizzare” il fenomeno delle religioni. La sua tesi fondamentale è che i “sistemi sociali i cui membri credono in uno o più agenti soprannaturali di cui ricercano l’approvazione” possano essere adeguatamente comprese indagandone i vantaggi adattativi. In questa luce, per fare un esempio, Dennett congettura che il tasso di sopravvivenza dell’Homo sapiens fosse superiore a quello dei suoi cugini ominidi in forza dell’“effetto placebo” connesso alle pratiche degli sciamani: pratiche che solo un contesto religioso poteva rendere possibili. Le pratiche religiose, dunque, si perpetuarono perché offrivano un vantaggio evolutivo importante. E spiegazioni simili, secondo Dennett, possono essere offerte anche rispetto mondo religioso contemporaneo: la sua idea è che oggi i sistemi di credenze confessionali competano tra di loro nel tentativo di procurarsi il maggior numero di fedeli e il compito dello scienziato-filosofo sia quello di valutare quantitativamente le loro capacità di espansione. Solo le religioni più adeguate ai contesti sociali e culturali possono sopravvivere ed espandersi: e così, secondo Dennett, se ne possono spiegare la fortuna e il senso.
Un tale ragionamento, ovviamente, ignora le religioni che non cercano affatto di espandersi, come per esempio quella dei drusi che pure è sopravvissuta per centinaia di anni; ma non è questo il punto centrale. E neppure è interessante discutere se ricerche sociologico-culturali di impianto evoluzionistico come questa siano legittime: lo sono certamente, e in taluni casi esse possono anche essere illuminanti. Ciò che è importante determinare, però, è se tali ricerche possano dare esaustivamente conto della fenomenologia religiosa o perlomeno dei suoi aspetti più rilevanti, come ritiene Dennett (e un domanda analoga potrebbe riguardare i concetti filosofici che egli, con procedure analoghe, tenta di ricondurre alle categorie delle scienze naturali).
Per rispondere a questa domanda, è utile rivolgersi ad un’altra proposta filosofica: quella sviluppata da Bernard Williams in un importante volume uscito postumo, Philosophy as a Historical Discipline (Princeton University Press, Princeton 2006). Se Dennett concepisce l’indagine sul mondo umano in una chiave che potremmo definire neogalileiana, Williams si pone piuttosto da una prospettiva che ricorda quella, caratterizzata dalla centralità filosofica della storia, propria di Machiavelli. Ciò che rende questo volume di particolare interesse è che Williams proviene da un ambiente culturale tradizionalmente alieno dalle prospettive storiche a ovvero la filosofia analitica (della quale egli è stato uno dei maggiori interpreti). Questa origine, peraltro, fa sì che Williams non compia il passo teoreticamente arrischiato – non raro in altri contesti filosofici – di far seguire alla critica di concezioni del genere di quella di Dennett l’adesione a forme estreme di relativismo o di irrazionalismo. Williams non nega affatto che sia legittimo porre alla scienza l’obiettivo di offrire una visione complessiva, unitaria e definitiva del mondo naturale (ciò che Williams chiama la “concezione assoluta del mondo”). Ciò che è errato, tuttavia, è ritenere che, siccome tale aspirazione è legittima, allora tutte le forme di comprensione della realtà debbano essere riconducibili, almeno idealmente, alle scienze della natura.
In realtà, sostiene Williams, non c’è ragione di credere che il mondo umano possa essere compreso soltanto con le modalità delle scienze naturali, per esempio con lo strumentario della teoria dell’evoluzione. Così, ciò che una spiegazione in termini evolutivi può riuscire a fare è soltanto di dare conto della capacità peculiarmente umana di elaborare pratiche culturali: ma essa non può spiegare senso, contenuto e natura di tali pratiche. Scrive Williams: “È proprio il fatto che le variazioni e gli sviluppi delle pratiche culturali non sono determinate a livello evolutivo che fa sì che la caratteristica umana di vivere all’interno della cultura produca un successo evolutivo così straordinario”. Se è così, analisi come quella che Dennett offre dei fenomeni religiosi tutt’al più possono aiutare a comprendere la capacità umana di produrre le pratiche del culto, ma non possono esaurire il significato delle pratiche medesime.
Ma qual è allora, in questa prospettiva, il compito della filosofia? La risposta di Williams è che – a parte casi peculiari del tutto legittimi, come per esempio quando essa si occupa dei fondamenti delle discipline scientifiche, quali la meccanica quantistica o la stessa teoria dell’evoluzione – la filosofia è parte di una più generale impresa umanistica, che ha come obiettivo l’autocomprensione. E a questa impresa la filosofia può contribuire sia con un’opera di chiarificazione concettuale sia, soprattutto, dando conto dell’irriducibile contingenza che informa le categorie e i valori delle nostre concezioni etico-politiche. Le idee e i valori che ci appaiono corretti in ambito pratico, infatti, sono innegabilmente un lascito in qualche misura accidentale del nostro passato: se tale passato fosse stato diverso, le nostre opinioni etico-politiche, e più in generale la nostra cultura, avrebbero potuto essere diverse (come prova il fatto che altre epoche e altre comunità hanno valori e concezioni diversi dai nostri). In ragione di questa ineliminabile contingenza storica, il tentativo – proprio di molte concezioni filosofiche – di dedurre a priori un insieme di tesi valide universalmente non potrà mai esaurire il compito della filosofia; né potrà farlo, come si è detto, uno studio puramente empirico dei fenomeni culturali. Nel vagliare le pretese di universalità della nostra cultura, allora, la filosofia non può ignorarne la genesi contingente. È per questa ragione che la filosofia è intimamente legata alla storia: “la comprensione riflessiva delle nostre idee e delle nostre motivazioni, che mi pare sia universalmente considerata come un obiettivo della filosofia”, scrive Williams, “implica la comprensione storica”. Il vecchio Niccolò ne sarebbe stato contento.
Mario De Caro
Pubblicato su Il Manifesto del 4 ottobre 2006, p.12
SCHEDA.
Nella prima parte del Novecento, i filosofi più influenti nel mondo anglosassone (da Frege a Wittgenstein, da Moore a Carnap) hanno disdegnato ogni contaminazione della loro riflessione tanto con la storia quanto quelle con la scienza. Quest’epoca sembra ormai tramontata e oggi, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, un robusto schieramento di filosofi filo-scientifici si contrappone a una meno numerosa, ma non meno vivace, falange di filosofi attenti alla dimensione storica dei problemi. Nel primo gruppo si segnalano, oltre a Daniel Dennett (del quale si vedano anche L’evoluzione della libertà, Cortina, Milano 2004, e Sweet Dreams. Illusioni filosofiche sulla coscienza, Cortina, Milano 2006, rispettivamente dedicati ai tentativi di naturalizzare il libero arbitrio e la coscienza), Jerry Fodor (del quale si veda Mente e linguaggio, Laterza, Roma-Bari 2001) e Paul Churchland (Il motore della ragione, la sede dell’anima, Il Saggiatore, Milano 1998).
Del filone filo-storico fanno invece parte, oltre a Williams, Hilary Putnam (Ragione, verità e storia, Il Saggiatore, Milano 1994) e Robert Brandom (Tales of the Mighty Dead, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2002).