| Segnala il documento | Contributo | Stampa | |||
| Link |
| Il mestiere del filosofo (sull'orlo delle neuroscienze) |
| di Maurizio Meloni |
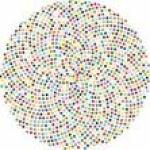
Non è una novità, nella storia della filosofia, che fasi di profonda trasformazione sul piano delle scienze tocchino con più o meno forza l’immagine e lo statuto disciplinare della pratica filosofica, rimettendo prepotentemente in discussione le distinzioni categoriali, ma anche più prosaicamente dipartimentali, su cui poggia il discorso filosofico. Oggi certamente viviamo una di quelle fasi calde, in cui i confini tra quello che consideriamo scienza e filosofia si fanno più magmatici, addirittura fluidi. Scienze biologiche, neuroscienze, scienze cognitive e psicologia evoluzionistica hanno avviato – sovente sotto le bandiere di un aggressivo neo-naturalismo - un vasto programma di ricerca mirante a far saltare la demarcazione netta tra uomo e regno del vivente, natura e tecnica, processi bio-chimici e Geist, neuroni ed etica, sferrando un colpo quasi mortale alla venerata distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito. Si tratta di un vero e proprio Spirito del Tempo ben rappresentato in alcune opere contemporanee di Damien Hirst, che - ad esempio con le sue mosche in formalina - propone un'eccellente metafora di quel riassorbimento dell'elemento culturale nel naturale (anche l'arte diventa un pezzo di natura!) a cui il neo-naturalismo in ultima analisi mira.
Volendo misurare che impatto abbia avuto questa temperie culturale sull’immagine stessa del discorso filosofico, quanto in profondità esso ne sia stato modificato, ci basti accennare alla distanza che passa tra la lapidaria sentenza heideggeriana secondo cui “la scienza non pensa” e la necessità avvertita oggi da un filosofo come Daniel Dennett di aprire uno dei suoi lavori recenti con l’espressione: “Sono un filosofo, non uno scienziato” (Kinds of Minds, Basic Books, New York 1996), data l’esigenza di districarsi in quella confusione tra confini della scienza e della filosofia che forse dai tempi di Kant sembrava risolta e accantonata, una volta per tutte. (Ma ulteriore testimonianza potrebbe essere data dal proliferare di filosofie della biologia, della fisica, della psicologia…). E’ l’impatto sul mestiere di filosofo di quelle che sono state chiamate “Tecnoscienze Umane” (De Carolis, ad esempio(1)), quella famiglia cioè di “discipline e programmi di ricerca che, pur mantenendo la stretta correlazione tra scienza e tecnica tipica delle scienze naturali, si rivolgono sistematicamente a un oggetto riservato un tempo alle sole scienze umane” . Delle Tecnoscienze Umane certamente oggi la regina sono le neuroscienze, soprattutto quando si riconnettono al lavoro svolto in questi ultimi anni dalle scienze cognitive, per la semplice ragione che esse ripercorrono – dal proprio punto di vista e con il proprio vocabolario (oltre che con la propria tecnologia) – le interrogazioni più intime che hanno fatto la trama della filosofia stessa, come la abbiamo conosciuta nei secoli: la mente, la coscienza, il libero arbitrio, le emozioni, la natura del pensiero, tutte questioni oggi soggette a un ripensamento nel quadro di un ideale epistemologico di piena dispiegabilità e addirittura rappresentabilità, grazie alle varie tecniche di PET (tomografia ad emissione di positroni) o fMRI (risonanza magnetica funzionale), usate dai neuroscienziati per visualizzare l’attività cerebrale (2) . I leaders della ricerca in neuroscienze sono inoltre del tutto consapevoli di questo conflitto tra vocabolari e dell’invasione di campo operata sulle tradizionali questioni di monopolio umanistico, quando esplicitamente attaccano la povertà di risultati che la filosofia avrebbe ottenuto in secoli di ricerca a confronto di quelli realizzati in pochi decenni dalle neuroscienze. In Bright Air, Brilliant Fire (Penguin, Harmondswerth 1994), ad esempio, Gerald Edelman ha scritto che: “One of the temptations of having a mind is to try to use it alone to solve the mystery of its own nature. Philosophers have attempted this since time immemorial … As a general method to explore the matter of mind, it just won’t do” (p.31). Oppure nel suo The Astonishing Hypothesis (Touchstone, London 1995), ancor più polemicamente Francis Crick ha dichiarato che: “Philosophers have had such a poor record over the last two thousand years that they would do better to show a certain modesty rather than the lofty superiority that they usually display” (p. 258); e sempre di “poverty of results of philosophy” ha parlato, in “Splendours and miseries of the brain”, S. Zeky aggiungendo: “the problems that neurobiology will face in the future are those lasting truths and ultimate values which philosophy (…) has so unsuccessfully tackled in the past” (in Philosophical Transactions of the Royal Society 1999, pp. 2053-2065).
Insomma le neuroscienze sono spesso “inclini a pensare di poter risolvere problemi con i quali i filosofi sono in lotta da secoli”. Molte di queste citazioni – compresa quest’ultima - sono tratte dal volume di M. R. Bennett, P. M. S. Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience, Blackwell, Oxford 2003, un’opera ambiziosa e controcorrente di oltre 450 pagine, consacrata a una raffinata critica filosofica del linguaggio delle scienze della mente contemporanee, capace di passare in rassegna gli sviluppi storici delle neuroscienze (da Sherrington a Eccles, Penfield, all’attuale terza generazione), tutte le principali questioni del momento (coscienza, qualia, problema mente-corpo, sensazioni e percezioni, poteri cognitivi, emozioni, volontà), oltre a quelle più squisitamente metodologiche (la terza parte, forse la più ricca del libro), con appendici conclusive dedicate alla critica di due delle maggiori figure che si contendono il campo della filosofia della mente contemporanea, ovvero J. R. Searle e Daniel Dennett. Anche qui, come nel caso dell’importante lavoro di Rizzolatti & Sinigaglia (So quel che fai, Cortina, Milano 2006) uscito in Italia quest’anno abbiamo una collaborazione tra un neuroscienziato, M. R. Bennett (dell’Università di Sidney), e un filosofo, P. M. S. Hacker, Fellow al St John’s College di Oxford e molto noto anche da noi per essere uno dei massimi interpreti contemporanei di Wittgenstein. Tuttavia, diversamente dal volume di Rizzolatti & Sinigaglia, qui la posizione che il filosofo assume davanti alle neuroscienze non è quella di saggio consulente che indica punti di contatto e percorsi possibili, accompagnando le potenzialità filosofiche della ricerca neuroscientifica, quanto piuttosto quella di implacabile critico delle confusioni concettuali in cui le neuroscienze sarebbero irrimediabilmente smarrite.
La tesi di fondo del libro, detta in una parola, è che le neuroscienze contemporanee sono concettualmente imbrigliate nell’onda lunga delle confusioni cartesiane, con la sola differenza – che costituisce forse addirittura un’aggravante! - di aver trasferito al cervello, oggetto dell’interesse neuroscientifico, le proprietà che Cartesio attribuiva alla mente. Insomma, se per Cartesio era le mente che pensava, sentiva, decideva, ora per le neuroscienze – vera e propria forma di cartesianesimo secolarizzato - è il cervello (o peggio ancora parti di esso!) a diventare il portatore delle proprietà psicologiche.
E’ il cuore concettuale del libro, oggetto del terzo capitolo in particolare, ma vera chiave di interpretazione dell’intero vocabolario neuroscientifico (ma un maligno direbbe: l’unico argomento spalmato per oltre 400 pagine), ovvero la questione della Fallacia Mereologica (dove per mereologia si intende lo studio delle relazioni tra le parti e il tutto). La Fallacia Mereologica, scrivono gli autori, “consists in ascribing to a part of a creature attributes which logically can be ascribed only to the creature as a whole. The particular form which this mereological fallacy took in Descartes consisted in ascribing to the soul attributes which can be ascribed only to the whole animal” (p.29). Con lo spostamento da mente a cervello tuttavia le confusioni concettuali finiscono solo col cambiare di aspetto. Quando infatti la terza generazione di neuroscienziati (le neuroscienze cosiddette post-Sherringtoniane) ha attribuito al cervello, o a sue parti, le proprietà psicologiche (Crick: “what your brain believes”; Edelman: structures within the brain that “categorize, discriminate, and recombine…..”; Damasio “our brains can often decide well”; Gazzaniga: “The Ethical Brain”; altri: “there are symbols in the brain”) non avrebbe fatto altro che impantanarsi ulteriormente nel pasticcio cartesiano, estendendo all’inverosimile la fallacia mereologica.
Come risultato di questa “unthinking adherence to a mutant form of Cartesianism” (p.72) – vero spettro che si aggirerebbe nella machine del raffinato vocabolario neuroscientifico – le neuroscienze finirebbero col portare implicitamente acqua a una antropologia che fraziona irrimediabilmente quell’unità che è l’uomo vivente: un paradigma avente origine in Platone, pieno sviluppo con Cartesio e oggi al culmine con la mente neurocognitiva (ma si noti qui en passant che in una certa letteratura “genocentrica”, il gene diviene portatore di analoghe qualità psicologiche - il gene che istruisce, trasmette un messaggio, commette errori… il gene strappa-applausi lo chiamerebbe J. Horgan - e suscettibile dunque di analoga critica ‘mereologica’). Mentre il paradigma alternativo disponibile sarebbe cominciato con Aristotele per trovare una sua chiarificazione definitiva nel § 281 delle Ricerche Filosofiche, sotto la cui bandiera l’intero libro di Bennett & Hacker sta: “…soltanto dell’uomo vivente, e di ciò che gli somiglia (che si comporta in modo simile) si può dire che abbia sensazioni, che veda, che sia cieco, che oda, che sia sordo; che sia in sé o che non sia cosciente”(3) .
Al di là della critica talvolta un po’ ripetitiva alle neuroscienze (ree di leso wittgensteinianesimo), questo libro, e il dibattito che si è svolto alla fine e che qui proponiamo ai lettori, risulta di grande interesse perché fa emergere in filigrana (soprattutto se confrontato con il commento operato da Daniel Dennett) la pluralità di atteggiamenti possibili che il filosofo può oggi assumere davanti alla sfida avanzata dalle scienze della mente.
Da una parte abbiamo infatti un segmento molto rilevante della filosofia contemporanea (analitica in gran misura) che ha aderito in pieno alla svolta naturalistica e naturalizzatrice trasformandosi talvolta in una vera e propria “estensione della scienza”, sua ancella, secondo una modalità che ha fatto scrivere a H. Putnam di “un clima filosofico di generale deferenza verso la presunta rilevanza metafisica della scienza”. E’ anche la nascita (meglio: la rinascita) di un genere letterario-filosofico di tipo scientizzante (scientosofia o neuro-filosofia come nel caso di P. Churchland) di cui non si può fare a meno di vedere come esso inclini all’idea di sbarazzarsi definitivamente ("to quine" per parafrasare il neologismo che Dennett ha coniato in omaggio a W. V. O. Quine a proposito dei qualia, gli stati soggettivi di coscienza, il cosa si prova ad essere un certo tipo di essere, di cui Dennett non vuol sentir parlare) di qualcosa come la filosofia stessa, oramai resa obsoleta, a meno che essa non accetti di uniformarsi, anche professionalmente, alle regole più o meno esplicite che governano la comunità scientifica, al suo linguaggio e al suo specialismo (col prezzo tuttavia che l’unica filosofia buona diventerebbe quella che progressivamente cessa di volersi come disciplina distinta, quella morta in un certo senso) (4).
Dall’altra – ed è il caso della battaglia che da anni Hacker conduce (si veda l’attacco a Quine “l’Apostata” nel suo Wittgenstein’s Place in the 20th Century Analytic Philosophy Blackwell, Oxford 1996) su posizioni in questo caso wittgensteiniane (ma equivalenti si possono trovare all’interno di approcci ermeneutici, normativi, neo-hegeliani) - c’è la riproposizione del fatto che lo spazio della filosofia come disciplina a priori rimanga inaccessibile ai risultati delle singole scienze; che nessuna seria ferita narcisistica possa essere apportata da queste ultime alla filosofia intesa come conoscenza prima delle questioni grammaticali, linguistiche, concettuali, normative che ad ogni ondata di scoperte le singole scienze depositano sulla spiaggia del filosofo come rottami da dividere, selezionare, riparare. Il filosofo è lì che attende e sa che nessuna marea sommergerà davvero la sua insenatura filosofica, originale e sui generis. “The root of the trouble - scrivono esemplarmente Bennett & Hacker a proposito della ricerca neuroscientifica - is conceptual confusion, not empirical ignorance” (p.47), ovvero: “The relevant connections are logical or conceptual – and neuroscientific investigations can shed no light upon the normative connections of logic” (406), e proprio quello sarebbe lo spazio inviolabile della ragioni (per parlare con McDowell) che assicurerà un lavoro ai filosofi anche nel futuro, soprattutto se NON si uniformeranno al linguaggio della scienza.
Il dibattito che qui proponiamo (insieme ad alcune recensioni del libro di Bennett & Hacker) risulta particolarmente importante nell’evidenziare la contrapposizione tra questi due modelli alternativi di filosofia. Senza anticipare la lettura, tuttavia, il primo testo - “Philosophy as Naive Anthropology”, ovvero il commento a Philosophical Foundations of Neuroscience che Dennett ha letto all’ APA Eastern Division Meeting nel Dicembre del 2005 - merita qualche piccola annotazione, data l’importanza storiografica che esso assume nel contrapporre i due paradigmi di filosofia. Dennett è chiaramente il nemico filosofico principale del testo di Bennett & Hacker, oltre che oggetto della Appendice 1 del libro che si estende dalle pagine 413 a 435 (mentre più misurata è la critica a John Searle, argomento della seconda appendice del testo). Oltre alla contrapposizione tra immagini contemporanee del fare filosofia davanti alla scienza, e al carattere meritoriamente franco e colorito della polemica (quando Hacker mi rimprovera di non capire la fallacia mereologica, scrive Dennett con uno stile che non farebbe male anche ai paludati dibattiti di casa nostra, “this is a case of teaching your grandmother to suck eggs”, p. 4), il testo di Dennett ha anche un particolare valore autobiografico. E’ chiaro infatti che, in modo più o meno strisciante nell’Appendice, Hacker accusa Dennett di aver tradito l’eredità dei “gloriosi tempi della Ordinary Language Philosophy” che Dennett apprese a Oxford negli anni 60 sotto la guida di Ryle. “I myself am a product of that time and place” conferma Dennett a pagina 1 del Comment, per chiedersi poi ironicamente a pagina 4: “Did I perhaps lose my way, when I left Oxford?”.
Sul piano del merito, nel commento Dennett si rivela implacabile sia nel contrapporre un’altra lettura della critica wittgensteiniana alla fallacia mereologica (citando un suo vecchio brano da Content and Consciousness, p. 95-96, dirà che: “The lesson [of Ryle and Wittgenstein, NdR] has occasionally been misconstrued, however, as the lesson that the personal level of explanation is the only level of explanation when the subject matter is human minds and actions”), sia nel rivendicare l’importanza del livello empirico su quello concettuale: “Even if conceptual questions do “antecede” matters of truth and falsity, it might well behoove anybody who wanted to get clear about what the good answers are to investigate the relevant scientific inquiries assiduously. This proposal, which Hacker identifies as Quinian naturalism, he dismisses with an irrelevancy: “we do not think that empirical research can solve any philosophical problems, any more than it can solve problems in mathematics.” (B&H;, p414) Well of course not; empirical research doesn’t solve them, it informs them and sometimes adjusts or revises them, and then they sometimes dissolve, and sometimes they can then be solved by further philosophical reflection. Hacker’s insistence that philosophy is an a priori discipline that has no continuity with empirical science is the chief source of the problems bedeviling this project” (Comment, p. 7).
La grammatica a cui Hacker tenterebbe di fissare l’autonomia non riducibile della “filosofia prima” (secondo un’attitudine che non nasce a Oxford, e in questo concordano Hacker e Dennett, ma con Socrate) non starebbe però in piedi per Dennett: “The conviction that this method of consulting one’s (grammatical or other) intuitions is entirely distinct from empirical inquiry has a long pedigree (going back not just to the Oxford of the 1960s, but to Socrates) but it does not survive reflection.” (Comment, p. 8). L’attacco di Dennett, che coinvolge anche il suo maestro Ryle, è frontale, ed è in sostanza l’attacco al paradigma della svolta linguistica che ha dominato la filosofia del dopoguerra fino all’avvento della svolta naturalistico-mentalistico-biologistica, se così si può dire, verso cui autori come Dennett e Searle (ma non Hacker), seppur in forme tra di loro antagoniste, hanno fatto decisamente rotta (5) : “It is long past time to call a halt to this sort of philosophical pretense” - scrive Dennett. “Ryle notoriously claimed to identify ‘category mistakes’ by appeal to the ‘logic’ of existence claims, but let’s face it: that was a bluff. He had no articulated logic of existence terms to back up his claims. In spite of the popularity of such talk, from Ryle and Wittgenstein and a host of imitators, no philosopher has ever articulated ‘the rules’ for the use of any ordinary expression.” (p.9). Per concludere perentoriamente con una campana a morto per la buona vecchia Linguistic Turn che rivela quanto sia oggi ampia la scissione dentro il campo che proviene dal mondo analitico: “Since Hacker’s philosophical problems are becoming obsolete, I suppose we might just sweep them under the carpet, though I’d prefer to give them a proper burial.” (p. 13).
___________________________________
Note
(1) M. De Carolis, La vita nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Bollati Boringhieri, Torino 2004
(2)Tecnologie che concorrono a determinare, come è stato ben scritto, una vera e propria “modifica profonda della figurabilità dello spazio antropico” (C. Ossola, Relazione di C. Ossola al convegno “Humanitas. Il paradigma di natura umana tra scienza e filosofia” organizzato da CNR e Istituto italiano di scienze umane, Firenze, luglio 2004).
(3) Tuttavia, per una interpretazione meno rigida della tesi di Wittgenstein e per una comprensione della Fallacia mereologica in termini di – del tutto legittima! – metonimia, si veda la recensione critica al volume di Bennett & Hacker avanzata da P. Machamer & J. Sytsma, “Neuroscienze e natura della filosofia”, Iride, XVIII, n. 46, pp. 495-514
(4) Vedi ad esempio le considerazioni nell’Introduzione e nel saggio di F. D’Agostini, “Che cos’è la Filosofia analitica?”, in Storia della Filosofia analitica, a cura di F. D’Agostini e N. Vassallo, Einaudi, Torino 2002
(5) Anzi Searle in un certo senso rappresenta un’evoluzione ancora più marcata da un paradigma linguistico a uno che vede nella biologia il fondamento ultimo, anche del linguaggio. Si veda il suo recente intervento per il conseguimento del Premio Mente e Cervello, edizione 2006, all’Università di Torino: “trovo grave che i filosofi del linguaggio non considerino il linguaggio come un fenomeno naturale (…) è raro che trattino il proprio oggetto come un’estensione naturale di capacità biologiche non linguistiche, di un’eredità biologica specificamente umana.” Analogamente nel suo ultimo lavoro La mente aveva parlato dei problemi del linguaggio come “casi speciali dei problemi relativi alla mente. Il nostro uso del linguaggio è l’espressione di capacità mentali più fondamentali dal punto di vista biologico” (J. Searle, La mente, Cortina, Milano 2005, pp. 10-11)
Volendo misurare che impatto abbia avuto questa temperie culturale sull’immagine stessa del discorso filosofico, quanto in profondità esso ne sia stato modificato, ci basti accennare alla distanza che passa tra la lapidaria sentenza heideggeriana secondo cui “la scienza non pensa” e la necessità avvertita oggi da un filosofo come Daniel Dennett di aprire uno dei suoi lavori recenti con l’espressione: “Sono un filosofo, non uno scienziato” (Kinds of Minds, Basic Books, New York 1996), data l’esigenza di districarsi in quella confusione tra confini della scienza e della filosofia che forse dai tempi di Kant sembrava risolta e accantonata, una volta per tutte. (Ma ulteriore testimonianza potrebbe essere data dal proliferare di filosofie della biologia, della fisica, della psicologia…). E’ l’impatto sul mestiere di filosofo di quelle che sono state chiamate “Tecnoscienze Umane” (De Carolis, ad esempio(1)), quella famiglia cioè di “discipline e programmi di ricerca che, pur mantenendo la stretta correlazione tra scienza e tecnica tipica delle scienze naturali, si rivolgono sistematicamente a un oggetto riservato un tempo alle sole scienze umane” . Delle Tecnoscienze Umane certamente oggi la regina sono le neuroscienze, soprattutto quando si riconnettono al lavoro svolto in questi ultimi anni dalle scienze cognitive, per la semplice ragione che esse ripercorrono – dal proprio punto di vista e con il proprio vocabolario (oltre che con la propria tecnologia) – le interrogazioni più intime che hanno fatto la trama della filosofia stessa, come la abbiamo conosciuta nei secoli: la mente, la coscienza, il libero arbitrio, le emozioni, la natura del pensiero, tutte questioni oggi soggette a un ripensamento nel quadro di un ideale epistemologico di piena dispiegabilità e addirittura rappresentabilità, grazie alle varie tecniche di PET (tomografia ad emissione di positroni) o fMRI (risonanza magnetica funzionale), usate dai neuroscienziati per visualizzare l’attività cerebrale (2) . I leaders della ricerca in neuroscienze sono inoltre del tutto consapevoli di questo conflitto tra vocabolari e dell’invasione di campo operata sulle tradizionali questioni di monopolio umanistico, quando esplicitamente attaccano la povertà di risultati che la filosofia avrebbe ottenuto in secoli di ricerca a confronto di quelli realizzati in pochi decenni dalle neuroscienze. In Bright Air, Brilliant Fire (Penguin, Harmondswerth 1994), ad esempio, Gerald Edelman ha scritto che: “One of the temptations of having a mind is to try to use it alone to solve the mystery of its own nature. Philosophers have attempted this since time immemorial … As a general method to explore the matter of mind, it just won’t do” (p.31). Oppure nel suo The Astonishing Hypothesis (Touchstone, London 1995), ancor più polemicamente Francis Crick ha dichiarato che: “Philosophers have had such a poor record over the last two thousand years that they would do better to show a certain modesty rather than the lofty superiority that they usually display” (p. 258); e sempre di “poverty of results of philosophy” ha parlato, in “Splendours and miseries of the brain”, S. Zeky aggiungendo: “the problems that neurobiology will face in the future are those lasting truths and ultimate values which philosophy (…) has so unsuccessfully tackled in the past” (in Philosophical Transactions of the Royal Society 1999, pp. 2053-2065).
Insomma le neuroscienze sono spesso “inclini a pensare di poter risolvere problemi con i quali i filosofi sono in lotta da secoli”. Molte di queste citazioni – compresa quest’ultima - sono tratte dal volume di M. R. Bennett, P. M. S. Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience, Blackwell, Oxford 2003, un’opera ambiziosa e controcorrente di oltre 450 pagine, consacrata a una raffinata critica filosofica del linguaggio delle scienze della mente contemporanee, capace di passare in rassegna gli sviluppi storici delle neuroscienze (da Sherrington a Eccles, Penfield, all’attuale terza generazione), tutte le principali questioni del momento (coscienza, qualia, problema mente-corpo, sensazioni e percezioni, poteri cognitivi, emozioni, volontà), oltre a quelle più squisitamente metodologiche (la terza parte, forse la più ricca del libro), con appendici conclusive dedicate alla critica di due delle maggiori figure che si contendono il campo della filosofia della mente contemporanea, ovvero J. R. Searle e Daniel Dennett. Anche qui, come nel caso dell’importante lavoro di Rizzolatti & Sinigaglia (So quel che fai, Cortina, Milano 2006) uscito in Italia quest’anno abbiamo una collaborazione tra un neuroscienziato, M. R. Bennett (dell’Università di Sidney), e un filosofo, P. M. S. Hacker, Fellow al St John’s College di Oxford e molto noto anche da noi per essere uno dei massimi interpreti contemporanei di Wittgenstein. Tuttavia, diversamente dal volume di Rizzolatti & Sinigaglia, qui la posizione che il filosofo assume davanti alle neuroscienze non è quella di saggio consulente che indica punti di contatto e percorsi possibili, accompagnando le potenzialità filosofiche della ricerca neuroscientifica, quanto piuttosto quella di implacabile critico delle confusioni concettuali in cui le neuroscienze sarebbero irrimediabilmente smarrite.
La tesi di fondo del libro, detta in una parola, è che le neuroscienze contemporanee sono concettualmente imbrigliate nell’onda lunga delle confusioni cartesiane, con la sola differenza – che costituisce forse addirittura un’aggravante! - di aver trasferito al cervello, oggetto dell’interesse neuroscientifico, le proprietà che Cartesio attribuiva alla mente. Insomma, se per Cartesio era le mente che pensava, sentiva, decideva, ora per le neuroscienze – vera e propria forma di cartesianesimo secolarizzato - è il cervello (o peggio ancora parti di esso!) a diventare il portatore delle proprietà psicologiche.
E’ il cuore concettuale del libro, oggetto del terzo capitolo in particolare, ma vera chiave di interpretazione dell’intero vocabolario neuroscientifico (ma un maligno direbbe: l’unico argomento spalmato per oltre 400 pagine), ovvero la questione della Fallacia Mereologica (dove per mereologia si intende lo studio delle relazioni tra le parti e il tutto). La Fallacia Mereologica, scrivono gli autori, “consists in ascribing to a part of a creature attributes which logically can be ascribed only to the creature as a whole. The particular form which this mereological fallacy took in Descartes consisted in ascribing to the soul attributes which can be ascribed only to the whole animal” (p.29). Con lo spostamento da mente a cervello tuttavia le confusioni concettuali finiscono solo col cambiare di aspetto. Quando infatti la terza generazione di neuroscienziati (le neuroscienze cosiddette post-Sherringtoniane) ha attribuito al cervello, o a sue parti, le proprietà psicologiche (Crick: “what your brain believes”; Edelman: structures within the brain that “categorize, discriminate, and recombine…..”; Damasio “our brains can often decide well”; Gazzaniga: “The Ethical Brain”; altri: “there are symbols in the brain”) non avrebbe fatto altro che impantanarsi ulteriormente nel pasticcio cartesiano, estendendo all’inverosimile la fallacia mereologica.
Come risultato di questa “unthinking adherence to a mutant form of Cartesianism” (p.72) – vero spettro che si aggirerebbe nella machine del raffinato vocabolario neuroscientifico – le neuroscienze finirebbero col portare implicitamente acqua a una antropologia che fraziona irrimediabilmente quell’unità che è l’uomo vivente: un paradigma avente origine in Platone, pieno sviluppo con Cartesio e oggi al culmine con la mente neurocognitiva (ma si noti qui en passant che in una certa letteratura “genocentrica”, il gene diviene portatore di analoghe qualità psicologiche - il gene che istruisce, trasmette un messaggio, commette errori… il gene strappa-applausi lo chiamerebbe J. Horgan - e suscettibile dunque di analoga critica ‘mereologica’). Mentre il paradigma alternativo disponibile sarebbe cominciato con Aristotele per trovare una sua chiarificazione definitiva nel § 281 delle Ricerche Filosofiche, sotto la cui bandiera l’intero libro di Bennett & Hacker sta: “…soltanto dell’uomo vivente, e di ciò che gli somiglia (che si comporta in modo simile) si può dire che abbia sensazioni, che veda, che sia cieco, che oda, che sia sordo; che sia in sé o che non sia cosciente”(3) .
Al di là della critica talvolta un po’ ripetitiva alle neuroscienze (ree di leso wittgensteinianesimo), questo libro, e il dibattito che si è svolto alla fine e che qui proponiamo ai lettori, risulta di grande interesse perché fa emergere in filigrana (soprattutto se confrontato con il commento operato da Daniel Dennett) la pluralità di atteggiamenti possibili che il filosofo può oggi assumere davanti alla sfida avanzata dalle scienze della mente.
Da una parte abbiamo infatti un segmento molto rilevante della filosofia contemporanea (analitica in gran misura) che ha aderito in pieno alla svolta naturalistica e naturalizzatrice trasformandosi talvolta in una vera e propria “estensione della scienza”, sua ancella, secondo una modalità che ha fatto scrivere a H. Putnam di “un clima filosofico di generale deferenza verso la presunta rilevanza metafisica della scienza”. E’ anche la nascita (meglio: la rinascita) di un genere letterario-filosofico di tipo scientizzante (scientosofia o neuro-filosofia come nel caso di P. Churchland) di cui non si può fare a meno di vedere come esso inclini all’idea di sbarazzarsi definitivamente ("to quine" per parafrasare il neologismo che Dennett ha coniato in omaggio a W. V. O. Quine a proposito dei qualia, gli stati soggettivi di coscienza, il cosa si prova ad essere un certo tipo di essere, di cui Dennett non vuol sentir parlare) di qualcosa come la filosofia stessa, oramai resa obsoleta, a meno che essa non accetti di uniformarsi, anche professionalmente, alle regole più o meno esplicite che governano la comunità scientifica, al suo linguaggio e al suo specialismo (col prezzo tuttavia che l’unica filosofia buona diventerebbe quella che progressivamente cessa di volersi come disciplina distinta, quella morta in un certo senso) (4).
Dall’altra – ed è il caso della battaglia che da anni Hacker conduce (si veda l’attacco a Quine “l’Apostata” nel suo Wittgenstein’s Place in the 20th Century Analytic Philosophy Blackwell, Oxford 1996) su posizioni in questo caso wittgensteiniane (ma equivalenti si possono trovare all’interno di approcci ermeneutici, normativi, neo-hegeliani) - c’è la riproposizione del fatto che lo spazio della filosofia come disciplina a priori rimanga inaccessibile ai risultati delle singole scienze; che nessuna seria ferita narcisistica possa essere apportata da queste ultime alla filosofia intesa come conoscenza prima delle questioni grammaticali, linguistiche, concettuali, normative che ad ogni ondata di scoperte le singole scienze depositano sulla spiaggia del filosofo come rottami da dividere, selezionare, riparare. Il filosofo è lì che attende e sa che nessuna marea sommergerà davvero la sua insenatura filosofica, originale e sui generis. “The root of the trouble - scrivono esemplarmente Bennett & Hacker a proposito della ricerca neuroscientifica - is conceptual confusion, not empirical ignorance” (p.47), ovvero: “The relevant connections are logical or conceptual – and neuroscientific investigations can shed no light upon the normative connections of logic” (406), e proprio quello sarebbe lo spazio inviolabile della ragioni (per parlare con McDowell) che assicurerà un lavoro ai filosofi anche nel futuro, soprattutto se NON si uniformeranno al linguaggio della scienza.
Il dibattito che qui proponiamo (insieme ad alcune recensioni del libro di Bennett & Hacker) risulta particolarmente importante nell’evidenziare la contrapposizione tra questi due modelli alternativi di filosofia. Senza anticipare la lettura, tuttavia, il primo testo - “Philosophy as Naive Anthropology”, ovvero il commento a Philosophical Foundations of Neuroscience che Dennett ha letto all’ APA Eastern Division Meeting nel Dicembre del 2005 - merita qualche piccola annotazione, data l’importanza storiografica che esso assume nel contrapporre i due paradigmi di filosofia. Dennett è chiaramente il nemico filosofico principale del testo di Bennett & Hacker, oltre che oggetto della Appendice 1 del libro che si estende dalle pagine 413 a 435 (mentre più misurata è la critica a John Searle, argomento della seconda appendice del testo). Oltre alla contrapposizione tra immagini contemporanee del fare filosofia davanti alla scienza, e al carattere meritoriamente franco e colorito della polemica (quando Hacker mi rimprovera di non capire la fallacia mereologica, scrive Dennett con uno stile che non farebbe male anche ai paludati dibattiti di casa nostra, “this is a case of teaching your grandmother to suck eggs”, p. 4), il testo di Dennett ha anche un particolare valore autobiografico. E’ chiaro infatti che, in modo più o meno strisciante nell’Appendice, Hacker accusa Dennett di aver tradito l’eredità dei “gloriosi tempi della Ordinary Language Philosophy” che Dennett apprese a Oxford negli anni 60 sotto la guida di Ryle. “I myself am a product of that time and place” conferma Dennett a pagina 1 del Comment, per chiedersi poi ironicamente a pagina 4: “Did I perhaps lose my way, when I left Oxford?”.
Sul piano del merito, nel commento Dennett si rivela implacabile sia nel contrapporre un’altra lettura della critica wittgensteiniana alla fallacia mereologica (citando un suo vecchio brano da Content and Consciousness, p. 95-96, dirà che: “The lesson [of Ryle and Wittgenstein, NdR] has occasionally been misconstrued, however, as the lesson that the personal level of explanation is the only level of explanation when the subject matter is human minds and actions”), sia nel rivendicare l’importanza del livello empirico su quello concettuale: “Even if conceptual questions do “antecede” matters of truth and falsity, it might well behoove anybody who wanted to get clear about what the good answers are to investigate the relevant scientific inquiries assiduously. This proposal, which Hacker identifies as Quinian naturalism, he dismisses with an irrelevancy: “we do not think that empirical research can solve any philosophical problems, any more than it can solve problems in mathematics.” (B&H;, p414) Well of course not; empirical research doesn’t solve them, it informs them and sometimes adjusts or revises them, and then they sometimes dissolve, and sometimes they can then be solved by further philosophical reflection. Hacker’s insistence that philosophy is an a priori discipline that has no continuity with empirical science is the chief source of the problems bedeviling this project” (Comment, p. 7).
La grammatica a cui Hacker tenterebbe di fissare l’autonomia non riducibile della “filosofia prima” (secondo un’attitudine che non nasce a Oxford, e in questo concordano Hacker e Dennett, ma con Socrate) non starebbe però in piedi per Dennett: “The conviction that this method of consulting one’s (grammatical or other) intuitions is entirely distinct from empirical inquiry has a long pedigree (going back not just to the Oxford of the 1960s, but to Socrates) but it does not survive reflection.” (Comment, p. 8). L’attacco di Dennett, che coinvolge anche il suo maestro Ryle, è frontale, ed è in sostanza l’attacco al paradigma della svolta linguistica che ha dominato la filosofia del dopoguerra fino all’avvento della svolta naturalistico-mentalistico-biologistica, se così si può dire, verso cui autori come Dennett e Searle (ma non Hacker), seppur in forme tra di loro antagoniste, hanno fatto decisamente rotta (5) : “It is long past time to call a halt to this sort of philosophical pretense” - scrive Dennett. “Ryle notoriously claimed to identify ‘category mistakes’ by appeal to the ‘logic’ of existence claims, but let’s face it: that was a bluff. He had no articulated logic of existence terms to back up his claims. In spite of the popularity of such talk, from Ryle and Wittgenstein and a host of imitators, no philosopher has ever articulated ‘the rules’ for the use of any ordinary expression.” (p.9). Per concludere perentoriamente con una campana a morto per la buona vecchia Linguistic Turn che rivela quanto sia oggi ampia la scissione dentro il campo che proviene dal mondo analitico: “Since Hacker’s philosophical problems are becoming obsolete, I suppose we might just sweep them under the carpet, though I’d prefer to give them a proper burial.” (p. 13).
___________________________________
Note
(1) M. De Carolis, La vita nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Bollati Boringhieri, Torino 2004
(2)Tecnologie che concorrono a determinare, come è stato ben scritto, una vera e propria “modifica profonda della figurabilità dello spazio antropico” (C. Ossola, Relazione di C. Ossola al convegno “Humanitas. Il paradigma di natura umana tra scienza e filosofia” organizzato da CNR e Istituto italiano di scienze umane, Firenze, luglio 2004).
(3) Tuttavia, per una interpretazione meno rigida della tesi di Wittgenstein e per una comprensione della Fallacia mereologica in termini di – del tutto legittima! – metonimia, si veda la recensione critica al volume di Bennett & Hacker avanzata da P. Machamer & J. Sytsma, “Neuroscienze e natura della filosofia”, Iride, XVIII, n. 46, pp. 495-514
(4) Vedi ad esempio le considerazioni nell’Introduzione e nel saggio di F. D’Agostini, “Che cos’è la Filosofia analitica?”, in Storia della Filosofia analitica, a cura di F. D’Agostini e N. Vassallo, Einaudi, Torino 2002
(5) Anzi Searle in un certo senso rappresenta un’evoluzione ancora più marcata da un paradigma linguistico a uno che vede nella biologia il fondamento ultimo, anche del linguaggio. Si veda il suo recente intervento per il conseguimento del Premio Mente e Cervello, edizione 2006, all’Università di Torino: “trovo grave che i filosofi del linguaggio non considerino il linguaggio come un fenomeno naturale (…) è raro che trattino il proprio oggetto come un’estensione naturale di capacità biologiche non linguistiche, di un’eredità biologica specificamente umana.” Analogamente nel suo ultimo lavoro La mente aveva parlato dei problemi del linguaggio come “casi speciali dei problemi relativi alla mente. Il nostro uso del linguaggio è l’espressione di capacità mentali più fondamentali dal punto di vista biologico” (J. Searle, La mente, Cortina, Milano 2005, pp. 10-11)